
Marco Aru
LA PRIMA VOLTA CHE VIDI MARTA
A tutti quelli che
rompono gli specchi
NARCISO E GLI ALTRI
I.
E' vero, la nostra delusione non può che essere il resto dell'illusione che ci siamo creata quando al Banco degli Amori siamo andati ad acquistare fantasie da consumare la sera, a letto o spiando il mondo da dietro il vetro appannato della nostra finestra. Ma l'amore è spesso simile a quell'ipotetico scrittore di cui riferì Nietzsche, la cui arte non era fatta necessariamente per essere capita, anzi, era sovente il contrario. Un Amore pare più vero se agli occhi degli altri risulta incomprensibile.
La prima volta che vidi Marta credetti di trovarmi di fronte a Narciso in persona, alla materializzazione dell’archetipo moderno della Vanità. Fu la sera in cui festeggiavamo il mio ventunesimo compleanno, e come succede spesso a chi proprio non sa che fare, eravamo andati a mangiare fuori. C'era tutto il gruppo. Fin dal giorno prima avevo nutrito la falsa consapevolezza che in quella serata avrei potuto fare ciò che volevo. Così, in modo più che scontato, finimmo per ubriacarci ed attirare su di noi l'attenzione di tutto il locale.
In quel tempo eravamo ancora sconosciuti, e nessuno di noi avrebbe anche solo osato sperare che da lì a qualche anno saremmo diventati delle celebrità.
Suonavamo in due locali, e il Martedì sera anche in una discoteca dell'entroterra ligure. Erano di quei locali moderni, una via di mezzo fra una birreria tedesca e un “club privè” per scambisti. Accanto a tavolini rotondi a tre piedi, uguali a quelli dei bar, ce n'erano altri di legno, più lunghi, sporchi e col piano disegnato o firmato dagli avventori. C'erano sedie di plastica, di quelle “paghi uno prendi quattro”, e divani nei quali ragazze emancipate si facevano settimanalmente maneggiare da amicizie improvvisate o da improvvisati e poco noti amanti. La luce soffusa delle lampade orrende opprimeva i visitatori, elargendo a piene mani claustrofobiche timidezze. Le tende illanguidivano ignare il volto dei frequentatori, ed evocavano, come stanche sirene ammalianti, situazioni intime poco adatte alle serate in questione, che negli intenti volevano solo essere istanti spensierati e giocondi.
I tizi che li frequentavano appartenevano a classi diverse.
C'erano gli agiati, che varcavano la soglia con espressioni di sufficienza, e gli operai, che non vedevano l'ora di spendere il sempre insufficiente stipendio in qualcosa che permettesse, la settimana successiva, di sprecarsi in narrative boccaccesche da raccontare a quegli amici che, meno fortunati, erano disoccupati o occupati con mogli e fidanzate. C'era chi veniva nei locali usando un paio d'ore come antefatto ad una più spericolata ed emozionante serata, e chi entrava per passarci tutta la notte uscendo la mattina col portafogli vuoto e le speranze intatte.
Altri venivano per ubriacarsi e far risse, alcuni per sfogare la loro musicomania, e altri ancora usufruivano del locale come scusa da propinare alle ragazze che accompagnavano, alle quali non potevano rivelare le loro sessuali premeditazioni.
L'età media era intorno ai diciotto, ma durante la settimana, portando a spasso le loro menopausaiche frustrazioni, anche le donne adulte venivano a trovarci.
Noi vivevamo tutto questo con la falsa consapevolezza, che in molti era più speranza, d'esserne i protagonisti. Il nostro repertorio era limitato a canzoni di successo, futili esibizioni che non impressionavano più di tanto. Eravamo pagati poche migliaia di lire, ma tutto sommato non credo meritassimo di più. Naturalmente allora la maggior parte di noi erano convinti di essere degli artisti. Io non lo sono mai stato, e tantomeno in quel tempo. Mi succedeva che quan-do guardavo il gruppo, vedevo in noi quei bambini che in piazzetta giocano a pallone facendosi la telecronaca. E poi non mi piaceva dover subire generi musicali che non mi si addicevano per nulla.
Il problema era che di noi cinque soltanto io e Maurizio, il tastie-rista, appassionato lettore della Bibbia, suonavamo per amore della musica. Gli altri, Alessandro, Enzo e Giacomo, lo facevano per molteplici ragioni fra le quali non rientrava certo quella artistica. C'era chi voleva far colpo sulle ragazze, chi voleva ubriacarsi gratuitamente, e chi, sempre attento agli strani sconvolgimenti del tempo, non aspettava altro di aver la possibilità per far parte a pieno titolo della società, magari senza troppa fatica, trovandosi un lavoro fisso che lasciasse energie e tempo per il divertimento. Da tale miseria poco sollecitato, l'ultima cosa a cui pensavo di aver a che fare era proprio l'Arte.
Ho sempre creduto che l'Arte sia creazione, ma che se in questa vi è vanità si finisce per ridurla soltanto a squallida mondanità, facendola diventare non altro che un'occasione per sfoggiarsi o cadere nell'opportunismo. L'opportunismo era sfruttare l'ignoranza musicale degli avventori, che i miei compagni si sceglievano accuratamente per sentirsi qualcuno, persone ansiose di farsi “considerare” da chi, come noi, era al centro della scena. Lo sfoggio, invece, per quanto io sia consapevole del fatto ch'esso sia difficilmente descrivibile, è il tema di questo libro.
E' strano come molto spesso siano proprio i polli ad agognare il contorno di patatine, per altro molto più vive di loro. E comunque, quei cari fottutissimi miei amici, i polli, probabilmente non si rendevano conto di essere loro per primi oggetto di sfottò. M'irritava vederli cercare la compagnia di quelli che si definivano “nostri fans”, perché mi rendevo conto che chi ci vedeva da fuori e non apparteneva a quella schiera di “conniventi della nostra vanità”, considerava tutto quel canovaccio, quella recita a soggetto, solo un bisogno d'affetto, una carenza edipica di cui m'infastidiva l'esserne conscio.
Oggi, ricordando, credo che fossimo tutti allo stesso livello, musicisti e spettatori. Anzi, qualche volta, anche se assai raramente, erano proprio gli spettatori ad essere più interessanti di noi.
Quello che più mi colpì di Marta quella sera, fu il suo modo di camminare. Nonostante, probabilmente, fosse stato messo a punto, studiato per affascinare, e quindi aveva in sé quel genere di vanità furba che più di ogni altro tipo di vanità mi sta sullo stomaco, ostentava comunque qualcosa di veramente originale.
Non era un modo di camminare barcollante, non era sceccherato, non volgarmente sculettante e neppure pomposamente snobistico. Somigliava, se visto da vicino e assaporato nei particolari, al passo di quella studentessa in Legge giunta all'ultimo esame, ma anche in questo non completamente. I tacchi pareva non toccassero terra, e le punte sembravano impattare qualcosa d'incandescente; appena trovavano l'asfalto scappavano via. Le ginocchia, piegate quel minimo che basta per far sì che la gamba riesca a portarsi in avanti, non davano segno di vantarsene troppo, e i glutei, come se stessero lavorando in proprio, non avevano nessuna intenzione d'ubbidir a tutto l'apparato inferiore. Allontanandosi ribelli, sembravano strizzare l'occhio a chi li guardava. Non per questo mi parvero ruffiani o ammiccanti. Il corpo aveva un non so che di rigido, ma non franke-stianamente. Le braccia, accompagnando l'incedere delle gambe, davano l'impressione di cercare qualcosa d'invisibile nell'aria, ed erano in questo assecondate dal collo, che, con poca e cerimoniosa lena, si girava in modo cadenzato prima a sinistra e poi, dopo una breve pausa, a destra. I capelli di Marta, lunghi e neri, si muovevano come un sipario impazzito.
La guardai, nel suo vestito rosso Inferno, e nella sua femminilità mascolina scorsi l'ingenua certezza che l'uomo giusto prima o poi arriverà. L'espressione melliflua della sua faccia era certamente l'esteriorità di quell’illusione adolescenziale secondo cui ad ogni angolo di strada possa celarsi un poco probabile Principe Azzurro, che col suo inverosimile Cavallo Bianco, galoppando, passasse a rapirla per portarla in un non molto credibile Castello Incantato, dove l'avrebbe saziata di un Amore Impossibile. Sorrisi pensando che nei sogni moderni della Bella Addormentata nel Bosco non v'è alcun senso della precarietà di tali desideri, e la certezza che tutto immancabilmente avverrà è solida come un muro di cemento armato.
Chissà, forse erano solo movenze da “teatro di posa”, un’interpretazione articolare studiata per l'occasione, “Passeggiata fra i tavoli al Ristorante”, ma guardando quella sorta di coreografia pensai subito che una ragazza del genere non mi sarebbe mai piaciuta.
Quando si avvicinò al nostro tavolo per salutare Alessandro che conosceva da parecchio tempo, vidi nel suo sguardo la sicurezza di appartenere ad una razza diversa. Sprizzava mascolinità da ogni poro della pelle, tanto che mi fece sorgere la curiosità di domandarmi se per caso non mi trovassi davanti ad una femminista, dura, spietata, sicura al di là delle apparenze, e anche un po’ lesbica. Una femminista non di quelle moderne, dunque, ma piuttosto una suffragetta inglese del diciannovesimo secolo, di quelle serie, che combattevano per convinzione e non per “convenzione”.
Ma era solo una prima occhiata. In realtà mi accorsi quella sera stessa che mi stavo sbagliando. Il mio giudizio presumibilmente fu annebbiato dalle sue movenze cordiali, dalla sua voce “trillata”, da campanello, perfino quando parlava tenendo il volume basso.
Tuttavia non la considerai cattiva.
In quel tempo, come tutti i ventenni lessi nelle proprie stupide convinzioni, mi chiedevo se non ci fossero alternative a questa democrazia. Si sa, a ventanni ci si sente così ingenuamente vivi da convincersi che i propri deliri siano cose sensate, e che le proprie scoperte possano essere una svolta decisiva per il mondo intero. Si è stupidi, a ventanni.
La ricerca della felicità era una priorità comunque boicottata dalla mia volontà, e si risolveva tutta nella speranza di essere amato. La Politica era stata da me precocemente abbandonata. Avevo soffocato la speranza nel voto, ero immune da colpe.
Malgrado questo, però, non sentivo come una grave disgrazia il fatto di essere un disilluso. Alcuni anni prima ero stato fermamente convinto che la musica potesse cambiare qualcosa, e mi sbattevo perché la voce di quelli che io ritenevo dei veri combattenti, le rock stars mondiali, non restasse inascoltata. Ma con gli anni sia i gusti che le convinzioni cambiano, e oggi sono talmente disilluso da poter affermare di essermi riappropriato della mia vita.
Ciò che una volta mi sconvolgeva (le immagini dei morti, degli affamati, dei malati, dei disoccupati, dei disgraziati in genere) non fa più presa su di me, sul mio corpo. Sono riuscito a persuadermi che rovesciare governi dittatoriali con “un giro di DO” sia quantomeno grottesco. Per questo mi sento meglio. Lo vediamo tutti i giorni, i musicisti che fanno solidarietà o promuovono contributi e raccolte di denaro, lo fanno solo per pubblicizzare il loro ultimo disco o per dire quando partirà la prossima turnè. Sting, Bono Vox e Peter Gabriel, a forza di cuocersi nel loro “altruismo umanitario”, hanno finito per compiacersi a tal punto da risultarne “scotti”. Più egoisti dovremmo essere, solo così riusciremmo davvero a fare del bene.
Oggi penso che nulla può essere più ributtante, ma allora ci credevo, ci credevo eccome! Allora mi arrabbiavo tantissimo coi miei compagni, quelli del gruppo, perché vedevo che non s'interessavano alle disgrazie planetarie, ciò che invece angosciava il mio cuore. Non sapevo darmi una risposta al loro menefreghismo e chiedevo:
- Ma la situazione in Sud Africa non vi sconvolge abbastanza?
Qualcuno rispondeva di sì, ma era solo un modo per chiudere il discorso. Infatti non c'era niente di più smodatamente superficiale di quei miei compagni. Avrei dovuto capire qualcosa già da allora.
Per fortuna oggi sono cambiato, sono maturato, e ho compreso che nulla è più falso di chi è sempre pronto a dare ragione a tutti.
Gli uomini che mai mi hanno ispirato fiducia sono proprio quelli che, smaniosi, cercano ogni pretesto per darci ragione, sono quelli che dopo aver fatto un'affermazione inequivocabile cercano di dirottarla verso la nostra insindacabile opinione (che tale è e tale resta, un’opinione), tentando esasperatamente di ricomporre i contrasti e insinuando, con tale comportamento, la nostra uguaglianza, finendo, invece, per risultare uomini insulsi e senza costrutto. Che fastidio, questo genere di tolleranza ad ogni costo, che rasenta la lusinga, che si presta così facilmente e così palesemente ad essere conquistata senza colpo ferire alla nostra causa, al nostro pensiero.
Quando questo succede mi sento come uno di quei cecchini che credendo di avere una mira infallibile, davanti al bersaglio che scappa si dicono: “Corri veloce che muori stanco”.
Non ho mai amato le armi e tantomeno sparare. Per fare tacche sul calcio del nostro fucile non serve avere una buona mira, ma un ottimo coltello.
Dopo quella sera ero convinto che non avrei più rivisto Marta in vita mia. Anche perché, persuasi e convinti da quell'ubriachezza molesta che fa scappar via le persone, molti di noi, me compreso, cominciarono a fare pesanti apprezzamenti di carattere genital-anatomico.
Ricordo che lei era con un paio di amici. Come mi disse qualche tempo dopo, erano una ragazza e un ragazzo che stavano insieme e che quella sera avevano litigato. Marta, in quel ristorante, stava tentando di ricomporre i contrasti........….………….
Pensandoci meglio mi ricredetti, e, cambiando risposta sulla “di lei persona”, mi parve di riconoscere nel suo passo sicuro il prototipo di certe suffragette moderne, che hanno fatto della “Psicologia Freudiana” una sorta di manuale per incolti alle prime armi, e che sono talmente abituate ad applicare agli uomini che le snobbano quella specie di acronimo, il C.D.M., o “Complesso della Mamma”, col quale sono solite giustificare il rifiuto da parte nostra dei loro capricci, da convincersi che il maschilismo sia una cosa vera.
Io, che a ventunanni suonati avevo ormai dimenticato gli “adolescenzial tenzoni” fatti di sfide di genitali, non le diedi troppa importanza.
Le poche parole che scambiò con Alessandro non rivelarono molto di lei, ma fecero in modo che ai miei occhi risultasse la solita ragazza che, sicura d'esser bella, finge con non curanza di non atteggiarsi, cascando, a sua insaputa, in quel vortice vanitoso proprio del bagaglio culturale di certe deboli donne che non hanno la forza per tenersene alla larga.
Quando si avvicinò alla porta e l'aprì per far uscire i suoi due amici, voltandosi mi fissò impietosamente, malcelando una di quelle smorfie che ti fanno capire “quanto sei stato stupido stasera”. Io non mi preoccupai più di tanto. Era solo la conoscente di un mio amico che si era svogliatamente presentata, e credevo che quella stretta di mano sarebbe rimasta l'unica cosa che avremmo mai condiviso in vita nostra.
E' superfluo dire che naturalmente mi sbagliavo.
II.
Non si diventa vanitosi per gli stessi motivi. C'è chi lo è diventato perché ha preso gli stessi vizi della sua famiglia, e chi, nel corso del processo ontogenetico, è stato subissato dai complimenti. C'è chi a scuola sapeva tutto e stupide insegnanti, innalzandolo al ruolo avventizio di Professore, glielo ha fatto dire ai suoi compagni, e chi, essendo bello davvero, lo è diventato davanti allo specchio. C'è chi lo è per ricchezza, chi per saccenza, per ostentazione, per desiderio, per difendersi dal sesso opposto, e addirittura chi lo è per frustrazione.
Gli artisti lo sono perché sono artisti.
La vanità dell'artista è la convinzione, senza ritorno, di essere originale. Tanto basta, a chi non ha mai avuto niente, per sentirsi unico nell'Universo movimentato.
Quest'autosublimazione finisce di solito per risolversi tutta in un comportamento sufficiente che fa prudere le mani. Sì, perché chi si crede artista senza esserlo è più vanitoso di chi lo è davvero, e la sua vanità infastidisce i suoi amici, che, per quanto scrutino, non né vedono né ne capiscono le ragioni.
Un “auto-artista” non è mai conscio del suo essere comico.
L'autoreferenza di chi si battezza da solo, mi ricorda quei quindi-cenni che chiusi nel bagno della loro casa si sfracellano di pippe almanaccando improbabili storie d'amore con ragazze bellissime; la loro autosufficienza è certamente masturbazione.
Un produttore che conobbi parecchi anni dopo il periodo di tempo che sto narrando, mi disse: “L'Artista è Colui che non si rende conto di esserlo”.
Se proprio non riusciamo a reprimere la tentazione di guardarci allo specchio, quando lo facciamo dovremmo scrutarci in maniera più profonda. Non per narcisismo, ma per renderci conto se ci riesce di capire come ci vediamo, se belli o brutti. L'artista che si trova anche bello è irrecuperabile; quello che si vede brutto è umile, e si può ancora salvare; colui che non riesce a giudicarsi forse ha qualche possibilità di diventare un artista, e dovrebbe lasciar perdere gli specchi, cani ben addestrati che per quanto scuotano la nostra immagine e la portino in giro scodinzolando e sbavandoci sopra, ogni volta ce la rimetteranno lì sempre ingiudicabile. Meglio non perder tempo con gli specchi, dunque, perché essi non possono mostrarci come saremo fra cinquantanni, e se la vita è solo narrazione, solo una concatenazione di gesti mitico-simbolici che noi, di volta in volta, agogniamo rivalutare quand’essi diventano passato, non esiste niente di più inutile del presente, e non riesco ad immaginare nulla che simbolizzi così bene il presente come fa uno specchio.
Tutti gli artisti vorrebbero essere come Salinger, ma sotto sotto bra-mano la popolarità, essere ricercati, intervistati, ripresi da una telecamera, anche solo per ribellarsi alla “violazione della loro privacy”, per mostrare di rifiutare la fama, disprezzare sovranamente la celebrità, magari quella stessa celebrità che è stata il vero motivo, l'unica spinta per cui hanno iniziato a creare.
Gli uomini d'oggi sono come cani che abbaiano alla Luna, che non sono in grado di far del male a qualcuno, che corrono dietro la “dèa cagna” del successo, di cui parlava Henry James, per raggiungerlo e aver più possibilità con le donne, senza capire che poi saranno proprio loro a spogliarli di quegli orpelli con cui la celebrità ha rivestito i più fortunati.
E noi così eravamo. Nulla tenenti passavamo le giornate a provare. Io non capivo il perché di tutte quelle “prove”, facevamo sempre gli stessi pezzi! Ma quando lo chiedevo a Maurizio, il ragazzo con cui andavo più d'accordo, lui mi rispondeva:
- Vedrai che a furia di provarci prima o poi ci si riesce. - e rideva come un povero demente.
Maurizio era uno dei pochi motivi per cui continuavo ancora a suonare nel gruppo. Spesso ci perdevamo in camera sua a leggere e fare considerazioni sulla Bibbia, e lui era assai bravo ad estrapolare concetti originali chiari e indefettibili, anche se ho capito da tempo che i sillogismi producono somme il cui risultato non serve mai a nessuno.
Gli altri del gruppo non mi erano particolarmente simpatici. Prendevano tutto come se fosse una fase cruciale. Io non ero così e loro se ne accorgevano. Mi sembrava un comportamento stupido.
“Passiamo la vita a tentare di non prenderci troppo sul serio”, pensavo, “e questi vogliono prendere seriamente un divertimento come la musica!” Questo mio lassismo veniva spesso rimproverato.
- Guarda che il riff è in sol non in si minore. - mi diceva Alessandro - Gianni, se non ne hai voglia te ne puoi pure andare.
Era vero, ma ciò che facevamo era per me più un gioco che qualcosa di serio. E poi l'Arte dovrebbe essere un effetto scatenato dalla causa della passione, anche se questi nostri Tempi han tutta l'aria di voler asserire il contrario. Il professionismo musicale è divismo non passione, ed oggi è facilmente imputabile di “falso ideologico”.
Io difendevo le mie convinzioni come meglio potevo.
- “Non posso pretendere che tutti abbiano le mie virtù. E' già tanto se trovo in essi i miei vizi”. Sai chi lo ha scritto? – chiedevo ad Alessandro, che aveva la stessa cultura di un giocatore di calcio, per mitigare l'evidenza della mia poca lena e arginare il mio torto - Andrè Gide.
Quando eravamo in sala a provare, come tutti i novelli gruppi musicali che si rispettino, avevamo l'inclinazione a suonare solo i pezzi che ci piacevano. Era una dolce consolazione, perché quando in-vece suonavamo nei locali dovevamo per forza di cose accontentare chi ci veniva a sentire, quindi suonare quella musica che io definivo, e definisco, “robaccia”: Queen, Beatles, musica da classifiche o da discoteca, in pratica niente di più noioso, semplice e scontato.
Naturalmente è un mio parere, e si sa che i pareri sono come i problemi, ognuno ha i suoi. Il mio punto di vista sulla musica era diverso da quello dei miei compagni, ai quali bastava rifare canzoni datate per sentirsi qualcuno. Ci voleva una bella faccia di bronzo a spacciarsi per artisti. Dei juke box eravamo, altro che arte!
Purtroppo per entrare nelle grazie di qualcuno non basta essere delle “cime”, ma bisogna esserlo nel campo che quel qualcuno predilige. Gli avventori dei locali nei quali suonavamo non erano degli esperti di musica, e per quanto tecnicamente bravi fossimo, loro ci ritenevano tali solo quando facevamo musica che conoscevano, cioè, la già citata “robaccia”.
A me e a Maurizio piacevano i Genesis vecchi, quelli con Peter Gabriel e Steve Hackett, e il rock progressivo degli anni settanta. Zappa e Pat Metheny, il jazz, Ellington, Porter, Coltrane, Monk, Powell, Tatum, Mingus, Gillespie, Davis, la fushion e la classica. Tutt'al più potevamo suonare della new age, ma anche lì si godeva poco. Il guaio era che nei locali dove suonavamo ci veniva gente che voleva divertirsi facendo casino, ubriacandosi, al massimo sfoderando saccenza musicale sui pezzi che facevamo (capirai!) per ammaliare qualche ragazza, e i nostri gusti ogni volta venivano frustrati.
Comunque non era così per tutto il gruppo. Gli altri ben sopportavano Freddy Mercury, soprattutto il cantante, Alessandro, che poteva dar sfoggio ai suoi urlacci e a tutta la sua megalomania celandola dietro l'interpretazione di quei pezzi e di quel personaggio.
Ma era inevitabile. Se ti vendi, o meglio, se vendi quel genere di musica, altro non ti può succedere che subirne la classificazione. Così accadeva che durante il giorno, in sala, alle prove, suonavamo jazz e musica impegnativa, e alla sera, nei locali, ci castravamo obbligandoci ad abbagliare gli spettatori con quel genere di musica furba che non impressiona più di tanto i musicologi navigati.
Quello che m'innervosiva era che da chi se ne capiva eravamo con-siderati delle “bagasce”, dei ruffiani, e che quando ci pensavo seriamente non potevo che dar loro ragione. Eravamo proprio dei polli che s'illudevano di poter convincere la gente a definirci “artisti”. Davanti ai nostri “contorni di patate” sfoggiavamo le nostre più abominevoli stranezze spacciandole per originalità. In realtà, seppur col nostro lottare, non riuscivamo a convincere coloro che ci sfottevano d'essere in grado di suonare altra “roba”. E' certo, in quell'ambiente, fra noi e i “contorni”, il pubblico sì più affezionato, ma anche, data la nostra condizione di “cattivi professori”, più ignorante, non erano sicuramente loro ad essere più soggetti a manipolazioni.
Sovente mi chiedevo perché continuassi a fare quel tipo di vita che non mi appagava per niente. C'erano alcune ragioni per questo, ma per lo più erano ignobili scuse. La verità era che quella specie di mestiere mi permetteva di vivere lontano da quello che oggi è battezzato “lavoro usurante”, e solo tale fatto bastava per farmi, e farci, illudere d'essere di una razza superiore.
Sì, oggi credo fermamente di essere stato soltanto un povero illuso. Mi convincevo a perder tempo in quelle serate mondane che, mentre ricaricavo gli strumenti nel furgone, mi facevano penare pen-sando a quanto poco adatto fossi alla vita vera.
Il motivo di questo comportamento era la certezza, aggrappata al cuore di ciascuno di noi con le unghia e con i denti, che fare quella vita stravagante ci trasformasse in persone originali. La verità era che quella vita non poteva darci nulla, oltre le centomila giornaliere. Neppure la soddisfazione artistica poteva essere un valido motivo. Anche perché non suonando ciò che volevamo suonare, eravamo continuamente sottoposti ad una frustrazione di fondo che non ci lasciava il minimo spazio per godere, quelle poche volte che suc-cedeva, delle nostre capacità. Sapevo con certezza che tutto il divertimento stava nella stravaganza.
Divertimento! A me sembrava di stare in un cronicario a Natale, quando per un paio di giorni ci si dimentica della morte. E proprio la Morte era quel locale, che in fatto di cervelli somigliava molto ad una frammentaria esposizione pitecantropomorfa. Certo, c'erano alcuni ambiziosi “evoluzionisti” che asserivano di trovarsi in mezzo a qualcosa di molto simile alla vita, se non in un brodo organico almeno in uno vegetale, ma erano poco credibili. E se qualcosa di vero poteva esserci in quell'azzardata affermazione, quegli esseri viventi erano strutturati in maniera assai semplice, al massimo c'era qualche forma di vita unicellulare. Insomma, l'Homo Sapiens Sapiens probabilmente andava in un altro locale.
Sicuro, avete ragione, se era di Filosofia che avevo bisogno, come potevo pretendere di trovarla in un night club?
Per alcuni di noi c'era anche un'altra verità, sfruttata da me per tediarvi con questo libro.
Nell'andazzo che la vita ci propinava ogni sera, la musica c'entrava davvero poco. Suonare in quel locale era, sia per noi che per chi ci veniva a vedere, uno squallido balletto di presunzioni a cui ciascu-no si sottoponeva per bruciare vanità non troppo sopite. Quel locale era una grande Fiera nella quale tutti i presenti erano sia merce che clienti. Ci si andava per mettersi in mostra, per comprare o essere comprati. Poco importava se le storie tardavano a venire, vitale era partecipare a quel grande mercato dei volti, delle facce, delle personalità lavate e messe in bella mostra, dei vestiti sgargianti che venivano indossati per l'occasione, e, sempre per l'occasione, affannosamente ricercati.
La vanità nel vestirsi bene è la peggiore, perché ci si arroga un merito senza averne la ragione, se non quella, puerile, che possono avere certi vecchi riccastri, che pagando le “hostess” per portarsele a letto s'illudono di averne conquistata qualcuna.
L'incredibilità è che oggi l'Alta Moda viene definita, da chi ha bisogno di presenziare le sfilate per vendere la propria faccia, qualcosa di simile all'Arte. Che ridere! Vogliono spacciare la vanità per Arte. Ma l'Arte non ha né padroni né soggetti preferiti. Gli eventuali limiti di chi non ha la capacità per seguirla dovrebbero essere culturali, e non, com'è nel caso dell'Alta Moda, economici. I limiti economici sono qualcosa che ha a che fare col mero mercato, non con l'Arte. Certo, anche un Picasso pone visibili e non risibili limiti economici, ma questo discorso riguarda il possesso, non il goderne. Ciascuno di noi può leggere un libro, ascoltare della musica, visitare un sito archeologico o una pinacoteca, ciò che non si può dire per quanto riguarda partecipare, come pubblico, alle sfilate. Non ho mai sentito di un Valentino o di un Armani che hanno spedito un invito ad un operaio della Fiat o alla commessa di un panificio. Perché succede? Perché quello dell'Alta Moda è un microcosmo dentro il quale i parametri sono diversi da quelli del mondo, e farsi applaudire, o nel caso contrario fischiare, da qualcuno che non è del “nostro rango”, non è mai conveniente.
I complimenti e le lusinghe fanno breccia in noi se vengono da persone che c'interessano, altrimenti non li accusiamo neanche. Questo valeva anche per noi “del locale”.
Come mi fa sorridere, oggi che ci ripenso con animo distaccato, il feeling che si aveva col pubblico. Era uno scambio: tu suonavi e ne ricevevi indietro apprezzamenti, in applausi, certo, ma non solo. Gli sguardi lontani e fissi delle ragazze, i bicchieri offerti da perfetti sconosciuti, essere additati nei locali, nei tavoli, nei bar, nei ristoranti. Sicuro, solo perché suonavi uno strumento.
Non c'è da meravigliarsi di questo fatto. I fans di un artista, come scriveva Proust, non sono altri che individui desiderosi essi stessi d'essere artisti. Chi applaude ad un concerto o ad una rappresentazione teatrale in realtà applaude sé stesso. Perché è andato ad assistervi, perché nella bellezza della rappresentazione egli vede la sua saggezza d'intenditore, perché, parte della platea, egli si sente parte dello spettacolo, e perché, una volta uscito dal teatro, potrà raccontarlo.
Non vi è dunque motivo valido perché l'artista sia fiero del suo pubblico, perché nei loro sogni desti egli non vi rientra se non come figurante, e non solo egli come persona, ma finanche la sua arte, lo spettacolo che ha messo in scena. Ogni spettatore è convinto che lo spettacolo al quale assiste non avrebbe ragion d'essere, senza la sua presenza in platea.
Soltanto guardando quella vita dal di fuori mi resi conto d'essere vittima, e partecipe, seppur inconsapevole, di un narcisismo sfrenato. E con me tutto il gruppo. Non di quel tipo di narcisismo che aiuta a crescere, quello egoistico che ci fa guardare allo specchio la mattina e ci convince che dobbiamo migliorare, ma di quell'altro genere che è solo bieca a fastidiosa vanità.
L'attaccamento alla nostra immagine è un antico sentimento dal quale soltanto la vecchiaia ci può rinfrancare. Il piacere che traiamo dalle immagini è vacuo e futile. L'immagine funziona da ini-bitore della nostra fantasia. Mi fanno ridere quelli che scrivono libri traendoli da sceneggiati televisivi o da film! Cosa mi scrivi a fare un libro del genere se ho già visto il film? Quando lo leggerò non potrò far altro che dare ai visi dei personaggi quelli degli interpreti televisivi o cinematografici. Ma la Letteratura, come la vita, non è che un invito all’astrazione, proprio quel che l’immagine frustra. Se leggo “Madame Bovary” ho il diritto di raffigurarmela come voglio, vi pare? Ma se invece ho già precisi contorni della sua faccia quel libro ai mie occhi perde di valore, perché l'emozione di parteciparvi è limitata dall'immagine già vista. E poi, la bellezza dell'im-magine passa, mentre la manipolazione che di essa abbiamo operato nel nostro cervello è l'unica cosa che ci rimane viva dentro. La nostra ex ragazza è sempre più bella nei ricordi che nella realtà.
Per tale motivo la vanità dell'immagine è stupidità.
Per la stessa ragione sono arciconvinto che per noi uomini sia meglio prendere in moglie una donna intelligente. Per quanto brutta sia avremmo sempre davanti uno specchio in grado di farci sentire bene, a posto con noi stessi, e capace di farci crescere intellettualmente, potenza che la bellezza non ha. Sposare una bella donna senza calcolare la sua possibile stupidità, è come al ristorante ordinare uno di quei piatti francesi dalla forma curatissima ma che non si adattano al nostro palato. Certo, potremmo godere della sua bellezza anche se non abbiamo “ritorno”, ma a cinquanta o sessantanni chi ci ritroveremmo di fronte? Un'inconsapevole “anacoluta” per di più frustrata dalla vecchiaia.
Non c’è nulla da fare, alla bellezza ci si abitua, alla stupidità molto meno.
Oggi credo che un po’ eravamo così perché costretti da un pubblico che tutto ti trasmette tranne che i tuoi meriti tecnici. Questo fatto mi divenne sempre più chiaro quando, nelle poche pause che facevamo, avevi il tempo di sederti ad un tavolo per scambiare qualche chiacchiera. Là scoprii un aspetto dei nostri fans, fino a quel momento rimastomi oscuro, che un po’ mi inebetì.
La vanità femminile è attrice di diversi comportamenti.
Quando, stanco di vivere nella musica, suonarla e discuterne, mi riducevo a parlare d'altro, mi accorsi di una sfaccettatura vanitosa che mi costrinse a rivalutare i rapporti che fino ad allora avevo avuto col “gentil sesso”. E' strano, per esempio, come certe donne, appena si trovano davanti ad un uomo che non parli loro solo di stronzate, si convincano di essere corteggiate, e che l'individuo che hanno davanti voglia far colpo su di loro. Evidentemente hanno sempre avuto a che fare con una pochezza sorda che le ha convinte di quanto l'intellettualità sia solo un'arma diversa per corteggiare, usata da chi non è bello fisicamente. Anche questa è vanità.
Come è vanità un genere di trasposizione che un po’ tutte le donne mettono in atto quando si sentono attorniate dai maschi. Ci sei tu, in quel momento il ragazzo più carino fra quelli presenti. Poi entra il fusto di turno, audacemente inconsapevole nel rubarti la scena. Lei, allora, fissa lui. Ma lui non se la fila. Quindi, ignaro come l’ultimo che non sa, esce dal locale. Ed ecco che, un secondo dopo essere uscito, lei ritorna a “puntare te”, magari con più intensità di prima, sperando che tu non ti sia accorto del suo opportunismo o, diversamente, addirittura per farselo scusare.
Che miserie, ragazzi.
Questo genere di comportamenti mi convinceva sempre più del pragmatismo nichilista che aleggia in certi locali, dove si va solo per “beccare o per essere beccati”. Non sono mai stato così superficiale da godere di quelle cose. Il brodo dentro il quale ci si bolle non mi è mai piaciuto granché, per questo l'ho sempre lasciato agli altri.
I miei interessi svariavano in diverse discipline della vita, la musica era tanto per me, ma non era tutto, e uscire con una ragazza non era la mia priorità, anche se poi, gioco forza, lo diventerà. A me piaceva leggere, andare a teatro (anche se potevo farlo poco perché lavoravamo la sera), mi piaceva il mare, la pesca, la campagna, la montagna.......……...….…………….
Uscire con una ragazza significava anche dover rinunciare a quei pochi piaceri che potevo soddisfare.
I gusti, i piaceri, sono direttamente proporzionati, e proporzionabili, all'appagamento delle esigenze del nostro intelletto. Questo è rivelatore delle scelte che abbiamo fatto. Il nostro cervello è una scatola. Possiamo riempirla dando più importanza all'immagine o, viceversa, preferire l'intellettualità. Naturalmente, anche se non in modo completo, uno esclude l'altro. Il giorno è fatto di ventiquattro ore, e se pensiamo che circa una ventina se ne vanno fra mangiare, dormire e lavorare, le restanti quattro, o sei che siano, sono un ben misero spazio per appagare le nostre voglie e i nostri intenti. E se a questo aggiungiamo che il cervello, in fatto di priorità, è un meccanismo piramidale nel quale la cosa che consideriamo meno importante viene rigettata a favore di quella più importante ed urgente, abbiamo un quadro chiaro della situazione. Andiamo! Per discorrere di politica preferisco uno skin head nazista piuttosto che un assiduo frequentatore di discoteche! Per quanto integralista sia possiede comunque una visione della storia, mentre l'unica visione che possiede un discotecomane è quella stroboscopica! E poi, Einstein non era un fotomodello! E non completamente per colpa della natura! Certo, ci sono mannequin che hanno preso la Laurea, ma la cultura non è un castello di nozioni, è spiccata e opportuna capacità di critica, è saper usare le proprie capacità astrattive! Chi dedica troppo tempo a curare il fisico conclama la sua malattia cerebrale. Sicuro, un bel paio di tette sono più facili da esibire di un'elucubrazione Umanista o di una teoria filosofico-religiosa subordinazionista, così com'è più semplice nascondere la propria ignoranza escatologica piuttosto che le caviglie grosse o un molare cariato, ma allora credevo che tutto dovesse avere comunque un limite.
Oggi che sono cresciuto, mi sono convinto che un individuo bello d'aspetto non debba avere l'obbligatorietà d'essere anche intelligente (tant'è che quasi mai è così), perché spesso sarà proprio il suo fisico a fargli superare le difficoltà o a sollevarlo da un’impasse, fatto al quale chi si vede bello ( mai capito come facciano coloro che ci riescono) piano piano si abitua.
Fatta questa considerazione, la vanità che vedevo sfoggiarmi davanti agli occhi ogni sera non mi trasmetteva più fastidio ma noia. E ancor più mi annoiavano le lotte interne al gruppo, le discussioni per dibattere la bellezza o l'eleganza di alcune donne che venivano a sentirci (o a vederci?). Ogni volta era la stessa storia. Ognuno di noi credeva di essere l'oggetto del desiderio di quella o quell'altra ragazza. Anche se nessuno aveva il coraggio di prendersela apertamente, più che altro per vergogna, era chiaro che l'eventuale conquista di una ragazza da parte di uno del gruppo, se guardata dal lato opposto della medaglia, era lo smacco per chi da quella con-quista veniva escluso. Ciascuno di noi credeva di essere l'unico ad interessare le donne.
La situazione era molto simile a quella che c'è in Italia per quanto riguarda la cultura. Le strane ed eterne convinzioni.
La ragione per cui alcuni individui che leggono libri pensano di essere gli unici a farlo, è la convinzione, nutrita anche dalla disinformazione, di quanto poco si legga in questo paese. Questa con-vinzione è simile a quella che porta i padroni della stessa mentalità a credere di essere l'oggetto di culto della stragrande maggioranza d'individui che per strada si voltano per guardarli al loro passaggio. La loro vanità è la più comica. Li vedi, mentre camminano per le vie del centro, guardarsi il posteriore riflesso nelle vetrine dei negozi, attraversare la strada come fossero modelli in una passerella, e compiacersi appena si accorgono che una persona del sesso opposto li ha guardati. Non sanno che in realtà è qualcosa che succede a tutti, colti e ignoranti, laureati e analfabeti, virtuosi o noiosi che siano. Credono che il sapere si possa sfoggiare col passo dinocco-lato, con l'aggrottare le sopracciglia, o sfogliando un libro in mezzo alla strada, rischiando stupidamente di esser messi sotto da una macchina. E come mi fanno ridere quelli che leggono libri sugli autobus! La lettura di un libro è qualcosa di talmente intimo che leggerlo in pubblico è per me come masturbarmi davanti ad una platea gremita. Evidentemente quelli che lo fanno davanti agli altri non hanno alcuna inibizione perché ciò che stanno leggendo è in realtà l'ultima cosa di cui s'interessano in quel momento. Probabilmente lo fanno perché sono convinti di piacere, per questo.
In verità la cosa che meno influisce nei gusti delle persone è proprio ciò che si sa, la propria cultura. Nel nostro caso era quel che facevamo, la nostra musica. Non è strano che in questo paese sia ben un trentenne su quattro a leggere regolarmente libri, e che sia proprio lui a credere di essere l'unico a farlo. In realtà siamo milioni.
La vanità culturale è “saccenza”, quella dell'immagine “auto caricatura”.
Quelle che più frequentemente si prestano a cadere nel “tranello” della vanità intellettuale (sia come attrici che come spettatrici affa-scinate) sono le donne, che, letteralmente violentate da un atavico senso di colpa che le tradizioni letterarie le hanno tramandato e che le infetta con un idiota complesso d'inferiorità, finiscono per ostentare la loro saccenza per provare ad abbattere quel millenario luogo comune secondo il quale “una donna bella d'aspetto non può essere anche intelligente”. Ma la vanità, come il tabagismo nella denuncia dei redditi, non è deducibile dalla propria natura, e infatti una donna che ha studiato è assai più vanitosa di una donna ignorante, anche se entrambe, nel loro essere donne, conservano intatte, ciascuna con le proprie possibilità, le loro endemiche vanità.
Quando arrivi a renderti conto di tutto questo, incredibilmente, allora sei proprio tu a voler cambiare, come accadde a me ad un certo punto della mia vita.
Cominciai a farmi dei problemi anche solo a guardare certe donne. Mi preoccupavo di quanti anni potessero avere, e se erano troppo giovani cercavo di non farmi ammaliare dalla loro bellezza.
Sapevo che il problema era solo mio, nel senso che quel che pensavo delle donne non poteva né doveva essere generalizzato, ma in una cesta di mele chi saprà mai quale d'essa contiene il verme?
Certo, i comportamenti fin qui narrati erano propri soltanto di un certo tipo di donne futili, senza costrutto, allegrone anche nei sentimenti o nel modo di porsi, e che non era la normalità ma solo il risultato di una precisa maniera di vedere la vita, le cose, il divertimento, ma le altre, voglio dire, le “sane”, dov'erano?
A ciò c'è d'aggiungere che io sono sempre stato timido, e se questo mi tornò vantaggioso qualche tempo dopo, in quel periodo, anche se avevo una gran voglia di buttarmi, non sapevo proprio da dove cominciare. Certe volte m'illudevo che la mia sola presenza sarebbe bastata, ma questo accadeva solo quei giorni in cui ero ottimista e mi facevo pervadere dalla convinzione di piacere. Il più delle volte me ne stavo per conto mio, al bancone del bar, con un bel bicchiere davanti sperando che proprio da lui arrivasse lo stimolo per cui mi sarei deciso di rivolgere la parola all'improvvisato oggetto del mio desiderio. Ma il Negroni non era per nulla provvidenziale. Succe-deva, infatti, o che io lo finivo prima che la ragazza che da qualche tempo mi “puntavo” arrivasse, e allora l'esaltazione alcolica scendeva e mi ritrovavo a dormire sul bancone, o che non facessi in tempo ad ubriacarmi, e quindi a disinibirmi, prima che lei se ne fosse andata.
Quello che più mi fregava era l'incertezza di come avrei dovuto presentarmi. Dovevo continuare a fare il manichino chiuso dentro un'immaginaria vetrina, sperando di essere da lei desiderato come si desidera un cappotto, o, abbandonando ogni timidezza e ogni inibizione, rompendo gli indugi, facendo come fanno tutti i giovani della terra, andarmi a presentare?
Quest'idea, esacerbata dalla mia esitazione, mi sembrava troppo rivelatrice delle mie intenzioni.
Lentamente mi feci la convinzione che le donne fossero una “priorità convenzionale”, e che il “dovere” da parte nostra di corteggiarle fosse solo una specie di tradizione tramandataci da un ormai desueto senso di appartenenza.
Quante volte, guardando ragazze con minigonne eloquenti che sedute sopra ai tavolini si mettevano in mostra come il pesce nei banchi del mercato, ho pensato a come si potessero avere certe priorità! A come alcuni individui, irrimediabilmente innocui e giustamente esclusi, colpiti e affondati da quell'esibizioni di cosce nude, calze a rete, e mutandine scorte perfino senza farci caso, facessero dei locali notturni il centro gravitazionale della loro esistenza! La vita è qualcosa di più di un night club!
Il mio problema era che facevo parte integrante di quel mondo. Sicuro, non mi piaceva affatto, ma questo ero solo io a saperlo. Probabilmente avevo bisogno di qualcos'altro che non fosse così sfacciatamente allusivo e materiale. No, non mi va di parlare come un buddista o un democratico cristiano! O come quei proseliti della nuova religione new age che fanno largo uso di avverbi e ti torturano con “l'esteriormente” o il “positivamente”, e, se hai la sfortuna d'incontrarli in forma, perfino con “l'interiorità del nostro io”! Ciò che volevo risolvere era l'approccio a quel tipo di vita che era anche il mio lavoro. Lavoro per nulla ben remunerato, ma pur sempre lavoro. Volevo cercare un equilibrio fra quel che mi manteneva in vita e ciò che pensavo davvero.
Come dite? Non posso ridurre la vita delle donne ad un continuo meretricio? No, non intendo far questo, anzi, ho sempre ritenuto che nel considerare le persone dovremmo tralasciare le confutazioni sul sesso o sul loro partito politico. La mia ambizione, facilmente frustrabile, è quella di mettere a nudo le motivazioni che si possono avere per diventare vanitosi, e tentare di dimostrare che quel difetto non è qualcosa d'innocuo, tutt'altro! Per esempio, una piccola verità potrebbe essere che spesso si cade nella vanità senza neppure accorgersene.
Quando, mettendomi al di fuori, tentavo di scrutare le persone che “vegetavano” in quell'anfratto ipocrita di terra, mi rendevo conto di vivere effimeramente. Allora cresceva dentro di me un'inquietudine per la vita che mi lasciava ansioso e poco tranquillo. Spesso suona-vo meccanicamente, senza capire a quale pezzo stavo dando vita, in quale posto stavo, e per quanto tempo ancora avrei seguitato a trascinare quella schifosa e ibrida mia esistenza. Era come se fossi padrone di “due me stessi”, la “teoria dell'elastico”, ai quali alternativamente scioglievo la briglia a patto che portassero dietro quello che restava momentaneamente escluso. Il problema era che sentivo l'elastico sempre più tirato e quasi sul punto di spezzarsi. Quale delle due vite infine avrei scelto? E delle due personalità, qual era quella vera?
Mi chiedevo sempre più spesso perché mai mi ero ridotto a fare quella musica, a sostituire il mio vero animo con uno più disposto al compromesso, e che non lasciava spazio a ciò che io agognavo da tempo; essere vero. Se non negli scambi personali almeno nei gusti.
Perché facevamo le “puttane” in quel locale?
Suonavamo tutto ciò che ci chiedevano gli altri e che desse la possibilità al cantante, l'unico a non saper suonare altro che il fischietto, di mettersi in mostra con le sue movenze effeminate, ma non suonavamo mai quel che ci piaceva suonare, quel che volevamo. Fu allora che mi sorse dal cuore un'inquietante risposta; tutto era fatto per vanità. Del resto sogni e bisogni quasi mai vanno a braccetto.
Quando oggi rifletto, nella mia terrazza a Monterosso, mi chiedo se in realtà anche a me non piacesse fare quel genere di vita, esser guardato, portato sul palmo della mano solo perché suonavo la chitarra e, orrore!, sapevo fare la svisa di “Hotel California”, o perché i capelli lunghi mi donavano particolarmente.
Così presi a voler rifiutare, appositamente, ogni sorta di compiaci-mento che provavo, ed a sentirmi, quelle poche volte che non riuscivo a reprimerlo, niente di più di una merda, un megalomane, un vanitoso senza rimedio.
Fu in quel tempo che iniziai a nutrire un odio preciso per vanitosi e affini. Si sa, un vanitoso vede in un altro vanitoso la comicità del proprio “essere vanitoso”. Mi costrinsi a cambiare. L'esibizionismo non l'avrei più permesso a nessuno, e tantomeno al mio corpo. Mi giurai di non mettermi più a posto i capelli quando salivo sul palco o alla fine dei pezzi che suonavamo. Cancellai dal mio mimico repertorio quei gesti che non servono a nulla ma che sono delle vere e proprie calamite di “attenzioni altrui”; sbracciate larghe come le ansate di filo di una sarta, passi claudicanti, inutili verbosità, rotazioni volontariamente distratte di capo, plateali risate, etc. Presi a vestirmi in maniera assolutamente anonima, a fuggire gli specchi di cui il locale era colmo, e a non andare più ai tavoli di chi m'invitava per offrirmi da bere, e che in quel modo, sotto sotto, voleva solo appagare la sua vanità, privandolo dell'opportunità di dire: “Hai visto? Conosco il chitarrista!” Che meschinità!
Chissà quale insospettabile e incomprensibile gusto può esserci a vantarsi delle qualità altrui.
La “vanità di rimpallo” mi è ancora più fastidiosa di quella “dipendente”, che ha un padrone preciso. Mai capito quelle donne che si atteggiano perché stanno insieme ad un personaggio famoso. Come se avessero qualche merito! Il fatto di “farsi fottere” da chi ha una carica pubblica dev'essere un po’ come entrare in possesso di un “segreto di Stato”. Tutti vedono, scrutano, ma nessuno può sapere niente.
Molti dicono che dietro un uomo di successo c’è una donna che l’ha ispirato. Può anche essere vero, ma ciò che m’inquieta è che oggi la donna quasi mai si accontenta di stare dietro. La vanità non si appaga col silenzio.
Quelle “comparse travestite da prime attrici” mi fanno venire in mente certe bambine di terza elementare che, contrariamente a compagne in questo senso più sfortunate, hanno l'amichetta del cuore che gli rivela tutti quei segreti che le fanno sentire importanti e nelle condizioni di atteggiarsi: io so tutto e tu no.
La loro vanità va al di là di qualsiasi immaginabile ragione.
Fu in quel periodo che rividi Marta per la seconda volta.
La vanità dell'artista è la convinzione, senza ritorno, di essere originale. Tanto basta, a chi non ha mai avuto niente, per sentirsi unico nell'Universo movimentato.
Quest'autosublimazione finisce di solito per risolversi tutta in un comportamento sufficiente che fa prudere le mani. Sì, perché chi si crede artista senza esserlo è più vanitoso di chi lo è davvero, e la sua vanità infastidisce i suoi amici, che, per quanto scrutino, non né vedono né ne capiscono le ragioni.
Un “auto-artista” non è mai conscio del suo essere comico.
L'autoreferenza di chi si battezza da solo, mi ricorda quei quindi-cenni che chiusi nel bagno della loro casa si sfracellano di pippe almanaccando improbabili storie d'amore con ragazze bellissime; la loro autosufficienza è certamente masturbazione.
Un produttore che conobbi parecchi anni dopo il periodo di tempo che sto narrando, mi disse: “L'Artista è Colui che non si rende conto di esserlo”.
Se proprio non riusciamo a reprimere la tentazione di guardarci allo specchio, quando lo facciamo dovremmo scrutarci in maniera più profonda. Non per narcisismo, ma per renderci conto se ci riesce di capire come ci vediamo, se belli o brutti. L'artista che si trova anche bello è irrecuperabile; quello che si vede brutto è umile, e si può ancora salvare; colui che non riesce a giudicarsi forse ha qualche possibilità di diventare un artista, e dovrebbe lasciar perdere gli specchi, cani ben addestrati che per quanto scuotano la nostra immagine e la portino in giro scodinzolando e sbavandoci sopra, ogni volta ce la rimetteranno lì sempre ingiudicabile. Meglio non perder tempo con gli specchi, dunque, perché essi non possono mostrarci come saremo fra cinquantanni, e se la vita è solo narrazione, solo una concatenazione di gesti mitico-simbolici che noi, di volta in volta, agogniamo rivalutare quand’essi diventano passato, non esiste niente di più inutile del presente, e non riesco ad immaginare nulla che simbolizzi così bene il presente come fa uno specchio.
Tutti gli artisti vorrebbero essere come Salinger, ma sotto sotto bra-mano la popolarità, essere ricercati, intervistati, ripresi da una telecamera, anche solo per ribellarsi alla “violazione della loro privacy”, per mostrare di rifiutare la fama, disprezzare sovranamente la celebrità, magari quella stessa celebrità che è stata il vero motivo, l'unica spinta per cui hanno iniziato a creare.
Gli uomini d'oggi sono come cani che abbaiano alla Luna, che non sono in grado di far del male a qualcuno, che corrono dietro la “dèa cagna” del successo, di cui parlava Henry James, per raggiungerlo e aver più possibilità con le donne, senza capire che poi saranno proprio loro a spogliarli di quegli orpelli con cui la celebrità ha rivestito i più fortunati.
E noi così eravamo. Nulla tenenti passavamo le giornate a provare. Io non capivo il perché di tutte quelle “prove”, facevamo sempre gli stessi pezzi! Ma quando lo chiedevo a Maurizio, il ragazzo con cui andavo più d'accordo, lui mi rispondeva:
- Vedrai che a furia di provarci prima o poi ci si riesce. - e rideva come un povero demente.
Maurizio era uno dei pochi motivi per cui continuavo ancora a suonare nel gruppo. Spesso ci perdevamo in camera sua a leggere e fare considerazioni sulla Bibbia, e lui era assai bravo ad estrapolare concetti originali chiari e indefettibili, anche se ho capito da tempo che i sillogismi producono somme il cui risultato non serve mai a nessuno.
Gli altri del gruppo non mi erano particolarmente simpatici. Prendevano tutto come se fosse una fase cruciale. Io non ero così e loro se ne accorgevano. Mi sembrava un comportamento stupido.
“Passiamo la vita a tentare di non prenderci troppo sul serio”, pensavo, “e questi vogliono prendere seriamente un divertimento come la musica!” Questo mio lassismo veniva spesso rimproverato.
- Guarda che il riff è in sol non in si minore. - mi diceva Alessandro - Gianni, se non ne hai voglia te ne puoi pure andare.
Era vero, ma ciò che facevamo era per me più un gioco che qualcosa di serio. E poi l'Arte dovrebbe essere un effetto scatenato dalla causa della passione, anche se questi nostri Tempi han tutta l'aria di voler asserire il contrario. Il professionismo musicale è divismo non passione, ed oggi è facilmente imputabile di “falso ideologico”.
Io difendevo le mie convinzioni come meglio potevo.
- “Non posso pretendere che tutti abbiano le mie virtù. E' già tanto se trovo in essi i miei vizi”. Sai chi lo ha scritto? – chiedevo ad Alessandro, che aveva la stessa cultura di un giocatore di calcio, per mitigare l'evidenza della mia poca lena e arginare il mio torto - Andrè Gide.
Quando eravamo in sala a provare, come tutti i novelli gruppi musicali che si rispettino, avevamo l'inclinazione a suonare solo i pezzi che ci piacevano. Era una dolce consolazione, perché quando in-vece suonavamo nei locali dovevamo per forza di cose accontentare chi ci veniva a sentire, quindi suonare quella musica che io definivo, e definisco, “robaccia”: Queen, Beatles, musica da classifiche o da discoteca, in pratica niente di più noioso, semplice e scontato.
Naturalmente è un mio parere, e si sa che i pareri sono come i problemi, ognuno ha i suoi. Il mio punto di vista sulla musica era diverso da quello dei miei compagni, ai quali bastava rifare canzoni datate per sentirsi qualcuno. Ci voleva una bella faccia di bronzo a spacciarsi per artisti. Dei juke box eravamo, altro che arte!
Purtroppo per entrare nelle grazie di qualcuno non basta essere delle “cime”, ma bisogna esserlo nel campo che quel qualcuno predilige. Gli avventori dei locali nei quali suonavamo non erano degli esperti di musica, e per quanto tecnicamente bravi fossimo, loro ci ritenevano tali solo quando facevamo musica che conoscevano, cioè, la già citata “robaccia”.
A me e a Maurizio piacevano i Genesis vecchi, quelli con Peter Gabriel e Steve Hackett, e il rock progressivo degli anni settanta. Zappa e Pat Metheny, il jazz, Ellington, Porter, Coltrane, Monk, Powell, Tatum, Mingus, Gillespie, Davis, la fushion e la classica. Tutt'al più potevamo suonare della new age, ma anche lì si godeva poco. Il guaio era che nei locali dove suonavamo ci veniva gente che voleva divertirsi facendo casino, ubriacandosi, al massimo sfoderando saccenza musicale sui pezzi che facevamo (capirai!) per ammaliare qualche ragazza, e i nostri gusti ogni volta venivano frustrati.
Comunque non era così per tutto il gruppo. Gli altri ben sopportavano Freddy Mercury, soprattutto il cantante, Alessandro, che poteva dar sfoggio ai suoi urlacci e a tutta la sua megalomania celandola dietro l'interpretazione di quei pezzi e di quel personaggio.
Ma era inevitabile. Se ti vendi, o meglio, se vendi quel genere di musica, altro non ti può succedere che subirne la classificazione. Così accadeva che durante il giorno, in sala, alle prove, suonavamo jazz e musica impegnativa, e alla sera, nei locali, ci castravamo obbligandoci ad abbagliare gli spettatori con quel genere di musica furba che non impressiona più di tanto i musicologi navigati.
Quello che m'innervosiva era che da chi se ne capiva eravamo con-siderati delle “bagasce”, dei ruffiani, e che quando ci pensavo seriamente non potevo che dar loro ragione. Eravamo proprio dei polli che s'illudevano di poter convincere la gente a definirci “artisti”. Davanti ai nostri “contorni di patate” sfoggiavamo le nostre più abominevoli stranezze spacciandole per originalità. In realtà, seppur col nostro lottare, non riuscivamo a convincere coloro che ci sfottevano d'essere in grado di suonare altra “roba”. E' certo, in quell'ambiente, fra noi e i “contorni”, il pubblico sì più affezionato, ma anche, data la nostra condizione di “cattivi professori”, più ignorante, non erano sicuramente loro ad essere più soggetti a manipolazioni.
Sovente mi chiedevo perché continuassi a fare quel tipo di vita che non mi appagava per niente. C'erano alcune ragioni per questo, ma per lo più erano ignobili scuse. La verità era che quella specie di mestiere mi permetteva di vivere lontano da quello che oggi è battezzato “lavoro usurante”, e solo tale fatto bastava per farmi, e farci, illudere d'essere di una razza superiore.
Sì, oggi credo fermamente di essere stato soltanto un povero illuso. Mi convincevo a perder tempo in quelle serate mondane che, mentre ricaricavo gli strumenti nel furgone, mi facevano penare pen-sando a quanto poco adatto fossi alla vita vera.
Il motivo di questo comportamento era la certezza, aggrappata al cuore di ciascuno di noi con le unghia e con i denti, che fare quella vita stravagante ci trasformasse in persone originali. La verità era che quella vita non poteva darci nulla, oltre le centomila giornaliere. Neppure la soddisfazione artistica poteva essere un valido motivo. Anche perché non suonando ciò che volevamo suonare, eravamo continuamente sottoposti ad una frustrazione di fondo che non ci lasciava il minimo spazio per godere, quelle poche volte che suc-cedeva, delle nostre capacità. Sapevo con certezza che tutto il divertimento stava nella stravaganza.
Divertimento! A me sembrava di stare in un cronicario a Natale, quando per un paio di giorni ci si dimentica della morte. E proprio la Morte era quel locale, che in fatto di cervelli somigliava molto ad una frammentaria esposizione pitecantropomorfa. Certo, c'erano alcuni ambiziosi “evoluzionisti” che asserivano di trovarsi in mezzo a qualcosa di molto simile alla vita, se non in un brodo organico almeno in uno vegetale, ma erano poco credibili. E se qualcosa di vero poteva esserci in quell'azzardata affermazione, quegli esseri viventi erano strutturati in maniera assai semplice, al massimo c'era qualche forma di vita unicellulare. Insomma, l'Homo Sapiens Sapiens probabilmente andava in un altro locale.
Sicuro, avete ragione, se era di Filosofia che avevo bisogno, come potevo pretendere di trovarla in un night club?
Per alcuni di noi c'era anche un'altra verità, sfruttata da me per tediarvi con questo libro.
Nell'andazzo che la vita ci propinava ogni sera, la musica c'entrava davvero poco. Suonare in quel locale era, sia per noi che per chi ci veniva a vedere, uno squallido balletto di presunzioni a cui ciascu-no si sottoponeva per bruciare vanità non troppo sopite. Quel locale era una grande Fiera nella quale tutti i presenti erano sia merce che clienti. Ci si andava per mettersi in mostra, per comprare o essere comprati. Poco importava se le storie tardavano a venire, vitale era partecipare a quel grande mercato dei volti, delle facce, delle personalità lavate e messe in bella mostra, dei vestiti sgargianti che venivano indossati per l'occasione, e, sempre per l'occasione, affannosamente ricercati.
La vanità nel vestirsi bene è la peggiore, perché ci si arroga un merito senza averne la ragione, se non quella, puerile, che possono avere certi vecchi riccastri, che pagando le “hostess” per portarsele a letto s'illudono di averne conquistata qualcuna.
L'incredibilità è che oggi l'Alta Moda viene definita, da chi ha bisogno di presenziare le sfilate per vendere la propria faccia, qualcosa di simile all'Arte. Che ridere! Vogliono spacciare la vanità per Arte. Ma l'Arte non ha né padroni né soggetti preferiti. Gli eventuali limiti di chi non ha la capacità per seguirla dovrebbero essere culturali, e non, com'è nel caso dell'Alta Moda, economici. I limiti economici sono qualcosa che ha a che fare col mero mercato, non con l'Arte. Certo, anche un Picasso pone visibili e non risibili limiti economici, ma questo discorso riguarda il possesso, non il goderne. Ciascuno di noi può leggere un libro, ascoltare della musica, visitare un sito archeologico o una pinacoteca, ciò che non si può dire per quanto riguarda partecipare, come pubblico, alle sfilate. Non ho mai sentito di un Valentino o di un Armani che hanno spedito un invito ad un operaio della Fiat o alla commessa di un panificio. Perché succede? Perché quello dell'Alta Moda è un microcosmo dentro il quale i parametri sono diversi da quelli del mondo, e farsi applaudire, o nel caso contrario fischiare, da qualcuno che non è del “nostro rango”, non è mai conveniente.
I complimenti e le lusinghe fanno breccia in noi se vengono da persone che c'interessano, altrimenti non li accusiamo neanche. Questo valeva anche per noi “del locale”.
Come mi fa sorridere, oggi che ci ripenso con animo distaccato, il feeling che si aveva col pubblico. Era uno scambio: tu suonavi e ne ricevevi indietro apprezzamenti, in applausi, certo, ma non solo. Gli sguardi lontani e fissi delle ragazze, i bicchieri offerti da perfetti sconosciuti, essere additati nei locali, nei tavoli, nei bar, nei ristoranti. Sicuro, solo perché suonavi uno strumento.
Non c'è da meravigliarsi di questo fatto. I fans di un artista, come scriveva Proust, non sono altri che individui desiderosi essi stessi d'essere artisti. Chi applaude ad un concerto o ad una rappresentazione teatrale in realtà applaude sé stesso. Perché è andato ad assistervi, perché nella bellezza della rappresentazione egli vede la sua saggezza d'intenditore, perché, parte della platea, egli si sente parte dello spettacolo, e perché, una volta uscito dal teatro, potrà raccontarlo.
Non vi è dunque motivo valido perché l'artista sia fiero del suo pubblico, perché nei loro sogni desti egli non vi rientra se non come figurante, e non solo egli come persona, ma finanche la sua arte, lo spettacolo che ha messo in scena. Ogni spettatore è convinto che lo spettacolo al quale assiste non avrebbe ragion d'essere, senza la sua presenza in platea.
Soltanto guardando quella vita dal di fuori mi resi conto d'essere vittima, e partecipe, seppur inconsapevole, di un narcisismo sfrenato. E con me tutto il gruppo. Non di quel tipo di narcisismo che aiuta a crescere, quello egoistico che ci fa guardare allo specchio la mattina e ci convince che dobbiamo migliorare, ma di quell'altro genere che è solo bieca a fastidiosa vanità.
L'attaccamento alla nostra immagine è un antico sentimento dal quale soltanto la vecchiaia ci può rinfrancare. Il piacere che traiamo dalle immagini è vacuo e futile. L'immagine funziona da ini-bitore della nostra fantasia. Mi fanno ridere quelli che scrivono libri traendoli da sceneggiati televisivi o da film! Cosa mi scrivi a fare un libro del genere se ho già visto il film? Quando lo leggerò non potrò far altro che dare ai visi dei personaggi quelli degli interpreti televisivi o cinematografici. Ma la Letteratura, come la vita, non è che un invito all’astrazione, proprio quel che l’immagine frustra. Se leggo “Madame Bovary” ho il diritto di raffigurarmela come voglio, vi pare? Ma se invece ho già precisi contorni della sua faccia quel libro ai mie occhi perde di valore, perché l'emozione di parteciparvi è limitata dall'immagine già vista. E poi, la bellezza dell'im-magine passa, mentre la manipolazione che di essa abbiamo operato nel nostro cervello è l'unica cosa che ci rimane viva dentro. La nostra ex ragazza è sempre più bella nei ricordi che nella realtà.
Per tale motivo la vanità dell'immagine è stupidità.
Per la stessa ragione sono arciconvinto che per noi uomini sia meglio prendere in moglie una donna intelligente. Per quanto brutta sia avremmo sempre davanti uno specchio in grado di farci sentire bene, a posto con noi stessi, e capace di farci crescere intellettualmente, potenza che la bellezza non ha. Sposare una bella donna senza calcolare la sua possibile stupidità, è come al ristorante ordinare uno di quei piatti francesi dalla forma curatissima ma che non si adattano al nostro palato. Certo, potremmo godere della sua bellezza anche se non abbiamo “ritorno”, ma a cinquanta o sessantanni chi ci ritroveremmo di fronte? Un'inconsapevole “anacoluta” per di più frustrata dalla vecchiaia.
Non c’è nulla da fare, alla bellezza ci si abitua, alla stupidità molto meno.
Oggi credo che un po’ eravamo così perché costretti da un pubblico che tutto ti trasmette tranne che i tuoi meriti tecnici. Questo fatto mi divenne sempre più chiaro quando, nelle poche pause che facevamo, avevi il tempo di sederti ad un tavolo per scambiare qualche chiacchiera. Là scoprii un aspetto dei nostri fans, fino a quel momento rimastomi oscuro, che un po’ mi inebetì.
La vanità femminile è attrice di diversi comportamenti.
Quando, stanco di vivere nella musica, suonarla e discuterne, mi riducevo a parlare d'altro, mi accorsi di una sfaccettatura vanitosa che mi costrinse a rivalutare i rapporti che fino ad allora avevo avuto col “gentil sesso”. E' strano, per esempio, come certe donne, appena si trovano davanti ad un uomo che non parli loro solo di stronzate, si convincano di essere corteggiate, e che l'individuo che hanno davanti voglia far colpo su di loro. Evidentemente hanno sempre avuto a che fare con una pochezza sorda che le ha convinte di quanto l'intellettualità sia solo un'arma diversa per corteggiare, usata da chi non è bello fisicamente. Anche questa è vanità.
Come è vanità un genere di trasposizione che un po’ tutte le donne mettono in atto quando si sentono attorniate dai maschi. Ci sei tu, in quel momento il ragazzo più carino fra quelli presenti. Poi entra il fusto di turno, audacemente inconsapevole nel rubarti la scena. Lei, allora, fissa lui. Ma lui non se la fila. Quindi, ignaro come l’ultimo che non sa, esce dal locale. Ed ecco che, un secondo dopo essere uscito, lei ritorna a “puntare te”, magari con più intensità di prima, sperando che tu non ti sia accorto del suo opportunismo o, diversamente, addirittura per farselo scusare.
Che miserie, ragazzi.
Questo genere di comportamenti mi convinceva sempre più del pragmatismo nichilista che aleggia in certi locali, dove si va solo per “beccare o per essere beccati”. Non sono mai stato così superficiale da godere di quelle cose. Il brodo dentro il quale ci si bolle non mi è mai piaciuto granché, per questo l'ho sempre lasciato agli altri.
I miei interessi svariavano in diverse discipline della vita, la musica era tanto per me, ma non era tutto, e uscire con una ragazza non era la mia priorità, anche se poi, gioco forza, lo diventerà. A me piaceva leggere, andare a teatro (anche se potevo farlo poco perché lavoravamo la sera), mi piaceva il mare, la pesca, la campagna, la montagna.......……...….…………….
Uscire con una ragazza significava anche dover rinunciare a quei pochi piaceri che potevo soddisfare.
I gusti, i piaceri, sono direttamente proporzionati, e proporzionabili, all'appagamento delle esigenze del nostro intelletto. Questo è rivelatore delle scelte che abbiamo fatto. Il nostro cervello è una scatola. Possiamo riempirla dando più importanza all'immagine o, viceversa, preferire l'intellettualità. Naturalmente, anche se non in modo completo, uno esclude l'altro. Il giorno è fatto di ventiquattro ore, e se pensiamo che circa una ventina se ne vanno fra mangiare, dormire e lavorare, le restanti quattro, o sei che siano, sono un ben misero spazio per appagare le nostre voglie e i nostri intenti. E se a questo aggiungiamo che il cervello, in fatto di priorità, è un meccanismo piramidale nel quale la cosa che consideriamo meno importante viene rigettata a favore di quella più importante ed urgente, abbiamo un quadro chiaro della situazione. Andiamo! Per discorrere di politica preferisco uno skin head nazista piuttosto che un assiduo frequentatore di discoteche! Per quanto integralista sia possiede comunque una visione della storia, mentre l'unica visione che possiede un discotecomane è quella stroboscopica! E poi, Einstein non era un fotomodello! E non completamente per colpa della natura! Certo, ci sono mannequin che hanno preso la Laurea, ma la cultura non è un castello di nozioni, è spiccata e opportuna capacità di critica, è saper usare le proprie capacità astrattive! Chi dedica troppo tempo a curare il fisico conclama la sua malattia cerebrale. Sicuro, un bel paio di tette sono più facili da esibire di un'elucubrazione Umanista o di una teoria filosofico-religiosa subordinazionista, così com'è più semplice nascondere la propria ignoranza escatologica piuttosto che le caviglie grosse o un molare cariato, ma allora credevo che tutto dovesse avere comunque un limite.
Oggi che sono cresciuto, mi sono convinto che un individuo bello d'aspetto non debba avere l'obbligatorietà d'essere anche intelligente (tant'è che quasi mai è così), perché spesso sarà proprio il suo fisico a fargli superare le difficoltà o a sollevarlo da un’impasse, fatto al quale chi si vede bello ( mai capito come facciano coloro che ci riescono) piano piano si abitua.
Fatta questa considerazione, la vanità che vedevo sfoggiarmi davanti agli occhi ogni sera non mi trasmetteva più fastidio ma noia. E ancor più mi annoiavano le lotte interne al gruppo, le discussioni per dibattere la bellezza o l'eleganza di alcune donne che venivano a sentirci (o a vederci?). Ogni volta era la stessa storia. Ognuno di noi credeva di essere l'oggetto del desiderio di quella o quell'altra ragazza. Anche se nessuno aveva il coraggio di prendersela apertamente, più che altro per vergogna, era chiaro che l'eventuale conquista di una ragazza da parte di uno del gruppo, se guardata dal lato opposto della medaglia, era lo smacco per chi da quella con-quista veniva escluso. Ciascuno di noi credeva di essere l'unico ad interessare le donne.
La situazione era molto simile a quella che c'è in Italia per quanto riguarda la cultura. Le strane ed eterne convinzioni.
La ragione per cui alcuni individui che leggono libri pensano di essere gli unici a farlo, è la convinzione, nutrita anche dalla disinformazione, di quanto poco si legga in questo paese. Questa con-vinzione è simile a quella che porta i padroni della stessa mentalità a credere di essere l'oggetto di culto della stragrande maggioranza d'individui che per strada si voltano per guardarli al loro passaggio. La loro vanità è la più comica. Li vedi, mentre camminano per le vie del centro, guardarsi il posteriore riflesso nelle vetrine dei negozi, attraversare la strada come fossero modelli in una passerella, e compiacersi appena si accorgono che una persona del sesso opposto li ha guardati. Non sanno che in realtà è qualcosa che succede a tutti, colti e ignoranti, laureati e analfabeti, virtuosi o noiosi che siano. Credono che il sapere si possa sfoggiare col passo dinocco-lato, con l'aggrottare le sopracciglia, o sfogliando un libro in mezzo alla strada, rischiando stupidamente di esser messi sotto da una macchina. E come mi fanno ridere quelli che leggono libri sugli autobus! La lettura di un libro è qualcosa di talmente intimo che leggerlo in pubblico è per me come masturbarmi davanti ad una platea gremita. Evidentemente quelli che lo fanno davanti agli altri non hanno alcuna inibizione perché ciò che stanno leggendo è in realtà l'ultima cosa di cui s'interessano in quel momento. Probabilmente lo fanno perché sono convinti di piacere, per questo.
In verità la cosa che meno influisce nei gusti delle persone è proprio ciò che si sa, la propria cultura. Nel nostro caso era quel che facevamo, la nostra musica. Non è strano che in questo paese sia ben un trentenne su quattro a leggere regolarmente libri, e che sia proprio lui a credere di essere l'unico a farlo. In realtà siamo milioni.
La vanità culturale è “saccenza”, quella dell'immagine “auto caricatura”.
Quelle che più frequentemente si prestano a cadere nel “tranello” della vanità intellettuale (sia come attrici che come spettatrici affa-scinate) sono le donne, che, letteralmente violentate da un atavico senso di colpa che le tradizioni letterarie le hanno tramandato e che le infetta con un idiota complesso d'inferiorità, finiscono per ostentare la loro saccenza per provare ad abbattere quel millenario luogo comune secondo il quale “una donna bella d'aspetto non può essere anche intelligente”. Ma la vanità, come il tabagismo nella denuncia dei redditi, non è deducibile dalla propria natura, e infatti una donna che ha studiato è assai più vanitosa di una donna ignorante, anche se entrambe, nel loro essere donne, conservano intatte, ciascuna con le proprie possibilità, le loro endemiche vanità.
Quando arrivi a renderti conto di tutto questo, incredibilmente, allora sei proprio tu a voler cambiare, come accadde a me ad un certo punto della mia vita.
Cominciai a farmi dei problemi anche solo a guardare certe donne. Mi preoccupavo di quanti anni potessero avere, e se erano troppo giovani cercavo di non farmi ammaliare dalla loro bellezza.
Sapevo che il problema era solo mio, nel senso che quel che pensavo delle donne non poteva né doveva essere generalizzato, ma in una cesta di mele chi saprà mai quale d'essa contiene il verme?
Certo, i comportamenti fin qui narrati erano propri soltanto di un certo tipo di donne futili, senza costrutto, allegrone anche nei sentimenti o nel modo di porsi, e che non era la normalità ma solo il risultato di una precisa maniera di vedere la vita, le cose, il divertimento, ma le altre, voglio dire, le “sane”, dov'erano?
A ciò c'è d'aggiungere che io sono sempre stato timido, e se questo mi tornò vantaggioso qualche tempo dopo, in quel periodo, anche se avevo una gran voglia di buttarmi, non sapevo proprio da dove cominciare. Certe volte m'illudevo che la mia sola presenza sarebbe bastata, ma questo accadeva solo quei giorni in cui ero ottimista e mi facevo pervadere dalla convinzione di piacere. Il più delle volte me ne stavo per conto mio, al bancone del bar, con un bel bicchiere davanti sperando che proprio da lui arrivasse lo stimolo per cui mi sarei deciso di rivolgere la parola all'improvvisato oggetto del mio desiderio. Ma il Negroni non era per nulla provvidenziale. Succe-deva, infatti, o che io lo finivo prima che la ragazza che da qualche tempo mi “puntavo” arrivasse, e allora l'esaltazione alcolica scendeva e mi ritrovavo a dormire sul bancone, o che non facessi in tempo ad ubriacarmi, e quindi a disinibirmi, prima che lei se ne fosse andata.
Quello che più mi fregava era l'incertezza di come avrei dovuto presentarmi. Dovevo continuare a fare il manichino chiuso dentro un'immaginaria vetrina, sperando di essere da lei desiderato come si desidera un cappotto, o, abbandonando ogni timidezza e ogni inibizione, rompendo gli indugi, facendo come fanno tutti i giovani della terra, andarmi a presentare?
Quest'idea, esacerbata dalla mia esitazione, mi sembrava troppo rivelatrice delle mie intenzioni.
Lentamente mi feci la convinzione che le donne fossero una “priorità convenzionale”, e che il “dovere” da parte nostra di corteggiarle fosse solo una specie di tradizione tramandataci da un ormai desueto senso di appartenenza.
Quante volte, guardando ragazze con minigonne eloquenti che sedute sopra ai tavolini si mettevano in mostra come il pesce nei banchi del mercato, ho pensato a come si potessero avere certe priorità! A come alcuni individui, irrimediabilmente innocui e giustamente esclusi, colpiti e affondati da quell'esibizioni di cosce nude, calze a rete, e mutandine scorte perfino senza farci caso, facessero dei locali notturni il centro gravitazionale della loro esistenza! La vita è qualcosa di più di un night club!
Il mio problema era che facevo parte integrante di quel mondo. Sicuro, non mi piaceva affatto, ma questo ero solo io a saperlo. Probabilmente avevo bisogno di qualcos'altro che non fosse così sfacciatamente allusivo e materiale. No, non mi va di parlare come un buddista o un democratico cristiano! O come quei proseliti della nuova religione new age che fanno largo uso di avverbi e ti torturano con “l'esteriormente” o il “positivamente”, e, se hai la sfortuna d'incontrarli in forma, perfino con “l'interiorità del nostro io”! Ciò che volevo risolvere era l'approccio a quel tipo di vita che era anche il mio lavoro. Lavoro per nulla ben remunerato, ma pur sempre lavoro. Volevo cercare un equilibrio fra quel che mi manteneva in vita e ciò che pensavo davvero.
Come dite? Non posso ridurre la vita delle donne ad un continuo meretricio? No, non intendo far questo, anzi, ho sempre ritenuto che nel considerare le persone dovremmo tralasciare le confutazioni sul sesso o sul loro partito politico. La mia ambizione, facilmente frustrabile, è quella di mettere a nudo le motivazioni che si possono avere per diventare vanitosi, e tentare di dimostrare che quel difetto non è qualcosa d'innocuo, tutt'altro! Per esempio, una piccola verità potrebbe essere che spesso si cade nella vanità senza neppure accorgersene.
Quando, mettendomi al di fuori, tentavo di scrutare le persone che “vegetavano” in quell'anfratto ipocrita di terra, mi rendevo conto di vivere effimeramente. Allora cresceva dentro di me un'inquietudine per la vita che mi lasciava ansioso e poco tranquillo. Spesso suona-vo meccanicamente, senza capire a quale pezzo stavo dando vita, in quale posto stavo, e per quanto tempo ancora avrei seguitato a trascinare quella schifosa e ibrida mia esistenza. Era come se fossi padrone di “due me stessi”, la “teoria dell'elastico”, ai quali alternativamente scioglievo la briglia a patto che portassero dietro quello che restava momentaneamente escluso. Il problema era che sentivo l'elastico sempre più tirato e quasi sul punto di spezzarsi. Quale delle due vite infine avrei scelto? E delle due personalità, qual era quella vera?
Mi chiedevo sempre più spesso perché mai mi ero ridotto a fare quella musica, a sostituire il mio vero animo con uno più disposto al compromesso, e che non lasciava spazio a ciò che io agognavo da tempo; essere vero. Se non negli scambi personali almeno nei gusti.
Perché facevamo le “puttane” in quel locale?
Suonavamo tutto ciò che ci chiedevano gli altri e che desse la possibilità al cantante, l'unico a non saper suonare altro che il fischietto, di mettersi in mostra con le sue movenze effeminate, ma non suonavamo mai quel che ci piaceva suonare, quel che volevamo. Fu allora che mi sorse dal cuore un'inquietante risposta; tutto era fatto per vanità. Del resto sogni e bisogni quasi mai vanno a braccetto.
Quando oggi rifletto, nella mia terrazza a Monterosso, mi chiedo se in realtà anche a me non piacesse fare quel genere di vita, esser guardato, portato sul palmo della mano solo perché suonavo la chitarra e, orrore!, sapevo fare la svisa di “Hotel California”, o perché i capelli lunghi mi donavano particolarmente.
Così presi a voler rifiutare, appositamente, ogni sorta di compiaci-mento che provavo, ed a sentirmi, quelle poche volte che non riuscivo a reprimerlo, niente di più di una merda, un megalomane, un vanitoso senza rimedio.
Fu in quel tempo che iniziai a nutrire un odio preciso per vanitosi e affini. Si sa, un vanitoso vede in un altro vanitoso la comicità del proprio “essere vanitoso”. Mi costrinsi a cambiare. L'esibizionismo non l'avrei più permesso a nessuno, e tantomeno al mio corpo. Mi giurai di non mettermi più a posto i capelli quando salivo sul palco o alla fine dei pezzi che suonavamo. Cancellai dal mio mimico repertorio quei gesti che non servono a nulla ma che sono delle vere e proprie calamite di “attenzioni altrui”; sbracciate larghe come le ansate di filo di una sarta, passi claudicanti, inutili verbosità, rotazioni volontariamente distratte di capo, plateali risate, etc. Presi a vestirmi in maniera assolutamente anonima, a fuggire gli specchi di cui il locale era colmo, e a non andare più ai tavoli di chi m'invitava per offrirmi da bere, e che in quel modo, sotto sotto, voleva solo appagare la sua vanità, privandolo dell'opportunità di dire: “Hai visto? Conosco il chitarrista!” Che meschinità!
Chissà quale insospettabile e incomprensibile gusto può esserci a vantarsi delle qualità altrui.
La “vanità di rimpallo” mi è ancora più fastidiosa di quella “dipendente”, che ha un padrone preciso. Mai capito quelle donne che si atteggiano perché stanno insieme ad un personaggio famoso. Come se avessero qualche merito! Il fatto di “farsi fottere” da chi ha una carica pubblica dev'essere un po’ come entrare in possesso di un “segreto di Stato”. Tutti vedono, scrutano, ma nessuno può sapere niente.
Molti dicono che dietro un uomo di successo c’è una donna che l’ha ispirato. Può anche essere vero, ma ciò che m’inquieta è che oggi la donna quasi mai si accontenta di stare dietro. La vanità non si appaga col silenzio.
Quelle “comparse travestite da prime attrici” mi fanno venire in mente certe bambine di terza elementare che, contrariamente a compagne in questo senso più sfortunate, hanno l'amichetta del cuore che gli rivela tutti quei segreti che le fanno sentire importanti e nelle condizioni di atteggiarsi: io so tutto e tu no.
La loro vanità va al di là di qualsiasi immaginabile ragione.
Fu in quel periodo che rividi Marta per la seconda volta.
L'AMORE E' UNA COSA MERAVIGLIOSA
I.
Un amore, per nascere e crescere, pretende che in noi la curiosità dell'altro arrivi a soffocare le abitudini precedenti per farne nascere di nuove ch’egli dirigerà a suo piacimento, proprio come un roman-ziere dirige la personalità e le sembianze con le quali ha rivestito il personaggio del suo romanzo. L'unica differenza è che nel “compiuto” l'amore non dipende dalla sua medesima potenza, mentre il personaggio del romanzo sì. Oltre a questo quel che varia è solo la possibilità della delusione.
Quando sei ad un passo dalla piena disillusione c'è sempre qualcuno che ti convince dell'utilità di quello che fai, di quello che sei, e dell'impriscindibilità della libertà che il mondo ti offre. Certo, non è gratis, ma piuttosto sottocosto. Direi che è come andare al mercato rionale e trovare degli sconti del dieci, quindici per cento. In realtà la libertà che ti prendi è sempre ansiosa di farsi pagare, proprio come un manovale che il Venerdì agogna prendere lo stipendio. E appena ha i soldi in mano eccola che scappa, la libertà, o si nasconde, o si traveste, così che non la riconosci più. La libertà odierna è simile all'attesa messianica che c'era fra gli ebrei del pri-mo secolo; non si attende che per rinnegarla e profetizzarne un'altra, magari diversa, più consona allo “spirito dei tempi”.
Se pensavo che nella vita che facevo nulla era più distante dall'amore, ebbi ben presto l'occasione di ricredermi. Non sono il tipo d'accettare senza ribellione alcuna il contraddittorio, ma avevo co-munque quell'umiltà di fondo che mi permetteva di dire, quando avevo torto, “non so, devo pensarci”. Era un’escamotage per non ammettere direttamente che mi ero sbagliato, cosa che facevo ugualmente dopo aver diluito il mio torto in un tempo più o meno lungo. Ma col passar degli anni anche questo era un giochetto che non funzionava più tanto bene. Talvolta avevo l'illusione di poter convincere gli altri che il mio torto non era poi così netto come appariva, che avevo qualche via d'uscita, ma questo succedeva sempre più raramente. Riuscivo a scamparla e a convincere dell'utilità delle mie errate opinioni solo certi ignoranti conclamati, o altri che, troppo occupati a mistificarmi (sempre per il fatto che suonavo uno strumento), non si rendevano immediatamente conto di avere ragione in pieno.
Fu nel periodo di quest'autoanalisi che rividi Marta.
Stranamente non mi parve così vanitosa come mi era sembrata allora, in quel ristorante il giorno del mio compleanno. Aveva l'aria di rendersi perfettamente conto che le disgrazie planetarie sono un fatto necessario, che la vera libertà è sentirsi liberi di non essere liberi, e che la dilagante umanità dell'umanità non è che altruismo compiaciuto.
Non so ancora se ero io a volerla vedere in questo modo, o se effettivamente anche lei aveva la consapevolezza che la disillusione può portarti a vedere le cose in maniera più rosea di come si sforzano di vederle certi ottimisti a tutti i costi. Chissà, forse i disillusi si fiu-tano reciprocamente.
Credo comunque che essere disillusi sia un privilegio che non tutti i disillusi si meritano, perché le ragioni possono essere molteplici e assai diverse. Ci sono i disillusi per convenzione, quelli che lo sono ostentatamente per ignoranza o troppo qualunquismo, chi lo è per mestiere, e altri più sanguigni, più duri, che non lasciano nulla al caso, e che si sono studiati talmente bene gli individui e il mondo che li circonda, da avere certezze che i più definirebbero da “pessimisti rinunciatari”.
Per esempio. L'Iconoclastia è l'anticonformismo del Terzo Millennio, ma quel che la rende perfetta e inattaccabile è “un ascetismo” completo, civile e sociale. Ciò che consapevolmente ti rende un alienato mentale, cioè, l'unico essere vivente davvero fuori dal convenzionale. Mi fanno ridere quei “bizzarri” che per essere originali si vestono da donna, perché hanno confuso le stravaganze con l'anticonformismo, che invece dovrebbe essere “voce fuori dal coro”. Oggi è più anticonformista un individuo senza patente e senza automobile, piuttosto di un aristocratico che fuma le “canne” in pubblico.
L'ho sempre pensata così, e non è per caso che in quel periodo, quando parlavo ai miei amici del mio punto di vista sul mondo, molti mi consigliavano l'Analista. Ma è sul serio da considerare un rimedio? Secondo me è una malattia che si vuol contrabbandare per cura. Siamo troppo orgogliosi per ammettere anche il più insignificante dei nostri fallimenti, e così arriviamo a pensare che ci sia rimedio a tutto. Credo che la Psicologia, per lo meno quella moderna, sia venuta fuori seguendo da vicino questo ragionamento.
Ad ogni modo. Praticamente tutti (o quasi) gli abitanti del pianeta pensano che essere dei disillusi sia una grave mancanza o chissà quale mortale malattia. Io sono di parere diverso. In realtà è il più privilegiato degli osservatorìi.
Quando non ti aspetti più nulla da nessuno è difficilissimo restare deluso di qualcosa. Questo mondo ti ha già completamente deluso, e, avendo in ogni campo dato tutto, sei convinto che non potrà portarti via più niente.
Ciononostante, per essere sicuramente al riparo da sorprese ed eventi che non avevi calcolato, ti propini con convinzione il ragionamento secondo cui nulla che abbia relazione con movimenti can-gianti di ogni sorta, siano essi individui o enti astratti (nazioni, governi, comunità), possano avere le capacità per stupirti. Non ti aspetti più niente, e tale consapevolezza basta da sola a farti sentire in pace con te stesso. Sei certo di aver già visto tutto, e niente al mondo potrà intaccare il tuo corpo o il tuo spirito.
Ma perfino le montagne non sono state fatte una volta per tutte. L'imprevisto, che sia in qualcosa di sorprendente o scontato, allegro o doloroso, è sempre in agguato. Anche se la tua mente vuole convincerti che non è vero, spesso ti capita di trovarti in mezzo a situazioni che non avresti mai immaginato.
Proprio ciò che avvenne quando rincontrai Marta.
E' in giorni come quello che mi sorprende, rinnovata, la gioia di non essere l'unico individuo, l'unico corpo, se argomentando di va-nità in fondo è di fisicità che si vuol parlare, che non ha nulla da spartire col mondo.
Credetti di vedere in Marta quel che mai mi sarei atteso di notare in una ragazza di questi tempi. Non per forme, ma piuttosto per quel genere di contenuti che man mano che gli scontri fra nazioni e popoli, fra poveri e ricchi, fra nobili e disgraziati, fra destri, ambi destri, sinistri e sinistrati son cessati, si son dati latitanti.
Marta, mi sembrò, non portava in sé quel genere di anticonformismo di origine statale che può spacciare una ragazza un po’ ignorantella e rozza per una creatura emancipata. Lavorava, anche se saltuariamente, senza dar troppo peso a ciò che faceva, in pratica, non da “donna liberata”. Aveva i suoi gusti, ma non appendeva le mutandine di pizzo nere sullo stenditoio che dava nella piazza principale. Non aveva l'automobile, senza per questo portare a nessuno rancori di carattere ecologico. Naturalmente anche lei si sprecava in chiacchiere da eleganti parrucchiere, ma, penso, più per sopravvivenza che per altro.
Il suo modo di parlare un po’ mi terrorizzò. Per dove ci trovavamo era un po’ troppo “ricercato”. “Non è una cosa normale”, pensai, “Soprattutto in un posto come questo locale”. La guardai un po’ di traverso, come si guarda una nuvoletta in una giornata di sole cocente per vedere quale forma abbia.
La vanità sottile di chi parla forbito circondato dalle “donnette del porto”, analizzandola mi ha ricordato certe scene, viste nei films di stile americano, di quelle scuole carcerarie in cui una maestrina fresca di Laurea vuole insegnare il “raddoppiamento sintattico” a rapinatori di mestiere; si finisce presto per essere considerati gli "ingenui scemi del paese", e per renderci conto d'essere fuori luogo.
Ma, malgrado quest'ostentazione incomprensibile, Marta non era una stupida. Anche musicalmente, sebbene non le piacesse la musica troppo colta e tecnicamente difficile, andavamo abbastanza d'accordo. Lei, come me, amava Peter Gabriel non per la sua traboccante e nauseabonda umanità, come la maggior parte dei suoi fans, ma sempre e soltanto per la sua musica. Era una gabrielliana doc. Aveva tutti i suoi album, e l'aveva visto diverse volte dal vivo (niente di più emozionante). Anche lei era una nostalgica dei Genesis vecchi. Non disprezzava Zappa e anche lei, seppur non conoscendolo perfettamente, era affascinata da Pat Metheny.
I.
Un amore, per nascere e crescere, pretende che in noi la curiosità dell'altro arrivi a soffocare le abitudini precedenti per farne nascere di nuove ch’egli dirigerà a suo piacimento, proprio come un roman-ziere dirige la personalità e le sembianze con le quali ha rivestito il personaggio del suo romanzo. L'unica differenza è che nel “compiuto” l'amore non dipende dalla sua medesima potenza, mentre il personaggio del romanzo sì. Oltre a questo quel che varia è solo la possibilità della delusione.
Quando sei ad un passo dalla piena disillusione c'è sempre qualcuno che ti convince dell'utilità di quello che fai, di quello che sei, e dell'impriscindibilità della libertà che il mondo ti offre. Certo, non è gratis, ma piuttosto sottocosto. Direi che è come andare al mercato rionale e trovare degli sconti del dieci, quindici per cento. In realtà la libertà che ti prendi è sempre ansiosa di farsi pagare, proprio come un manovale che il Venerdì agogna prendere lo stipendio. E appena ha i soldi in mano eccola che scappa, la libertà, o si nasconde, o si traveste, così che non la riconosci più. La libertà odierna è simile all'attesa messianica che c'era fra gli ebrei del pri-mo secolo; non si attende che per rinnegarla e profetizzarne un'altra, magari diversa, più consona allo “spirito dei tempi”.
Se pensavo che nella vita che facevo nulla era più distante dall'amore, ebbi ben presto l'occasione di ricredermi. Non sono il tipo d'accettare senza ribellione alcuna il contraddittorio, ma avevo co-munque quell'umiltà di fondo che mi permetteva di dire, quando avevo torto, “non so, devo pensarci”. Era un’escamotage per non ammettere direttamente che mi ero sbagliato, cosa che facevo ugualmente dopo aver diluito il mio torto in un tempo più o meno lungo. Ma col passar degli anni anche questo era un giochetto che non funzionava più tanto bene. Talvolta avevo l'illusione di poter convincere gli altri che il mio torto non era poi così netto come appariva, che avevo qualche via d'uscita, ma questo succedeva sempre più raramente. Riuscivo a scamparla e a convincere dell'utilità delle mie errate opinioni solo certi ignoranti conclamati, o altri che, troppo occupati a mistificarmi (sempre per il fatto che suonavo uno strumento), non si rendevano immediatamente conto di avere ragione in pieno.
Fu nel periodo di quest'autoanalisi che rividi Marta.
Stranamente non mi parve così vanitosa come mi era sembrata allora, in quel ristorante il giorno del mio compleanno. Aveva l'aria di rendersi perfettamente conto che le disgrazie planetarie sono un fatto necessario, che la vera libertà è sentirsi liberi di non essere liberi, e che la dilagante umanità dell'umanità non è che altruismo compiaciuto.
Non so ancora se ero io a volerla vedere in questo modo, o se effettivamente anche lei aveva la consapevolezza che la disillusione può portarti a vedere le cose in maniera più rosea di come si sforzano di vederle certi ottimisti a tutti i costi. Chissà, forse i disillusi si fiu-tano reciprocamente.
Credo comunque che essere disillusi sia un privilegio che non tutti i disillusi si meritano, perché le ragioni possono essere molteplici e assai diverse. Ci sono i disillusi per convenzione, quelli che lo sono ostentatamente per ignoranza o troppo qualunquismo, chi lo è per mestiere, e altri più sanguigni, più duri, che non lasciano nulla al caso, e che si sono studiati talmente bene gli individui e il mondo che li circonda, da avere certezze che i più definirebbero da “pessimisti rinunciatari”.
Per esempio. L'Iconoclastia è l'anticonformismo del Terzo Millennio, ma quel che la rende perfetta e inattaccabile è “un ascetismo” completo, civile e sociale. Ciò che consapevolmente ti rende un alienato mentale, cioè, l'unico essere vivente davvero fuori dal convenzionale. Mi fanno ridere quei “bizzarri” che per essere originali si vestono da donna, perché hanno confuso le stravaganze con l'anticonformismo, che invece dovrebbe essere “voce fuori dal coro”. Oggi è più anticonformista un individuo senza patente e senza automobile, piuttosto di un aristocratico che fuma le “canne” in pubblico.
L'ho sempre pensata così, e non è per caso che in quel periodo, quando parlavo ai miei amici del mio punto di vista sul mondo, molti mi consigliavano l'Analista. Ma è sul serio da considerare un rimedio? Secondo me è una malattia che si vuol contrabbandare per cura. Siamo troppo orgogliosi per ammettere anche il più insignificante dei nostri fallimenti, e così arriviamo a pensare che ci sia rimedio a tutto. Credo che la Psicologia, per lo meno quella moderna, sia venuta fuori seguendo da vicino questo ragionamento.
Ad ogni modo. Praticamente tutti (o quasi) gli abitanti del pianeta pensano che essere dei disillusi sia una grave mancanza o chissà quale mortale malattia. Io sono di parere diverso. In realtà è il più privilegiato degli osservatorìi.
Quando non ti aspetti più nulla da nessuno è difficilissimo restare deluso di qualcosa. Questo mondo ti ha già completamente deluso, e, avendo in ogni campo dato tutto, sei convinto che non potrà portarti via più niente.
Ciononostante, per essere sicuramente al riparo da sorprese ed eventi che non avevi calcolato, ti propini con convinzione il ragionamento secondo cui nulla che abbia relazione con movimenti can-gianti di ogni sorta, siano essi individui o enti astratti (nazioni, governi, comunità), possano avere le capacità per stupirti. Non ti aspetti più niente, e tale consapevolezza basta da sola a farti sentire in pace con te stesso. Sei certo di aver già visto tutto, e niente al mondo potrà intaccare il tuo corpo o il tuo spirito.
Ma perfino le montagne non sono state fatte una volta per tutte. L'imprevisto, che sia in qualcosa di sorprendente o scontato, allegro o doloroso, è sempre in agguato. Anche se la tua mente vuole convincerti che non è vero, spesso ti capita di trovarti in mezzo a situazioni che non avresti mai immaginato.
Proprio ciò che avvenne quando rincontrai Marta.
E' in giorni come quello che mi sorprende, rinnovata, la gioia di non essere l'unico individuo, l'unico corpo, se argomentando di va-nità in fondo è di fisicità che si vuol parlare, che non ha nulla da spartire col mondo.
Credetti di vedere in Marta quel che mai mi sarei atteso di notare in una ragazza di questi tempi. Non per forme, ma piuttosto per quel genere di contenuti che man mano che gli scontri fra nazioni e popoli, fra poveri e ricchi, fra nobili e disgraziati, fra destri, ambi destri, sinistri e sinistrati son cessati, si son dati latitanti.
Marta, mi sembrò, non portava in sé quel genere di anticonformismo di origine statale che può spacciare una ragazza un po’ ignorantella e rozza per una creatura emancipata. Lavorava, anche se saltuariamente, senza dar troppo peso a ciò che faceva, in pratica, non da “donna liberata”. Aveva i suoi gusti, ma non appendeva le mutandine di pizzo nere sullo stenditoio che dava nella piazza principale. Non aveva l'automobile, senza per questo portare a nessuno rancori di carattere ecologico. Naturalmente anche lei si sprecava in chiacchiere da eleganti parrucchiere, ma, penso, più per sopravvivenza che per altro.
Il suo modo di parlare un po’ mi terrorizzò. Per dove ci trovavamo era un po’ troppo “ricercato”. “Non è una cosa normale”, pensai, “Soprattutto in un posto come questo locale”. La guardai un po’ di traverso, come si guarda una nuvoletta in una giornata di sole cocente per vedere quale forma abbia.
La vanità sottile di chi parla forbito circondato dalle “donnette del porto”, analizzandola mi ha ricordato certe scene, viste nei films di stile americano, di quelle scuole carcerarie in cui una maestrina fresca di Laurea vuole insegnare il “raddoppiamento sintattico” a rapinatori di mestiere; si finisce presto per essere considerati gli "ingenui scemi del paese", e per renderci conto d'essere fuori luogo.
Ma, malgrado quest'ostentazione incomprensibile, Marta non era una stupida. Anche musicalmente, sebbene non le piacesse la musica troppo colta e tecnicamente difficile, andavamo abbastanza d'accordo. Lei, come me, amava Peter Gabriel non per la sua traboccante e nauseabonda umanità, come la maggior parte dei suoi fans, ma sempre e soltanto per la sua musica. Era una gabrielliana doc. Aveva tutti i suoi album, e l'aveva visto diverse volte dal vivo (niente di più emozionante). Anche lei era una nostalgica dei Genesis vecchi. Non disprezzava Zappa e anche lei, seppur non conoscendolo perfettamente, era affascinata da Pat Metheny.
Mi sembrava d'aver trovato la mia scarpetta.
Quando per qualche giorno non ci vedevamo, lei tornava sempre piena di racconti o episodi con cui passare la serata a parlare, e mi faceva ridere davvero, con quelle delizie. Anche lei era appassionata di Letteratura. Non lo dava a vedere, ma si capiva che la sua non era solo cultura didattica, nozionismo. Inoltre. Era una ragazza bellissima.
Ben presto fui catturato da quella che in seguito divenne una eterna incertezza. Infatti ero combattuto e infastidito dal dubbio che il gruppo non la vedesse tanto di buon occhio. Era quanto di più distante esistesse dal loro modo di concepire l'obbligatorietà di quella nostra presenza in quel posto. Sembra assurdo a pensarci adesso, ma per gli altri del gruppo era inconcepibile il fatto che qualche donna venisse in quel locale non per farsi ammaliare da noi, ma solo per passarsi una serata senza particolari costrizioni o necessità, così, spensieratamente.
I miei amici erano abituati ad avere a che fare con le mediocrità che quell'andazzo gli procurava come unico svago, e ad aver la consapevolezza che tutto girasse intorno a loro. Gli pareva strano che al mondo potesse esistere qualcuno che non badasse alla loro presenza, soprattutto se quel qualcuno veniva dove suonavamo noi e, secondo il loro modo di veder le cose, doveva averci a che fare.
Quest'idea divenne sempre più forte in loro, tanto che si erano qua-si convinti di essere dei proprietari feudali, e che su tutto ciò che di lì passava avessero diritto di prelazione, di scelta. Una proendrìa sessuale. Non ammettevano, per esempio, che una bella ragazza andasse in quel locale e invece che “farsi fare” da uno di noi uscisse con qualcun altro che non era “un artista”. Sembra incredibile ma, anche se non era detto in maniera chiara e diretta, la situazione era proprio questa. Pareva di essere dentro un territorio di caccia esclusivo.
Ricordo che allora pensai che “il fascino della divisa” non colpisce solo le donne, ma anche coloro che suppongono di diffonderlo nel mondo. Noi, per il nostro “ruolo pubblico”, eravamo una specie di Ammiragli, Generali, Aviatori. I miei compagni erano convinti che le ragazze entrassero nel locale e, immancabilmente, restassero affascinate dalla nostra “divisa di musicisti”. Appena una ragazza li guardava loro ringraziavano il Dio della Musica. Questo si chiama “rincretinimento di gruppo”, ed ha la sua fetta di studio nelle “patologie suggestive”.
Io non me la prendevo più di tanto. Consideravo che le ragazze che uscivano coi miei compagni erano, nel novanta per cento dei casi, interessanti come andare a vedere una retrospettiva di film bulgari o dal Dentista. Quasi sempre si trattava di bimbette ambiziose che avevano capito male il nostro lavoro, e che uscivano con noi per il solo gusto di farsi additare come “ragazza del cantante o del chitarrista”. Generalmente erano mosce come bucce di banana, e avevano il tracciato nell'elettroencefalogramma piatto come un microchip. Naturalmente erano anche vanitose, e una delle disgrazie peggiori che può capitare ad un uomo (l'ho capito a mie spese) è quella di uscire con una donna vanitosa. A dar retta alla sua vanità, agli ammiccamenti stupidi fatti ad altri uomini, alle movenze ruffiane, al suo esibizionismo marchiano e spesso fuori luogo, ci si dovrebbe picchiare ogni quarto d'ora.
Se posso dare un consiglio; non sposatevi mai con una donna che si è rifatta le labbra col silicone. Quelle femmine sembrano sempre distribuire bacini a tutti, e passereste la vostra vita a far risse per difendere il vostro onore di marito da chi ha confuso un “gommato Pirelli” con una avance.
Forse era per questo motivo che io non avevo assiduamente la ragazza. Ogni tanto uscivo con una donna, ma era solo per provarmi, per constatare se piacevo ancora e se ero capace di conquistare. Anche se quasi mai la conquista che facevi si rivelava tale, sovente, però, riuscivo ad estrapolare convinzioni che mi persuadevano di avere ancora delle possibilità, soprattutto con le donne più grandi. Erano loro, infatti, a suscitare il mio interesse. Le bimbette non le sopportavo. L'unica cosa che mi procuravano erano erezioni immediate che poi, una volta che tutto era finito, scendevano inesorabilmente come la mia considerazione nei loro confronti.
Marta aveva la mia età, e se da una parte c'era il pericolo, una volta innamorato seriamente, che per la sua bellezza sia fisica che mentale in modo astuto mi tradisse, dall'altra c'era la certezza che con lei non ci si annoiava di certo. Ma forse questo era solo un ottimismo senza ragione generato dalla speranza di piacere.
Quando la incontrai per la seconda volta ( e la conobbi davvero) fece subito colpo su di me. Allora mi rimproverai quanto stupido e pieno di pregiudizi ero stato la prima volta che la vidi. Natural-mente a lei non dissi nulla, ma, inquieto, mi domandavo come mai io, che difficilmente ciccavo a considerare le persone, quella volta avevo completamente sbagliato giudizio.
Lei, quella sera, non aveva occhi che per me. Durante tutti i pezzi non abbandonò il mio sguardo che un paio di volte (che stavo già per giudicare troppe). Ero in quella fase, narrata prima, di disillu-sione forzata. In pratica non mi fidavo. Tanto più che il mio giudizio precedente sulla ragazza in questione era stato quantomai negativo. Quindi, se non altro per tenere fede alla configurazione che me n'ero fatta (questione di coerenza), non la degnavo di una seppur misera considerazione. Certo, la guardavo, ma come si guarda la partita alla Tv, o qualcosa che c'interessa ancor meno.
Ma lei insisteva. Mi guardava sorridendo e non aveva l'aria di voler litigare. La smorfia che mi aveva lasciato in eredità uscendo dal ristorante sembrava aver smarrito ogni ragion d'essere. Solo questo fatto mi permise di giudicarla diversamente. “Se non altro”, mi dissi, “non è una che porta rancori per questioni futili”.
Subito sperai che il desiderio fosse ciò che avevo sempre creduto; un sentimento che si sviluppa appena trova fonti di reciprocità, e più esso è forte più ci sono speranze che abbia trovato. Del resto l'illusione s'aggrappa a noi se trova motivo, e il motivo è dato da chi ha un principio d'illusione, ed è quindi esso stesso ragione di reciprocità. “Se non l'avessi guardata non mi sarei accorto che mi stava guardando, e così è per lei”, mi dissi.
La speranza che nutrono i disillusi è simile alla “debolezza dell'ottimismo” nella quale cadono gli apolitici e gli anarchici sotto le elezioni. Speri sempre che il tuo voto, questa volta, sia decisivo per il cambiamento. Quasi mai è così. E allora quella delusione servirà per i prossimi dieci anni a farti astenere politicamente. L'amarezza che resta è che soltanto quando tutto è finito che ti accorgi di esserci “cascato nuovamente”, e la rabbia che ti nasce dentro è ciò che presto battezzerai “disaffezione politica”. Ma questa sorta di “movimento mentale” non è così scontato in amore, perché per appagare i nostri “pruritini del cuore” siamo disposti a rimettere in gioco tutto, ogni nostro stato d'animo e ogni nostra convinzione, tanto che per appagarlo “grattandoci”, siamo in grado di sopportare qualsiasi specie di delusione.
La disillusione amorosa è una bomba ad orologeria che aspetta il consumarsi del tempo per esplodere in una pirotecnica evoluzione di passioni.
Il pomeriggio avevo litigato con Alessandro per problemi legati alla nostra musica, e lui continuava a tenermi il broncio come un bambino dell'asilo. “Sicuramente”, mi dicevo, “lei è qui su un suo preciso invito”. Non a caso era l'unico che aveva salutato.
Quando finimmo di suonare, Alessandro, insieme a tutti noi, scese giù dal palco e andò, non senza tirarsi indietro i capelli e dopo aver sostato vistosamente al centro della scena, i cinque gradini che portavano al palco vuoto, al tavolo di Marta. Io posai la chitarra e mi avviai verso il banco, dove molti volevano offrirmi da bere. Rifiutai con grazia e, nascostamente, mi feci fare un Negroni.
Li guardavo da lontano.
L'errore nel quale inciampano quasi tutti gli inesperti, è quello di cimentarsi nelle discipline di cui non capiscono nulla esagerando le porzioni per dissimulare la loro inesperienza. Così finiscono involontariamente per non avere mezze misure e offendere o infastidire chi hanno di fronte. Del resto causa più danni un filantropo che per una volta si comporta egoisticamente, piuttosto che un egoista nato.
Alessandro non aveva il portamento di un modello, ma quello di un bamboccio da pizzicotti sulle guance e affettuosi baci di zie. Ciononostante, gesticolante e sorridente, in piedi, fingeva di parlare in modo serio, anche se non curante, proprio come un consapevole “bello”. Lei ascoltava. Pareva di essere a teatro, ma la recita del “protagonista” aveva preso un’involontaria ironia che sfocia in quel fastidio da cui non si rimonta neppure col rimborso del biglietto. Non per altro, per la pomposa importanza che lui dava ai gesti, agli sguardi tutt'intorno, quando salutava ostentatamente qualche inutile personaggio che poco distante passava, nonché alzando il tono del-la voce non appena gli sembrava di dire qualcosa di originale.
Quando arrivava il momento nel quale si costringeva, senz'altro violentandosi, ad ascoltare, assumeva una posizione da “fermo-immagine”, rigidamente dinoccolata, alla maniera dei neri d'America, con una gamba piegata e l'altra diritta, una mano sul tavolo e l'altra sul fianco, tenendo la testa leggermente reclinata, e modellando il suo volto mellifluamente, facendolo diventare da angioletto, simulando una condizione paradisiaca falsa e ributtante.
Certamente stava usando quel tempo di forzato silenzio per pensare qualcosa di originale da dire non appena Marta glie ne avesse dato l'opportunità. A parta Maurizio, gli altri tre del gruppo, a distanze pressappoco regolari, facevano lo stesso.
Credo fermamente che soltanto in rari momenti si possa davvero afferrare il significato che il vocabolo “Vanità” ha. Infatti non sono le azioni clamorose a farci capire le inezie che riguardano questo difetto, ma più quelle nascoste, che nessuno nota. Magari una mezza frase, una parola, un gesto, l'esser colti da un amico a fare qualcosa di poco chiaro nei suoi confronti, il cercare, anche velatamente, di mettere qualcuno in cattiva luce agli occhi di persone che invece lo tengono in grande considerazione. Sono queste le occasioni in cui ci accorgiamo di essere uomini di scarso valore, perché non diamo vita a queste meschinità per sopravvivenza, ma per Vanità, per essere “riconosciuti” più belli e intelligenti di altri. Non sono i furti o gli omicidi, le “tammurriate” o le frasi urlate che ci fanno scoprire lo spessore degli individui, ma i loro comportamenti nascosti. Un vanitoso può sfoggiare il suo esibizionismo lavorando in Comune, allo sportello dove si rifanno le Carte d'Identità o gli Stati di Famiglia. Non servono le folle per dar sfogo, e quindi sottoporre gli individui, alla nostra Vanità, bastano soltanto due persone, magari una sola, che particolarmente c'interessa e sulla quale vogliamo far colpo. In effetti una recita vanitosa non ha come obiettivo la collettività, ma, fra questa, un’unica persona.
Stavo per attaccare il mio Negroni quando Alessandro, sempre tenendomi il broncio e dopo aver tentato di tutto per rovinarmi la piazza con la sua amica, venne a dirmi che Marta voleva che an-dassi al suo tavolo. Lo guardai mentre conquistava il palco fingendo di mettere a posto il microfono, col suo passo claudicante, sincopato. Fece quei gradini come se fosse Wanda Osiris.
Risi. Risi di gusto.
Non era una di quelle serate in cui sentivo, più che in altre, il bisogno di prendere le distanze dal mondo, quindi accettai e raggiunsi il tavolo di Marta.
C’aveva messo i gomiti sopra, e con le mani aperte si teneva il mento. Mi guardava, mentre mi avvicinavo, con un vago sorriso sulle labbra, e i suoi occhi, che la volta prima avevo confuso con un paio di telecamere di quelle usate per spiare gli impiegati mentre sul posto di lavoro oziano o si fanno gli affari loro invece che darsi da fare, quella sera luccicavano come lampioni di fine ottocento intenti ad illuminare accidiosamente i lastrici azzurri e pallidi. Non mi ero affatto sbagliato, la prima volta, confutando i suoi capelli. Parevano avere una vita propria, e si muovevano anche se lei teneva la testa ferma.
- Mi stavo chiedendo - iniziò - come certe persone possono cambia-re, anche d'aspetto, quando sono lontane da particolari eventi come possono essere le feste di compleanno. Come stai?
- Credevo di averti offesa in qualche modo. - risposi io in soggezione.
- Ci vuole ben altro per offendermi. L'importante è sapere con chi si ha a che fare, e voi quella sera eravate troppo ubriachi per poterlo rivelare appieno. Se non ricordi il mio nome, io sono Marta.
- Gianni, piacere. - dissi stringendo non troppo forte la sua mano.
- Davvero ti diverti a fare quello che fai? - mi chiese.
- Intendi dire a suonare? – risposi chiedendo.
- Beh, vedo che sei un ottimista. Se quello lo chiami suonare allora sì, a suonare. - disse piegando la testa da una parte come solo le donne sanno fare.
Sorrisi in modo che nelle mie intenzioni voleva essere simpatico, ma che da sé, probabilmente, aveva preso strade che non mi appartenevano.
- Ma i Queen non sono malaccio come si dice in giro. - non lo diceva quasi nessuno - Sono famosi. - continuai cercando di ostentare convenzionalità, campo in cui se non primitivo ero davvero alle prime armi.
- Certo. Anche l'Aids è famoso, ma non vedo perché dovrei averci a che fare. - rispose lei finendo in un sorriso che piano piano divenne scrosciante e rumoroso.
Avevo iniziato male, si capiva. In certi casi è sempre meglio essere sé stessi, senza cercare inutili e anemici compromessi che possono farci apparire democratici e tolleranti fuori luogo, senza un proprio pensiero, nudi. Stavo facendo la figura dell'invertebrato, senza spina dorsale.
- Presento una mozione. - dissi alzando un dito.
- Parliamone. - rispose lei ridendo.
- Comincio da capo?
Marta sorrise bonariamente, come una mamma italiana.
Perché c'innamoriamo di una donna molto spesso basta che lei ci dia del “tu” guardandoci negli occhi, sovente che gli scappi un po’ di forza in più quando ci stringe la mano, e quasi sempre che trattenga il suo sguardo su di noi per qualche secondo più del necessario.
Subito cadiamo nella tentazione di prendere tali gesti e trasformarli in simbolismi che non vediamo l'ora di reinterpretare con la convinzione d'esserne stati i protagonisti. Può darsi che, in questa veste improvvisata di esegeti, ogni tanto ci vada bene, ma a volte il “tu” che ci ha dato è perché pensava di conoscerci già, la forza che ha messo nel stringerci la mano è solo una forma di educazione e di rispetto, e lo sguardo del quale noi ci credemmo oggetto, era solo mira sbagliata, strabismo o l'essere assorta nei propri pensieri.
Tornato al banco ordinai un altro Negroni, che scolai in un batter d'occhio. Dopodiché mi avviai verso il tavolo dove lei, col ditino alzato, prometteva falsi rimproveri.
- Il guaio di questo replay, - disse appena giunsi nei pressi del treppiedi - è che mi sono dimenticata cosa ti avevo chiesto. Peccato, me l'ero preparato così bene....……………..
Ridemmo. Ridemmo per gran parte della serata. Ma non di quelle risate fatte per obbligo o educazione, ridemmo di gusto. Io, un paio di volte, dovetti alzarmi per continuare a suonare, ma quando ritornavo al suo tavolo ritrovavo verve e comicità. Neppure l'inno nazionale, quella sera, mi avrebbe schiodato da quella sedia, d'accanto a lei.
L'autocompiacimento che Marta mi provocava mi faceva star bene, e cercando di rinnovarlo, con domande volutamente stupide, con occhiate intense e prolungate, con lusinghe datate e fuori tempo massimo, con atteggiamenti e galanterie che non avevano nulla del secolo ventunesimo e che si prestavano come antefatto ad un infe-rente ed obsoleto baciamano, speravo che quella serata non finisse mai.
Continuammo a bere e scherzare fino a che non ci ritrovammo tutti e due abbastanza ubriachi da dimenticare che in quel posto non ci si poteva comportare in quel modo, che quel genere di goduria e di divertimento andavano presi sottovoce, quasi in silenzio, nessuno avrebbe dovuto accorgersene, soprattutto i miei compagni.
Loro erano degli abitudinari. Se qualcosa doveva cambiare volevano saperlo con giorni d'anticipo, come per le canzoni avevano bisogno di una “scaletta”. Dovevano prepararsi, avvicinarsi a piccoli passettini, facendo largo uso di luoghi comuni, come un tossicodipendente, scalandosi le dosi di droga, si disabitua all'assuefazione. Inoltre. Loro, come veri “artisti”, non si sprecavano in quella maniera, non si davano così completamente. Erano sempre distaccati quanto basta, anche se falsamente simpatici, da poter dissimulare, in maniera voluta e ostentata, cittadinanza in un altro pianeta. Ecco, si comportavano da marziani. Inarrivabili. Mentre invece erano solo dei ragazzotti stupidi e vanitosi che suonavano in uno scalcinato locale a centomila lire la sera.
Ma bisognava capirli. Soltanto là dentro erano a loro agio e si sentivano qualcuno, mentre nel resto delle loro giornate ritornavano ad essere degli individui mediocri, che come tutti erano soggetti agli strani sconvolgimenti del tempo, dei governi, dei mercati. Infatti, fuori da quel locale e dal loro “ruolo” di musicisti, nessuno li notava.
II.
La svolta, se così si può chiamare, venne un giorno in cui io e Maurizio trovammo, in un bar non distante dalla sala dove provavamo, il coraggio di farci le nostre ragioni. Affermammo, in maniera forte e categorica, che eravamo stufi di suonare soltanto “merdate”, che avanti di questo passo non saremmo mai approdati a niente.
- E va bene! - disse Alessandro a Enzo e Giacomo – Facciamoli contenti. Altrimenti crederanno davvero di essere dei perdenti a vita e tenteranno il suicidio.
Così ci concessero di scegliere quasi la metà dei pezzi da fare sull'intera scaletta. Come mia madre che, sapendo che a me piacciono soltanto le caramelle alla frutta, comprava sempre quelle alla menta (“così durano di più”, diceva pensando di farmi, e di farsi, un favore), allo stesso modo loro, piuttosto che sciogliere il gruppo, e quindi uccidere un sogno, lasciarono decidere a noi le canzoni da suonare la sera.
Frustrare i propri veicoli di piacere dev'essere un po' come accettare il contraddittorio; una forma di castrazione.
Anche la cocciutaggine è un brutto difetto, e ancor più brutto diventa se l'applichiamo ai vizi che abbiamo, e, fra questi, quello di non riuscire a considerare i propri difetti. Considerare seriamente i propri difetti è un atto di estremo sadomasochismo, è come esporsi volontariamente al pubblico ludibrio.
Quelli che meno di tutti riescono a far questo sono i vanitosi (quindi Alessandro, Giacomo ed Enzo), che nella presunzione di saper nascondere la propria vanità arrivano addirittura a convincersi di non avere difetti. Se ci fate caso noterete che un vanitoso, per quanto disposto sia ad ammettere i propri difetti, non si troverà mai d'accordo con voi sulle pecche che avete visto in lui. E' come andare in Comune a chiedere un certificato; lo sportello è sempre un altro. Certo, “lui ha dei difetti”, ma non sono sicuramente quelli che voi avete creduto di vedere.
Io e Maurizio scegliemmo tre pezzi di Peter Gabriel, tre di James Taylor, due di Pat Metheny e uno di Frank Zappa. Non erano pezzi che si potevano suonare in quel locale, ma i patti son patti. Così iniziammo a prepararli in sala. I pezzi di Gabriel e di Taylor non furono difficili da tirare su, e nemmeno “Last train home” di Pat Metheny. Più difficoltosi del previsto si rivelarono “Third wind” di Metheny e “Evil Prince” di Zappa. Comunque, alla fine, più o meno, riuscimmo a riprodurli fedelmente.
La volta in cui decidemmo di suonare i nuovi pezzi nel locale era un Venerdì, la serata nella quale potevi permetterti di uscire dai binari consueti. Facemmo tutti i nuovi pezzi, e, io e Maurizio, ci divertimmo parecchio. Non c'era molta gente, ma facemmo prevalere l'ipocrita scusa secondo la quale “meglio pochi ma buoni”. Certo, sapevamo che la serata dopo, il Sabato, non sarebbe stata la stessa cosa. E infatti fu così.
Quello era il giorno nel quale avevano la libera uscita ragazzine e ragazzini che volevano sentirci suonare i soliti Queen, U2, Jovanotti, Vasco Rossi eccetera. Per quei “liceali in vacanza” quella era musica che loro consideravano “cult”. A noi non restava altro che eseguire e subire. Naturalmente solo io e Maurizio subivamo le forzature del mercato, perché gli altri erano “nel loro”. Alessandro poteva atteggiarsi come una vecchia checca in andropausa che cerca soltanto il martirio, Giacomo, il batterista, sollevato dal dover venire dietro a me e a Maurizio (doveva suonare tutta la sera in quattro quarti) si riposava dalla faticaccia del giorno prima, ed En-zo, il bassista, incazzato perché completamente sano il Venerdì, quel Sabato poteva sbizzarrirsi con Negroni e Glen Grant poiché la tecnica di quei pezzi non richiedeva uno sforzo particolare che non fosse il “ton-ton”.
Il Sabato avrei fatto di tutto per restare a casa. Qualche volta sono riuscito a darmi malato, ma siccome suonavamo anche la sera prima, non potevo farlo spesso perché avrei finito con lo smarronare. E poi quei soldi, benché pochi, mi servivano. Gli altri invece sembravano contenti. Non avevano la premura di piacersi prima che piacere, e non sentivano, come la sentivo io, l'eterna urgenza di smentire la critica cittadina. A loro bastava poter bruciare vanità, partecipare a quel grande circo comicamente megalomane e narcisistico al quale il ruolo di modelli avventizi, a cui si sottoponevano volentieri, li costringeva. Per nulla ripugnati, continuavano ad andare avanti in quella mistificazione dell'arte, della nostra arte, che erano ben felici di propugnare agli ignoranti spettatori.
Comunque, in quel periodo, niente era più lontano dalla mia testa della preoccupazione di cosa pensassero di noi quelli che capivano di musica. Marta mi aveva lasciato il suo numero di telefono la sera che per la seconda volta la conobbi, ma, completamente ubriaco, ero riuscito nell'incolpevole intento di perderlo.
Non sapevo come fare per ritrovarla. Alessandro, ovvero l'unico ponte verso quella tanto agognata casualità da me un po’ ingenuamente creduta Amore, non sapeva né dove abitava né il suo numero di telefono. Solo allora mi disse che lui non la conosceva più di tanto, che era solo una amica di sua sorella, una sua vecchia compagna di Liceo. Anche se non lo davo a vedere, ero disperato. Come una novella Cenerentola avevo perso la mia scarpina. Semmai fosse stata la mia scarpina.
Che ridere. Non è certo una svista asserire che negli “ovvero” nuotano le realtà come nel mare dei “semmai” affogano i veri intenti.
Mi sentivo amareggiato, deluso, dimenticato, e la consapevolezza che Marta, presumibilmente, non si rendesse neanche conto dei dolori che mi stava procurando, mi lasciava in uno stato d'acèdia retorico e fastidioso. La lontananza non è la fine di tutto, perché il saperci pensati può annullare la materiale distanza. Nel mio caso, però, non v'era nulla di preciso, di certo, e il fatto di non aver approfittato di quella sera per metterle le briglie, lasciava svariate possibilità, alimentate dal mio scetticismo, che lei non mi pensasse affatto, e che fosse già abbandonata nelle braccia di altri cento. Si sa, “la gelosia ha tante facce quante sono il numero delle cause incerte che la fanno nascere in noi”, scriveva Proust. In quei pochi giorni avrei voluto sapere Marta con un ragazzo ben preciso, con nome, cognome e indirizzo, sul quale poter lanciare improbabili anatemi, piuttosto che non saperla sola e quindi con un imprecisato numero di amanti senza volto molto più difficili da sconfiggere.
Anche se ero sicuro che lei presto sarebbe tornata in quel locale, avevo comunque l'ansia di rivederla. Ero conscio di non esserne innamorato, almeno, non ancora, ma la sua presenza mi procurava quella leggerezza al cuore che gli adolescenti sentono davanti alla loro ragazzina. Mi piaceva questo stato, e cercavo di galleggiarci il più possibile. Il problema era che una volta provato ciò che io ritenevo essere “il massimo” non avevo alternative che non fossero quelle di cercarla o di suicidarmi.
E' strano quel che succede ai nostri corpi quando una persona con cui sei stato particolarmente bene sparisce e non si fa più vedere. Ci sembra quasi che quell'intruso, di cui noi in così poco tempo già sentiamo di non poter fare più a meno, ci abbia felicemente spostato le nostre cose consuete, e che le abitudini alle quali una volta eravamo attaccati tornino spocchiosamente ad ingombrare la nostra vita, strappandoci il nuovo scenario proprio mentre stavamo entrando in simbiosi con lui. Le odiamo, allora, quelle cose consuete, e sentiamo perfino di poter rinunciare facilmente a quella che era la nostra vita soltanto perché il nuovo personaggio, così caro al nostro cuore, fatica ad entrarvi.
Chissà per quale motivo la reazione alla mia mal celata disperazione si risolveva tutta nella tentazione di strappare i miei documenti. Forse li accusavo d'essere proprio loro a tenermi legato al mio passato, diventato così odioso per me, perché Marta non vi prendeva parte se non come sogno vago, come voglia di raggiungere la tanto agognata felicità.
Oh! come mi rammaricavo di non essere mai stato un contemplatore! Rammentavo a malapena i tratti del suo viso, delle sue labbra, la forma dei suoi occhi o la sua risata. Quante volte, in quei pochi giorni, mi sono rimproverato l'ubriachezza di quella sera. Non per la paura di aver fatto qualche brutta figura, ma perché la mia condizione di barcollamento mentale mi precludeva quell'oggi di godere, sebbene soltanto nei ricordi, del suo viso, del suo corpo, delle sue parole e del clima che si era stabilito fra noi quella sera.
In quelle poche settimane fui tentato sovente di chiudere tutto dentro il cassetto dei ricordi, ma mi sembrava di essere ingeneroso innanzi tutto con me stesso. Come potevo arrendermi e lasciare che tutto finisse, così com'era cominciato, per caso o per inerzia? E già mi dicevo che la felicità è la più immeritata di tutte le casualità.
Se bene ci pensiamo nessuno di noi, seppur felice, ha ricercato, con abnegazione spropositata, quella felicità di cui poi è stato “vittima”. Sì, perché la felicità, e quasi sempre la felicità amorosa, ci vien su dal di dentro sottoforma di tenera e dolce amarezza, un languore che ha la capacità di soffocare in noi qualsiasi altro moto del cuore e ogni coscienza, in quell’istante, d’essere felici. La vera felicità è come un atto sessuale, che soltanto nei ricordi si riesce a gustare completamente.
Quando ero lì lì per mettere da parte lo stupido orgoglio e, armandomi di zaino, bussola e ramponi, andarla a cercare, ecco che lei, così come la prima volta, mi appare, seduta allo stesso tavolino, come appare un fantasma in una nottata di vento e pioggia.
Sentii che dentro di me qualcosa sobbalzava, si muoveva, si chinava come verso chi è generoso con lei, tanto che la sua presenza in quel posto mi parve più un atto santo di misericordia che, com'era, quello prosaico di un'innamorata. “Stai buona”, dicevo a denti stretti alla mia pancia. Subito pensai che l'adempimento di una speranza fosse un chiaro segno d'intesa. Avevo sperato e pregato che lei venisse, ed era venuta. Allora mi costrinsi a pensare al Destino, all'ineluttabile, e già mi vedevo sposato con Marta e padre di tre bambini.
Mi saluta da lontano, con la manina. Io rispondo con un sorriso. Incredibilmente (quando ci si mette anche la sfiga!) stavamo suonando “Show must go on”. Proprio davanti a lei, alla quale i Queen, come a me, stanno sullo stomaco. Il guaio era che, essendo Sabato, quella era più o meno la scaletta! La solita robaccia! Ero deciso di non farmi ribeccare da lei proprio su questo punto. Così parlai a Giacomo e Alessandro minacciando di andar via se non avessimo fatto qualche pezzo della scaletta del Venerdì. Loro accettarono, di malavoglia ma accettarono. Mi esibii in “Third wind” di Pat Metheny. Che saccente! Che vanitoso! La svisa è davvero notevole, ma tutto andò per il verso giusto. Dopo aver concluso, accompagnato da pochissimi applausi, scesi dal palco e mi diressi verso il suo tavolino.
- Finalmente - disse lei appena mi ebbe a portata di voce - qualcosa di meno noioso!
- Hai solo questo da dire per Pat Metheny? - chiesi io ridendo.
- Scherzavo. - aggiunse - Avevi detto che mi telefonavi o sbaglio?
- Volevo chiamarti, ma ho perso il tuo numero la sera stessa che me lo hai dato. - risposi io cercando di essere più convincente possibile. Era vero, anche se non sembrava verosimile.
- Devo crederci? - continuò lei alzando un sopracciglio alla maniera dei doganieri sospettosi.
- Se vuoi te lo giuro!
- Calmati. Se lo dici con questa foga ci credo, - sorrise - non hai bisogno di giurarmi niente!
Non ero più tanto sicuro di non essere innamorato di lei. Tutto combaciava. Tremore, secchezza delle fauci, tachicardia, sudorazione, alterazione della vista, giramenti di testa, nausea. Mi sem-brava d'aver fatto indigestione. Lei doveva essersi accorta di qualcosa, perché mi guardava con un sorriso ebete sulla faccia. Cercai di recuperare la pacatezza che mi ha sempre contraddistinto, ma allungando una mano per spegnere la sigaretta nel portacenere, rovescio prima il mio bicchiere, poi il suo addosso a lei. Le sporco tutto il vestito, e per rimediare dico:
- Scusami, sono un imbranato. Comunque non doveva costar molto.
Lei da principio mi guarda sbigottita, quindi divertita, infine scoppiando in una rumorosa risata. Il ghiaccio era sciolto, sopra alla sua gonna, e riniziammo a parlare come ci era successo nell'occasione precedente. Di nuovo notai che nel parlare era esageratamente ricercata.
La vanità dialettica, nel suo allestimento, richiede la stessa attenzione di quella che si ha nel vestire o nell'atteggiarsi. Bisogna curare le frasi in modo da non cadere nelle ripetizioni, negli errori grammaticali, negli anacolutismi, nelle false originalità e nelle considerazioni scontate. Come quando si scrive un libro. In effetti il libro è uno sfoggio di vanità, detta “saccenza”, di chi lo ha scritto. La differenza è che lo scrittore termina di godere quando porta a compimento l'opera, mentre i discorsi del vanitoso hanno proprio nella loro conclusione il principio del compiacimento, perché il vanitoso non gode di quello che dice, ma dell'effetto che le sue parole hanno sugli altri.
- Senti, - mi disse avvicinando lentamente la sua faccia alla mia - hai finito di suonare?
- Sì, per stasera credo di sì. - rispondo.
- Bene. Allora usciamo un po', così ti riprendi.
Uscendo noto che Maurizio è nella sua auto e sta “tirando”. Coca. Qualche tempo dopo lo troverò nel bagno della sala prove con una siringa piantata nel braccio.
Appena fuori dal locale, che si affaccia sul mare, sento pervadermi dall'intimità che prende gli innamorati, quel sentore che c'illan-guidisce modellando il nostro volto e trasformandolo in quello di un perfetto deficiente.
Scivolai lentamente fra le sue labbra, come in balìa di un buco nero che tutto risucchia con la sua forza negativa. Mi specchiai nel suo viso, cosa che non facevo da anni, e mi trovai insolitamente bello. Bello come lei.
Forse quella fu una delle poche volte, assai rare nella mia vita, in cui mi sentii bene con qualcuno che non ero io. Si sa, l'Iconocla-stia ti porta all'isolamento.
Quando ripenso a quella prima volta con Marta credo che il Destino, se esiste, sia veramente beffardo. Tutti gli uomini credono che la vita, le cose, il mondo, esistano in loro funzione, e che se-guano il modello di certe macchine con meccanismi d'inerzia. Tutto va da sé, una volta innestato. Noi siamo qui a subire, inconsapevolmente, ciò che queste macchine, che sia per un caso o perché è il loro lavoro, inavvertitamente o per un preciso disegno cosmico, ci offrono. Nulla è più distante dal nostro cervello di credere che noi siamo parte attiva di tale meccanismo, che siano proprio gli individui ad innestarlo e a dar vita e indirizzo a quel che gli succede.
Quella notte feci l'amore con Marta. Lo facemmo in una camera di un albergo vicino, col trasporto proprio degli adolescenti che scoprono l'estrema duttilità dei loro corpi.
Non scorsi nessun erotismo, in quel nostro primo incontro. Tutto era congelato dall'emozione. E poi, “Erotismo”! Cosa vuol dire? Quando sei lì, in camera con la donna di cui sei innamorato, nudo, anche lei nuda, cosa c'è da erotizzare? Tutto è già abbastanza erotizzato da sé! Aiutato dalla presenza del letto, del comodino, della tappezzeria, della luce soffusa dell'abat jour, mescolata, come olio nell'acqua, a quella diffusa del giorno che penetra fra gli intervalli regolari della persiana, e che dov'essa è tirata su, in una misera striscia, riporta confusamente sul letto piatto, sulle pareti a fiori, su screpolate labbra secche, i ricami curati delle tende. Un gioco lumi-noso di sfere stroboscopiche che riflettono il clangore intontito del sesso, dell'amore. Sei indeciso, allora. Fai ruotare gli occhi, stordito. Guardi quella donna e nel pensare di prenderla ti chiedi se per caso non stai rovinando qualcosa di prezioso, un'amicizia, un amore vero. E' lì che abbassi lo sguardo e ti ritrovi spento. Il tuo desiderio non è più sudore, ferocia erotica, orgasmo, seme e capelli in bocca, ma carezze, baci, tenerezza, lacrime e giuramenti. E non vorresti più essere un uomo, un uomo al quale le tradizioni orali e letterarie impongono di prendere quella creatura di una specie diversa, che ti guarda da quel letto, a gambe larghe, col muschio del suo sesso che per te, in quel momento, non è più veicolo di piacere, ma bellezza della natura, panorama marino, barriera corallina, covo di micromiceti, ma un figlio caro, adorato, che una madre ha ricercato costantemente, e vorresti sentire le sue mani non sul tuo sesso, in quell’istante volgare organo dissacratore, ma sui tuoi capelli, carezzevoli, solide, che ti proteggono dal mondo e alle quali, senti, puoi abbandonarti fiducioso.
Come tutto è più basso nel sesso!
Purtroppo i rapporti sessuali con le donne che amiamo sono simili a quelle “via Crucis” a cui ogni tanto si sottopongono peccatori incalliti e senza rimedio; non vediamo l'ora che finiscano per tornare a fantasticare perversioni su donne astratte alle quali non dobbiamo rendere conto di nulla. Per tale motivo non ho mai comperato quei calendari che ritraggono in posizioni erotiche donne belle e famose. Irraggiungibile per irraggiungibile preferisco crearmi da me un'immagine su cui fantasticare, senza dover pagare per sfogliare ragazze la cui cellulite è “modificata a colpi di mouse”.
Per anni avevo evitato di mettermi con ragazze di cui, sentivo, potevo anche innamorarmi. Non volevo correre il rischio, come mi era successo in passato, di idealizzarle rendendomele sacre e, per questo, ridurre il rapporto sessuale ad un atto irrispettoso e dissacrante, perché quella stupida devozione m'inibiva a tal punto da farmi provare un indicibile rimorso e uno scarso eccitamento. Così uscivo solo con “smandrappate” che assumevo per una sera, per portarmele a letto, e che la mattina dopo potevo licenziare senza il rimorso per i contributi o la liquidazione. Tutto possiamo dire, ma il rapporto sessuale, per quanto bene vorremmo alla donna che abbiamo sotto, o a fianco, o sopra, è sempre qualcosa di scarsamente sentimentale, di animalesco, e con loro non riusciamo a liberare completamente la nostra libido senza avere il timore di fare la figura dei depravati, degli “eretici” che pisciano sull'altare di una chiesa, e passare poi mille notti insonni per il rimorso. Sennonché, alcuni anni dopo, veniamo a sapere che è proprio per la nostra poca depravazione che quella donna ci ha lasciati.
Comunque tutto andò bene, e ognuno di noi fu contento di quel “pranzetto consumato in fretta e furia”. Certo, la realtà di questi scambi è che sono, almeno all'inizio, fine a sé stessi. L'ultima cosa che un individuo pensa quando fa l'amore è che “si sta dando”, e questo tanto più vale quando veniamo assorbiti e intontiti dalla devozione di cui sopra (perché pensare che alla donna di cui siamo innamorati piaccia ciò che le stiamo facendo ce la renderebbe molto meno “dèa”, poco “santa”, più puttana e, per questo, meno amabile). Non si arriva mai a pensare che in verità è molto peggio, che l'inevitabile sciagura è che ci si sta mettendo in gioco. Presto sentiremo la necessità di provare e di provarci, di metterci in ballo, di capire fino a che punto amiamo e siamo amati, se la persona che abbiamo di fronte sia realmente quella che crediamo di conoscere, e non c'è niente di più falso dell'impressione che ci può fare la persona che amiamo o che crediamo di amare.
Chiaramente tutto questo lo affermo ora, ora che posso dire di essermi sbagliato. Allora non avevo le idee così chiare. Non mi mancavano certo gli spunti, qualcosa iniziai a notare già dopo pochissimo tempo che stavamo insieme.
Spesso Marta voleva convincermi della sua assoluta fedeltà, di quella che lei amava definire “coerenza”. Il guaio era che non potevo provare certe cose che vedevo sia nel suo carattere che nel suo pensiero, assai vicino a ciò che il mondo chiama “moderno”. Si può tradire anche stando chiusi in una scatola da scarpe. Talvolta le sue affermazioni mi lasciavano perplesso, e mi facevano sorgere il dubbio, già allora, di essermi sbagliato. Lei, sempre portata a convincere gli altri di essere originale, tentava di spacciarsi per “socio” di quel club inesistente che nel mondo è denominato, pressappochisticamente, anticonformismo; la consapevolezza di appartenere ad un tempo tremendo in cui ogni buon stato di coscienza, se non fa parte di quel genere di coscienza moscia, conforme al mondo, e che fa del libertarismo una forma di egoismo non troppo occulta e piuttosto furba, è considerato arretratezza o maschilismo. Come m'innervosivo per il fatto che certe cose non sono dimostrabili in senso stretto!
A sera la guardavo dal palco sorprendendola, non poche volte, a fissare non me ma uno dei miei compagni. Cosa voleva dire? Notai che quando camminava nel locale teneva il petto in fuori, sporto come un vaso di gerani su un davanzale, ed il posteriore leggermente ricurvo, in modo che si notasse.
Quando la guardavo nelle sue escursioni fra i tavoli, vedendo il suo corpo deformato come un arco da tiro, scuotevo la testa. Marta non aveva il fondo schiena fatto in quel modo, e infatti quando eravamo soli era piatto, un tutt'uno con la colonna vertebrale. Perché lo teneva così solo per strada o nei locali? Il mio cervello iniziò ben presto a rovellarsi. Era forse esibizionismo? vanità?
Cominciai ad essere nervoso.
Se un vanitoso non è capace di nascondere la sua vanità è meglio che lasci perdere e cambi atteggiamento! Come sono ridicoli quegli esibizionisti convinti che la loro megalomania non si noti, sicuri di essere riusciti a nasconderla perfettamente. Questi individui sono delle vere e proprie figure retoriche che camminano, preterizionali, paralessici, contraddizioni viventi, ossimori che respirano, e sono convinti a tal punto di apparire naturali, che la vanità con la quale martoriano la vista di chi hanno intorno sembra essere il loro fedele specchio dell'anima.
Ma anche questi si possono “scoprire”. Quando girano la testa lentamente, quando prolungano indefinitamente una nota, quando tentano di farci credere d'essere sinceri mentre sillabano le frasi e sbattono ridicolmente le palpebre, perfino quando ci ostentano eloquentemente la loro attenzione verso i nostri discorsi.
Sono certo, la Vanità è l'unico difetto che non si può occultare, e coloro che pensano il contrario sono proprio i vanitosi, che nel loro slancio interpretativo diventano l'unico esempio vivente del signi-ficato della locuzione “Segreto di Pulcinella”.
Ognuno di noi vorrebbe assicurare il mondo intero della sua estraneità di fronte ai puerili esibizionismi, ma ci capita spesso di farci coinvolgere a tal punto dalle nostre convinzioni sul nostro corpo, dall’illusoria consapevolezza ch'esso sia qualcosa di desiderabile, che il compiacimento che proviamo ci rapisce in una giostra megalomane costringendoci a rivelare la nostra reale pasta, il nostro egoismo, il nostro egocentrismo, e, più che ogni altra cosa, la nostra vanità. Ogni cosa, nel mondo, ha origine da essa o dall'impossibilità di appagarla.
Certo, anch'io, come molti, avrei voluto affermare, senza temer smentite, di stare insieme ad una persona meravigliosa, che nulla ha da nascondere perché genuina, incolpevole, sincera e vera. Ogni uomo della terra ama crogiolarsi al tepore di quella ambiziosa speranza d'aver a che fare con una donna diversa, che non ama particolarmente sfoggiarsi, ma purtroppo sovente ci rendiamo conto che se una donna di tal fatta esiste non siamo certo noi ad averla in custodia.
Presi l'andazzo di vedermi ogni sera con quella che tutti definivano, con un pressappochismo da far invidia a mormoni e bahisti, la mia donna. Ancora oggi non so se lei sia mai stata, anche solo temporaneamente, la mia donna. Quel che so con certezza è ciò che sentivo.
L'amore che portavo a Marta non lasciava il minimo spazio a considerazioni di carattere più generale e realistico. Il fatto di averla conosciuta in quel locale era completamente scomparso. Eppure, a ripensarci oggi che sono meno manipolabile, già allora era un fatto degno di nota. Io in quel posto ci lavoravo, e probabilmente, se non fossi stato spinto dall'incombenza di vivere, non ci avrei mai messo piede, soprattutto per divertirmi. Ma allora lei, lì, cosa ci faceva?
Mistero.
Marta, così mi parve all'inizio, non era tipo da facili divertimenti, e un locale come quello non aveva la forza per spingere una persona d'intelligenza media a farsi frequentare. E soprattutto un tipo come la “mia Marta”. Lei aveva la giusta visione della vita, era il classico esempio di donna che per fare una qualsiasi cosa doveva avere motivazioni precise, non era abituata a sprecarsi.
Nonostante i miei dubbi il nostro rapporto si trascinò per diverso tempo. Gli ingredienti erano gli stessi di quella prima sera. Io suonavo, e quando avevo finito scendevo e mi adagiavo accanto a lei, al suo tavolo, il più delle volte senza parlare.
Evidentemente entrambi avevamo la corda che avevamo, se tutte le possibilità discorsive che avevo visto le prime sere si erano già esaurite. In quelle occasioni pareva che un gelo d'indifferenza avesse avvolto i nostri sentimenti. Dopo qualche chiacchiera fra commensali nelle quali io rimanevo puntualmente escluso, si usciva per an-dare in spiaggia o in una stanza d'albergo a fare ciò che le coppie di tutto il mondo, più per tacita convenzione che per reale desiderio, fanno.
Anche se a me piaceva tantissimo fare l'amore con lei, quasi sempre ricavavo da quegli incontri abborracciati, soltanto eterne menzogne di lealtà, fiducia, amore.
Datemi retta, quando una donna vi ama in questa maniera scappate. I nostri rapporti erano lo specchio fedele dei nostri altalenanti sentimenti, della scarsa sincerità, della menzogna, di una fiducia ceduta “una tantum”, delle ammissioni “quid pro quod”. Un “dare per avere” paralessico, muto ma chiaro, evidente.
Quest'illusione d'amore andò pian piano scemando fino a diventare scialba, e quel rapporto soltanto un riflesso condizionato, una costrizione.
L'amata, quando è consapevole dell'amore che le vogliamo, sa con certezza che qualsiasi carognata ella ci faccia noi non sapremmo reagire che volendole ancora più bene. Quello che non sa è che accatastando carognate su carognate rende le nostre aspettative sempre maggiori. Questo, l'ho imparato a mie spese, non è un bene per noi, perché il “ritorno”, i momenti piacevoli che viviamo con lei, è sempre qualcosa d'improvviso, e quindi di scarsamente goduto, e non fa altro che aumentare le nostre sofferenze, perché, come scriveva Salomone, “chi accresce il suo desiderio accresce anche il suo dolore”.
Ma forse l'amore per una donna vanitosa è una prigione d'incertezze dentro la quale amano segregarsi certi uomini votati al martirio. La loro voglia di soffrire per amore deve trasmettergli qualcosa di vivo ch'essi non sono in grado di scovare nella quotidianità della propria esistenza, e sono continuamente alla ricerca di quel “colpo di grazia” che li convince di essere al mondo. Protraendo la relazione con una vanitosa riescono a sentirsi parte dell'umanità attraverso le pene d'amore ch'ella gli infligge, e usano quei dolori come serbatoio della loro coscienza d'esser vivi.
Credo fermamente che le ingiustizie che ciascuno di noi vorrebbe gli fossero propinate quotidianamente, debbano essere accuratamente ricercate, magari nelle file truccate agli sportelli, magari nelle altrui raccomandazioni, o forse nel chiudere gli occhi davanti ad una storia improbabile, come fu la mia con Marta. Questo bisogno di soffrire è ciò che ci rende forti di fronte alle disgrazie, alla nostra stessa morte.
Il ricordo delle umiliazioni inflittemi da Marta ancora oggi mi aiuta a campare, facendomi nascere dentro una rabbia che, unita alla delusione, mi coadiuva nell'autopropinarmi una sorta di solidarietà che riesce a confortarmi delle ingiustizie subite, passate o presenti che siano.
Ero arrivato a convincermi a tal punto d'essere senza rimedio, che l'infelicità di cui godevo presto divenne per me un’assuefazione.
Rammento che poco prima del fattaccio, quando Marta per una volta era riuscita a farmi stare bene, io, per riappropriarmi della mia infelicità, dovevo infliggermi con convinzione una specie di auto sublimazione. Faticavo, ma dopo qualche istante riuscivo a risentirmi vittima di un'ingiu-stizia.
L'amore illanguidisce. La sofferenza invece ci rinvigorisce a tal punto che se una donna ci dice “ti odio” non è raro finire per sentirsi ringalluzziti. Il nostro ragionamento pare esser questo: non ci si risponde mai “Lo odio” se prima non ci si è chiesti: “Lo amo?”
Tale sicurezza arriva perfino a perpetuare in noi un pianto che gli altri non riescono a capire; la nostra speranza di esistere, seppur odiati, nei pensieri di quella donna.
Com'è strano il mondo. Ci riteniamo dei duri, dei mastini, perché non abbiamo mai visto la Morte da vicino, sia quella Reale che quella Metaforica, e ci siamo convinti che le disgrazie accadano sempre agli altri. Ma non appena superiamo la soglia del dolore che siamo in grado di sopportare, subito ci convinciamo di soffrire ingiustamente. Non esiste contrappasso per noi. Inaspettata-mente, e chissà per quale motivo, questo fatto basta da solo a rinvigorirci. In quell’ingiustizia ci sentiamo riempiti di coraggio, quello stesso coraggio che nella normalità ci mancherebbe. Così diamo vita ad un ridicolo e retorico circolo vizioso; vogliamo sentirci vittime senza rimedio ma siamo costantemente alla ricerca di una cura, e fra queste un abbaglio, l'Amore, che riteniamo la più indolore, e che invece è assai frequentemente il principio della nostra malattia.
Di tanto in tanto avevo la tentazione di tornare a perdermi per le strade del mondo. Chi era questa sconosciuta alla quale avevo aperto le porte del mio cuore? Mi sembrava di non saperlo più. Era importante saperlo?
Oggi credo di sì, ma allora non m'importava poi molto d'essere ricambiato. Il mio amore mi bastava, mi appagava completamente. Sicuro, non era una cosa normale, e talvolta queste idee mi convincevano di non essere adatto alla “sistemazione”. Ciononostante quella provvisorietà non mi dispiaceva. Pertanto continuai la storia con quella ragazza. Non so perché. Ero innamorato, è vero, ma non senza via di scampo. Probabilmente avevo bisogno che qualcuno mi chiedesse: “Hey, ma cosa stai facendo?” Forse solo così mi sarei salvato da ciò che in seguìto accadde.
III.
L'amore che portavo a Marta mi spingeva a fare cose che se avessi visto negli altri mi sarei giurato di non frequentarli più. Avevo preso l'abitudine di chiederle, ogni volta che mi alzavo dal tavolino per andare a prendermi da bere, se voleva qualcosa anche lei. Questa mia galanteria divenne presto un suo vizio, e spesso mi scoprivo ad alzarmi dalla sedia e andare a prendere da bere solo per lei.
Esasperante gentilezza? Mah!
Non mi piaceva il suo modo di fissare le facce. Marta aveva nei suoi occhi neri la profondità sfuggente del corruttore di costumi. A sua insaputa, più per consuetudine che per intenzione, essi scrutavano nelle anime di quelli che potevano diventare dei condannati, e fra questi l'unico certo, io, la possibilità di appagare la sua vanità di donna. Pareva usare il viso degli altri come “Stele di Rosetta”, come caleidoscopio o specchio riflettente. Leggeva le espressioni facciali come uno scrittore sta attento all'inflessione vocale del critico che legge un suo libro. Forse s'illudeva di poter capire quale giudizio aveva di lei dato quel volto, ma, così mi sembrava, quasi sempre non riusciva che ad estrapolare incertezze. In questo Tempo di Grandi Omologazioni bisogna essere degli esperti contemplatori per tradurre un gesto mitico-simbolico, tanto più, quindi, per inter-pretare un naso corrucciato o l'improvviso movimento di un sopracciglio. Restava delusa, allora, e io dovevo preoccuparmi di dimostrarle che non mi ero accorto di niente.
Ero ossessivo? Forse.
Sovente, quando alcune volte subivamo la compagnia di qualche nostro amico, mi scoprii a darle ragione anche se pensavo avesse torto marcio, e, addirittura, a dirottare i discorsi su ciò che sapevo le avrebbe fatto piacere. Quando spendeva una parola d'apprezzamento per una persona che conoscevo e che sapevo assolutamente insulsa, per accontentarla ed evitare di aprire qualche pericoloso contenzioso che per ripicca sua mi avrebbe privato di favori futuri, sia di carattere sessuale che di carattere personale, mi costringevo ad essere d'accordo con lei.
Come dite? “Complicità amorosa”? Magari.
A giorni, dopo qualche piccolo litigio, tentavo di rimontare andando via pur volendo, invece, rimanere accanto a lei. La mia speranza era quella di essere seguito. Era il grido di dolore di chi è caduto nelle mani del nemico, l'Amore, e sta per essere trucidato. Probabilmente ciascuno di noi nella sua vita è già morto tre o quattro volte, in questo senso. E non se ne rammarica, intendiamoci, perché la morte, a meno che non sia quella pragmatica, fisica, universale, è sempre presupposto di rinascita, unico istante in cui davvero si sente la vita in tutta la sua concretezza. Per questo motivo molti di noi agognano soffrire, perché sappiamo che a quella “morte” seguirà una rinascita, e allora ci cerchiamo questa fine simbolica perché così speriamo di poter gustare nuovamente, e più in profondità, la vita.
Cosa spinge un uomo a ricercare quel che in realtà vuol fuggire? Forse la convinzione che la Morte, nonostante tutto, non arriverà, che il bello della vita, in fondo, è tutto qua.
Non è dunque improbabile che quel mio “andar via da lei” fosse solo la richiesta muta d'essere salvato, e in questo, sotto sotto, ancora la voglia di soffrire.
Ero diventato onomatopeista. Appena qualcuno pronunciava il suo nome o soltanto quello della strada dove lei abitava, subito sentivo un tuffo al cuore, una scarica di adrenalina che mi scuoteva il petto, la testa, e che mi mandava in ebollizione il sangue. Tutto questo accadeva nonostante la “sbadataggine” di Marta nel provarmi il suo amore.
Questa obnubilazione amorosa aveva come valida diagnosi il mio sentimento, che soffocava in me qualsiasi voglia di far considerazioni che mi avrebbero permesso di prender coscienza della con-dizione precaria del nostro rapporto. Sapevo di essere ricambiato, ma mi mancava l’inequivocabilità dei gesti, quell’esporsi completo e inopinabile che mi desse la possibilità di consolidare i miei sogni e i miei desideri amorosi cancellando qualsiasi dubbio, dubbio che nell’arco della giornata puntualmente faceva intempestive quanto terrorizzanti apparizioni.
L'ansietà del mio amore mi stava rendendo succubo di lei? O forse era quel suo centellinare coccole, ad accrescere il mio sentimento?
“Amor mi sprona in un tempo ed effrena
assecura e spaventa
arde e agghiaccia
gradisce e sdegna
a sé mi chiama e scaccia
or mi tene in speranza ed or in pena”
Quando leggevo questi versi del Petrarca il sangue mi si raggelava nelle vene. Che meschini, noi uomini! Siamo tutti figli di Laio in questo porco mondo, smaniosi di rientrare dentro quel buco nero che un lontano giorno ci esturbò.
Divenni presto inquieto, incerto se abbandonarmi, almanaccando sulle poche ammissioni d'amore che lei mi concedeva, facendomi coinvolgere completamente in quel rapporto, o, riprendendo personalmente la guida di me stesso e la direzione delle mie azioni, ristabilire le distanze fra noi.
Quei comportamenti, esageratamente “galanti”, li pagavo più tardi, quando la notte andavo a dormire a casa, e, nel mio buio, mi rimproveravo il fatto di essere troppo acquiescente ed ecumenico, cioè, proprio quel che avevo sempre evitato di essere.
La solitudine è quella condizione che spinge gli individui a fare i conti con sé stessi. L'inibizione che intorno a loro crea il mondo, folla e movimento, li aiuta a nascondere per qualche mezza giornata il loro completo asservimento all'amarezza della realtà. Restano intontiti, inebetiti. Poi, a casa, nella loro camera da letto, soli, riescono a rinfacciarsi tutto, sapendo bene che hanno una notte davanti per rifarsi l'espressione del viso e rinfrancarsi da quell'auto analisi nell'attesa quieta del domani.
Ma cos’erano tutte queste incertezze che il mio cuore faceva proprie con l’inevitabile conseguenza di farmi indicibilmente soffrire? Era dunque questo malessere l’innamoramento? Ma quel che sentivo non aveva molto da spartire con ciò che le tradizioni letterarie avevano tramandato. Questa ossessione non era uno stato permanente di oblìo dannunziano, e neppure la sensazione di vivere più del necessario. I contorni si fecero più chiari, ed io capii che il nostro rapporto era quanto di più distante esistesse da ciò che avevo ritenuto essere la felicità. Immediatamente chiusi gli occhi e impressi quei contorni nella mente, battezzandoli “Tormento”.
Un giorno, dopo aver finito di far l'amore, mentre lei era sotto la doccia, io, disteso sul letto, voltai la testa lentamente, e nello specchio rividi il mio volto. Non mi riconobbi subito, e questo essere estraneo a me stesso mi fece sobbalzare di sgomento. Nel guardare i miei occhi liquidi, limpidi come un ingenuo, il mio cuore rimase senza respiro. Fu in quell'istante che per la prima volta mi resi conto d'essere prigioniero. Più che la mia faccia, riflessa in quello specchio scorsi la certezza di un vicolo cieco, o, peggio ancora, la piccola entrata di un enorme labirinto nel quale, come in un sogno, ci si sente rapiti, e la frenesia di uscirne ci porta ad infilare una porta dietro l'altra, restituendoci come unico risultato quello di farci perdere definitivamente.
Talvolta, essendo magnanimo con me stesso, mi giustificavo dicendomi che l'amore è anche questo genere di comportamenti. Non ci credevo più di tanto, ma questo tentativo di autoconvincimento mi serviva per non mandare all'aria tutto, cosa che senz'altro sarebbe successa se avessi cercato di cambiare abitudini alla nostra relazione. Avevo sbagliato fin dall'inizio, questo lo sapevo benissimo, ma ormai l'irreparabile era stato consumato.
Mi sentivo prigioniero. Non tanto di Marta, quanto della paura di affrontare la vita da solo, senza di lei. Non perché fosse in grado di darmi eccessive sicurezze, questo non l’ho mai creduto. Ero più che conscio d'esserne innamorato, e mettere fine a quegli eterni istanti, alle sere trascorse a fissarla dal palco o a sentire la sua presenza quando andavo in giro smanioso di vederla la sera o il giorno dopo, mi sarebbe costato troppo.
Non sono uno sprovveduto, e mi rendo perfettamente conto che la sofferenza portata dalla fine di un amore, di un'illusione terminata male, non è mentale ma proprio fisica. Forse perché “quella fine” non dà possibilità di rinascita, e ti lascia in uno stato permanente di “non-morte” che ha insito in sé nessun appagamento, né della sofferenza e men che mai della felicità.
Spesso mi è capitato di paragonare la fine di un amore a quando tiravo su un giro di chitarra, una canzone, che poi, arrangiandola con gli altri del gruppo, finiva per essere stravolta e cambiare completamente significato. Vedevo quel mio pezzo masticato male, portato in giro e rimesso lì, dove tutti lo potevano guardare, completamente sfigurato. Il guaio era che, seppur molte volte poco convinto, anch'io avevo preso parte a quello stravolgimento. Una forma di “Autoinqui-sizione”.
Certo, il sentimento che proviamo per una donna ci costringe a cambiare il nostro approccio col mondo, ciò che non avevamo mai creduto possibile, ma non dovremmo arrivare a stravolgere quel che siamo, il nostro animo profondo!
Ripensandoci mi chiedo spesso se l'Amore altro non sia che il totale autoannullamento. Ci si vede nell'altro come in uno specchio, e questo ci basta. Aspettiamo che sia lui, o viceversa lei, a prendere le decisioni per noi, a dirci quello che dobbiamo o non dobbiamo fare, come ci dobbiamo muovere. Ci si autoannulla, ci si autolimita, ci s'impongono barriere che con l'andar del tempo e il perdurare delle relazioni siamo sempre meno pronti ad abbattere quando, in una proposta di lavoro o d’invito a cena, si profila l'occasione per rinnegare il nostro status di coppia. Ci si abitua addirittura a parlare al plurale, come se fossimo una Società a Responsabilità Limitata, o come quei Luminari che parlando di sé stessi dicono “Noi”, intendendo tutto il Corpo Scientifico. Certo, si può affermare, senza temer smentite, che un rapporto di coppia abbia la stessa legittimità di una Corporazione.
E' l'ansia di trasmettere agli altri il nostro desiderio, la nostra speranza di venire accettati come unica entità nella convinzione che quell'accettazione, quell'inglobamento da parte della società, dia forza e rinvigorisca il nostro amore. Così, quando la Società va in fallimento e i rancori vengono a pignorare tutte le nostre speranze e molti di quegli esili ricordi, dobbiamo reinventarci, rifondare una società a conduzione unica, magari qualcosa di piccolo, un laboratorio che non vogliamo più dividere con nessuno. Forse perché così speriamo di prolungare quella sofferenza in attesa della rinascita.
In realtà quel plurale è una sorta d'esagerata riverenza verso noi stessi, perché non consideriamo mai la nostra donna come un altro individuo, ma come quel qualcosa in più che riempie la nostra vita, che ci appartiene, un arto o una fase complementare, un messaggio in codice da decifrare per capire dove possiamo arrivare.
Purtroppo riusciamo a comprendere tutto questo solo quando l'amarezza ci ha definitivamente marchiato nelle carni, e quando la voglia di rivalsa si è impossessata di noi a tal punto che subito vogliamo trovarci un’altra donna per far pagare a lei, in un colpo solo, tutte le umiliazioni subìte da quell'altro amore finito male.
I rancori più duri a morire sono quelli che si portano per quelle ingiustizie che ci sono state fatte senza clamori, per quelle offese la cui causa è talmente confusa che non ce la possiamo prendere apertamente. Così sovente accade che continuiamo ad odiare per anni, perché o non abbiamo nulla di legittimo, e di così riprovevole agli occhi degli altri, da rinfacciare a Colei che secondo noi ci ha offesi, o quella stessa offesa che ci è stata fatta, nonostante sia subdola, ma per noi bruciante, nascosta, ma per noi presente, è tuttavia talmente inconfessabile, soprattutto da parte nostra, che ci vergogniamo di ammettere che in qualche modo siamo stati toccati, di essercela presa, insomma. Nel mio caso, non so se dir “per fortuna”, l'enormità fu così evidente che se mai porterò ancora del rancore nei confronti di Marta, cosa che non mi sembra possibile, quel senti-mento sarebbe non solo giustificato, ma addirittura inevitabile.
Quello che provavo per Marta era talmente una cosa mia da sfiorare la masturbazione. E' scontato asserire che l'amore è la più nobile forma di egoismo. Il tener conto dell'altro è fine a sé stessi. In realtà non ci preoccupiamo mai di voler bene ad un'altra persona, ma sublimiamo il rapporto con quell'individuo che vorremmo essere noi.
Anche l'amore, in fondo, è una forma di narcisismo. Ce ne rendiamo conto quando un storia finisce. Allora, e solo allora, capiamo che ciascuno di noi sta male per le proprie carenze, e non perché gli manca qualcosa che è al di fuori del suo corpo. L'amore che vorremmo dare agli altri è in realtà l'amore che vorremmo gli altri ci dessero.
Probabilmente anche con Marta fu così. Quando ripenso al suo modo di camminare, ciò che subito di lei mi affascinò, e al suo modo di parlare, entrambe peculiarità delle sue premeditazioni di “come porsi al mondo”, mi rivedo schiavo non solo di quei gesti ma anche di me stesso, della mia voglia di rivederli e dell'agonia nell'aspettarli. Mi sentivo un morente. In breve tempo, come diciamo a Genova, mi accorsi di essere “bello che andato”.
Ma Marta pareva non pensarla alla stessa maniera. I suoi “addobbi vanitosi”, seppur fosse vero che all'inizio avevano me quale obiettivo, non erano studiati in maniera d'affascinare un uomo preciso, ma esposti come “offerta gratuita” verso l'intera umanità. Una auto referenza, una specie di pubblicità della propria persona.
Come i potenti del mondo, che hanno a disposizione mezzi che gli consentono di entrare giornalmente in un delirio di sola andata, anche lei tentava di costruire un sorta di “monopolio dell'interesse”, cosa che ogni ragazza libera vorrebbe mettere in atto. Il punto era che lei aveva me, non era libera, e che il suo rappresentava un chiaro caso di “conflitto d'interessi”. Ecco, ironicamente si può affermare ch'ella si prestasse ad essere oggetto delle “attenzioni di un Antitrust”.
Che difetto immortale e pericoloso è la Vanità! Un egoista è egoi-sta quando ne ha le opportunità! E un gozzovigliatore, perché abbia la possibilità di gozzovigliare, ha bisogno d'essere seduto ad una tavola imbandita! Mentre la Vanità è un difetto che solo la solitudine può frustrare. Non v'è nulla da mostrare se non c'è nessuno che guarda. Ma in questo mondo, per trovare un po’ di pacifica solitudine, dovremmo diventare degli anacoreti e andare a vivere in alta montagna.
Mi fanno ridere quelli che si sottopongono volontariamente ad essere spiati da una telecamera ventiquattrore su ventiquattro. L'emozione che provano dev’essere un po’ simile a quella che prende gli assassini, i quali, sempre volontariamente, chiedono di essere sottoposti alla macchina della verità; la speranza e la voglia di vedere se riescono a fregare chi hanno intorno. Il rischio non è una cosa innocua: pr quegli assassini è il carcere a vita, a volte la pena di morte, mentre per gli “scopofili” consiste nell'essere giudicati globalmente. Questo non è un bene, perché i nostri comportamenti nove volte su dieci sono frutto del caso, di uno stato d'animo o di sbadataggine, e se la telecamera ti sorprende a dire una stronzata, poi non è difficile né tanto raro essere giudicato uno stronzo ad libitum.
L'unica cosa che allora speravo, nei miei ragionamenti “semi-incoscienti” d'innamorato, era che il mio fisico non si assuefacesse anche alla vanità di quella donna. Ne sarei morto.
Quando ero da solo mi sorprendevo a fare stupidi paragoni con gli altri del gruppo. Pensavo a come fossero ingenuamente semplici nell'amare. Non bisogna essere dei geni per saper dire “ti amo” alla propria donna, ma bisogna certamente esserlo per avere il coraggio di piangere quand'ella ci lascia. Come sono vigliacchi gli uomini che non lo sanno fare! Allora mi convincevo che il mio modo di voler bene a Marta fosse quanto di più intelligente esistesse sulla faccia della terra. Faceva leva sulla comprensione, sul farla sentire bella, intelligente, importante, sulle facili lusinghe, su un romanticismo esasperato e opprimente che m'illudeva d'essere un maestro nell'amare.
Oggi ho capito che ognuno di noi pensa questo di sé stesso. Il nostro modo di amare è il solo, l'unico, il più vero e particolarmente intelligente.
Sorridevo quando Alessandro mi parlava delle ragazze che aveva “conquistato”(!), che aveva fatto innamorare di lui. E ancor più ridevo quando poi queste stesse ragazze conoscevo! Giovincelle di sedici, diciotto anni, per le quali il massimo era essere riprese da una telecamera o conoscere un personaggio famoso!
Ma anch'io non avevo molto da star allegro.
Quante volte, guardandomi nelle facce della gente che veniva nel locale, mi son rivisto stupido, ridicolo, in balia di un fiume in piena. Il fiume in piena non era Marta, non completamente. Piutto-sto era l’inebetimento che quel sentimento per lei mi provocava, ero io che, assorbito dal mio amore per lei, avevo perso sia il vizio che il gusto di dire di no.
Ricordo che in quei giorni di assoluto abbandono, quando lei mi faceva qualche dispetto, io non avevo altra arma per difendermi che non fosse quella di cercare di far la pace.
Il coraggio che hanno molti uomini nel protrarre una relazione con una donna che, sanno, li tradisce, è assai simile a quello di certi scrittori libertini che scrivono la loro biografia osando mettere tutta la verità nero su bianco. Non c'è compiacimento nel divulgarla, ma solo dolore.
Intendiamoci, Marta non mi aveva tradito, non materialmente. Tuttavia il suo modo di farsi guardare mi rendeva nervoso, facendomi sorgere il dubbio che non badasse a me e fosse sempre “alla ricerca di qualcosa di meglio”.
Era furba, lei. Quando, quelle poche volte, avevo il coraggio di rinfacciarle qualcosa, metteva su un muso che mi faceva venire l'ansia di riguadagnarla al mio amore, unica cosa che per me contasse davvero. Allora cedevo, e a Marta, che mi ricattava sentimentalmente, ero sempre pronto a dir di sì. Anche se in quel tempo ancora non me ne rendevo conto, ero incapace di reagire.
Ad osservarla mi sembrava sempre smaniosa di trovare il modo per tradirmi. Non era così male, questo. Poiché se avevo ragione d'essere geloso potevo ancora trovare il coraggio per troncare quella relazione. Le gelosie senza motivi visibili finiscono in dramma.
Rammento una sera, al bancone del locale mentre bevevamo in silenzio. Fummo avvicinati da due Carabinieri in borghese. Venivano nel locale solo raramente, quando i turni glielo permettevano. Lei, che da qualche minuto stava “puntando” uno dei due, sembrava smaniosa di presentarsi. Allora si misero accanto a noi e cominciarono a parlare. Di musica, naturalmente.
L'osservavo dialogare con “l'inbanderuolato” mentre il suo collega mi teneva impegnato dicendomi quanto per lui fosse stato una rivelazione l'ultimo album di Eros Ramazzotti.
Quando si fece tardi e venne il momento di andare via, avvicinandomi a Marta ed al suo non troppo occulto corteggiatore, la sentii pronunciare queste parole. “Lo vedi? C'è sempre lui!”
Anche quella volta non risposi, e, come succede a certi codardi senza rimedio o a coloro che non hanno mai la risposta pronta, soltanto una volta a casa, nella mia camera, sprofondato nella delusione e febbricitatamente inquieto, riuscii a rimproverarmi la mia mancanza di reazioni.
Andiamo! Non potevano mica arrestarmi!
Come dite? Ero esageratamente geloso? Certo! Era l'incertezza di sapermi amato che mi faceva diventare geloso, e la mia gelosia era un modo per proteggere il nostro rapporto. Mi spiego meglio.
Quando, alcune volte, Marta si mostrava gelosa di me, il mio amore, lusingato da quella gelosia, cresceva. Era come se della sua gelosia se ne nutrisse, e io, speranzoso d'essere ricambiato, mi mostravo geloso convinto d'indurre in lei quello stesso meccanismo che s'innestava nel mio corpo accrescendo il mio amore, sperando sì che la sua psico accettazione delle sublimazioni a cui davo vita funzionasse come funzionava in me, nel mio cervello. Ero certo che la Gelosia del nostro partner fosse l'ultimo baluardo che la disaffezione alla sua faccia deve superare per farci trovare la forza che ce lo fa lasciare, perché più esso si dimostra geloso di noi, più difficile è per noi rompere la relazione, e, con tale convinzione, mi mostravo geloso, sovente perfino quando non lo ero.
M'inquietano coloro che s'impongono d'essere freddi col loro partner per ostentare una irragionevole “emancipazione”, perché credo che il loro rifiuto della gelosia sia solo una scusa alla quale si aggrappano per evitare di dire la verità al loro partner, e cioè, che non lo amano più. E comunque esistono anche quelli che invece sono convinti davvero che la gelosia non sia frutto d'amore ma di egoismo. In verità la gelosia, nove volte su dieci, nasce dal “sentirsi poco amati”, e se una donna vede che suo marito è geloso, non dovrebbe cadere nel tranello di confutare la sua eventuale stupidità, ma porsi questa domanda: “riesco a farlo sentire amato?”
Chi non è geloso non è interessato.
Dunque, che fossi geloso era vero. Non sono mai stato un campione nel temperare malizie, anche se non credo che questa sia una mia rinfacciabile colpa. Il nostro Dubbio, che in altre discipline del-la vita è chiamato “esser cauti”, è la sola campana di vetro dentro la quale possono sopravvivere gli Amori, che altrimenti si troverebbero come canne al vento, vittime, come i Tempi, di ciò che spesso cambia. La Fiducia c'entra poco con l'Amore, e non si può certo dare gratis. Non è un vuoto a perdere. Non ci si fida mai perché si ama, ma perché ci si rende conto di essere amati. Tutto è una dimostrazione continua, non v'è niente di vero a priori. Chi fa credito della propria Fiducia senza sapere nulla di certo è destinato ad andare incontro alle delusioni. La Fiducia è la Pietra Tombale dell'amore.
La rabbia che quelle occasioni mi facevano affiorare mi costringeva a ripromettermi, con me stesso spergiuro, che la prossima volta sarebbe andata diversamente, o che “questa gliela avrei fatta pagare”. Non c'era nulla di più falso.
Quando il giorno dopo la rivedevo e dissimulavo ostentatamente arrabbiatura, bastava un suo semplice gesto, che fosse un bacio o, ancor meno, uno splendido sorriso, per farmi dimenticare tutto. Lei, per qualche tempo, tornava ad essere “la mia Marta”, non avendo occhi che per me.
Com’erano dolorosi tutti quei dubbi! E com’era doloroso quel sentore che mi convinceva di quanto io fossi per lei soltanto un palliativo, un riempitivo, una scusa per far passare il tempo, e che in fondo Marta sperasse di conoscere qualcun altro.
Per me questo solo fatto, cioè che lei non mi considerasse degno di essere l'uomo della sua vita, era un dolore cocente che mi straziava il cuore, e anche oggi, quando, pescato chissà dove, mi ritorna in mente, mi fa montare un'ira furiosa tale da rovinarmi la giornata. Chi si credeva di essere?
Non è un caso vedere oggi donne sposate, anche di trenta o quarantanni, mandare “a ramengo” il loro matrimonio solo perché invece di esser state guardate da due o tre uomini, come solitamente gli succede, un giorno vengono fissate da quattro o cinque. Tanto basta per illuderle d'essere preziose, troppo preziose, per “quell'inutilità di uomo” che hanno sposato. Questo dimostra che la vanità, come ogni altro difetto, non è una cosa innocua. Certo, non tutte sono fatte così, ci sono anche quelle che adorano farsi guardare ma che non hanno intenzioni che non siano limitate al compiacimento, il problema, però, è che noi non possediamo strumenti in grado di trebbiare le une dalle altre, e questa impossibilità ci spinge a diffidare di ogni loro gesto e momento della giornata.
Esattamente come io diffidavo di Marta.
Qualche rara volta, prima del fattaccio, cercavo di convincermi che quel genere di situazioni che subivo e che soffrivo, la sua mania di guardare gli altri uomini, i suoi scherzi inopportuni, il suo pressappochismo quando parlava della nostra storia, e il fatto che mi escludeva sistematicamente dal suo futuro, fossero il giusto salario da pagare alla sua bellezza. Questa effimera convinzione, tuttavia, non poteva curarmi più di tanto il cuore, perché, a pensarci bene, capivo d’aver raggiunto il “punto del non ritorno”, e mi rendevo conto che se mai ci fossimo lasciati avrei dovuto recuperare la mia vecchia vita, vita che a quel punto giunti sentivo estremamente estranea.
Consideriamo tale la bellezza quando ha a che fare con noi, è il desiderio di mettere in relazione con noi qualcosa di esterno che ci è particolarmente piaciuto. Se c'innamoriamo di una donna è perché riusciamo ad inserirla nel nostro immaginario di vita a due, e vediamo in lei un futuro luogo comune che è in grado di riempire le nostre nuove abitudini rimuovendo le vecchie. La delusione non è data che da un principio d'illusione, e forse quello che ci fa più male quando una storia finisce non è tanto la perdita di quei nuovi luoghi comuni, per i quali così ansiosamente avevamo faticato per far diventare nostri, quanto la costrizione di dover fare la pace con i vecchi.
Assai di frequente pensavo a quanto fosse inutile e stupido innamorarsi. Soprattutto di ragazze conosciute in un certo tipo di locali. Avevo sempre pensato che l'amore sincero, vero, fosse una cosa meravigliosa, oggi sono convinto che non sia sempre così. Ma si sa, come in passato anche nel prossimo futuro le nostre convinzioni non saranno altro che quel veicolo che ci rende alienata e alienabile la realtà, ben misera consolazione per la storia delle nostre vite.
Marta diceva di amarmi, ma, sono sicuro, il suo amore non era uguale al mio, e questa disparità in un rapporto di coppia può essere determinante per decidere equilibri e durata di un amore. Lei, questo lo capii a mie spese, durante il giorno poteva fare a meno di me. Io, quando non ero con Marta, altro non agognavo che di vederla. Era proprio un bisogno fisico, la necessità di appagare e calmare i miei doloranti sensi; vista, tatto, olfatto.........……………….
Niente al mondo era più importante per me che guardare Marta, baciare Marta, abbracciarla forte e farci l'amore. Il problema era che lei non sembrava dello stesso avviso.
Per capire lo spessore dell'amore che la nostra donna ci porta, dovremmo chiederci più spesso cosa sarebbe disposta a fare per noi, e se non scorgiamo risposte in arrivo, tentare di abbassare il livello d’importanza del rapporto.
Talvolta Marta diceva che l'amavo come un ragazzino, che l'amore che le volevo rasentava l'idolatria adolescenziale, un possessivismo e un egoismo da pena di morte.
Oggi so con certezza che la vera bambina era lei.
Sempre attenta agli sguardi degli altri uomini, spesso sfoderava quel tipo di vanità furba che non compromette completamente, ma che da sola basta a farci capire di aver a che fare con una megalomane, una sfrenata esibizionista disposta a tutto pur di farsi notare. In quegli istanti questo suo passeggiare in quelli che io ritenevo, e ritengo, difetti, me la sviliva compiutamente. Il suo ricamare di-scorsi di scuse con l'uncinetto, me la faceva odiare. Anche la sua vanità non era così palese come quella, per esempio, dei miei compagni del gruppo, ma era comunque abbastanza per cercare quell'autocompiacimento che l'attenzione di “terzi” poteva darle.
Proprio ciò che odiavo di più al mondo.
Per crearsi una vanità propria da spacciare per qualcos'altro e consona alle aspettative altrui (quel che pensiamo gli altri si attendano da noi), è necessario trasformarsi in registi di noi stessi, considerare la scenografia, i costumi, studiare attentamente la sceneggiatura della commedia che vogliamo mettere in atto, che bramiamo allestire.
Marta pareva non aver lasciato nulla al caso, neppure i movimenti o le battute impreviste. Era abilissima ad improvvisare, che fosse un gesto con la mano o la scusa per attraversare la sala di un locale indossando così i panni di “prima donna”.
Io subivo. Subivo perché non avevo in me quella determinazione che mi avrebbe consentito un gesto risolutore. Ciò che meno mi aspettavo, cioè che quella determinazione arrivasse da fuori, da un fattore esterno, da un episodio nel quale la mia responsabilità, che fosse per meriti o per colpe, era alquanto limitata, avvenne.
L’IMPORTANZA DI ESSERE ARTISTI
I.
Per tutto il periodo in cui stavo con Marta continuammo a suonare. Finalmente avevamo deciso di fare qualcosa di “nostro”, ed il tempo che perdevamo in sala a provare aveva cominciato ad avere qualche senso. Non suonavamo perché volevamo incidere ed avere successo, anche se in questi casi è meglio parlare per sé stessi.
Passavamo giornate intere a tirare su dei “pezzi”, a costruire, a creare. Eravamo combattuti su quale genere di musica buttarci. I gusti erano molto diversi fra loro.
C'era chi amava la robaccia che facevamo di solito al locale, e chi, attirato verso quel tipo di originalità moscia, voleva diventare il Peter Gabriel o lo Sting del Terzo Millennio. Io e Maurizio volevamo fare davvero qualcosa di nuovo, anche se in musica ormai non s'inventa più niente. Così, per i primi Tempi, altro non riuscivamo ad eseguire che un qualcosa di ibrido che conteneva i gusti di cinque individui. Era chiaro, se volevamo fare musica che potesse piacere dovevamo scegliere cosa tenere e cosa scartare.
Ci furono un paio di mesi di lotte interne al gruppo nelle quali, come cani che pisciano su più ruote possibili, ciascuno di noi tentava di delimitare il proprio territorio. Pochi erano disposti a cedere su quelli che chiamavano “principìi musicali”. Per esempio.
Alessandro era davvero poco propenso a fare del jazz o dell'etnica. Lui voleva avere la possibilità di cantare qualcosa che ammaliasse le ragazze. Non voleva sentir parlare di Pat Metheny o degli Spyro Gyra. Per qualche tempo io e Maurizio riuscimmo a convincere gli altri di poter fare qualcosa di molto simile agli Oregon ma con armonizzazioni che avrebbero permesso ad Alessandro di cantarci sopra, e quindi di sfoggiarsi. In pratica volevamo dargli un contentino. Ma lui non si faceva persuadere così facilmente.
Il vanitoso confonde le sue opportunità con la vita vera, e se gli sottrai il suo habitat naturale, per Alessandro il locale e tutto quel corollario di allestimenti che gli offrivano la possibilità di sfog-giarsi, egli si sente come se fosse in cattività. La tentazione di “sventolarsi” è un po’ simile a quella che prende gli appassionati del tavolo verde; più si guadagna più vien la voglia di continuare a giocare.
Tirammo su diversi pezzi, alcuni dei quali abbastanza buoni, usando tutte le tecniche che sapevamo; dissonanze, salti, stacchi, sincopato eccetera. Durante i concerti riuscimmo ad inserirne alcuni, ai più sconosciuti, che ci appagavano sia artisticamente (per me e Maurizio era così) che moralmente. Erano “movimenti” dei Montreaux, alcuni di Nando Lauria e di Tuck and Patty. Presto mi accorsi che i miei gusti mi rendevano troppo lineare, scontato. Diedi un’occhiata, e mi resi conto che le mie svise erano tutte in LA e in SOL. Sorrisi. Era proprio la semplicità di cui accusavo i gruppi che non mi piacevano. Così tentai di cambiare il mio modo di suonare, e ne ricavai alcune soddisfazioni.
L'unico problema era la miseria che il nostro pubblico rappresentava come “ascoltatori”. La gente che veniva nei locali dove suonavamo era considerata dai gestori come una preda. Dovevamo fare Vasco Rossi perché così quegl'imbecilli bevevano Tequila e Whisky, consumazioni che costavano di più. Vasco ti do un consiglio; fatti pagare. Non solo dalla SIAE per i diritti, ma anche dai produttori di liquori.
In quel modo ridotti, solo pochi individui riuscivano ad apprezzare quel po' po' di sforzo che facevamo. Ben presto capimmo che quei pezzi non potevano monopolizzare la serata, e fummo costretti a ritornare dalle parti di Sting, Peter Gabriel, Queen e Beatles. Non c'era nulla di più frustrante. Mi sentivo una bagascia di quelle da cinquemila lire la botta. L'Arte è prima di tutto “creazione”, e se esegui sempre cover, “roba altrui”, non puoi dirti artista.
Fu in una serata come tante che la fortuna, veramente cieca in quell'occasione, venne a sbattere il muso su di noi. Era un Venerdì e il locale era semi deserto. Così iniziammo a suonare quel che ci garbava. Nel pubblico di quella sera, sagacemente occultato, c'era un misterioso personaggio. Non lo avevamo mai visto. Era un amico del barista, e per tutta la sera non fece altro che osservarci. Beveva seduto ad un tavolo con accanto una ragazza che poteva essere sua figlia.
Quelle donne belle che stanno con uomini vecchi o brutti ma ricchi e famosi, vedono in loro l'emanazione fascinosa di una vita segreta il cui santuario vorrebbero violare. Sanno che con le sue possibilità, che poi sono soldi e conoscenze, potranno appagare più facilmente la loro Vanità, e sconsacrare il Santo dei Santi di quella celebrità e ricchezza uscendoci insieme, è un modo per impossessarsene. Naturalmente non è gratis, anzi, dovranno offrire quale olocausto la loro bellezza, la loro giovinezza, e quella naturale propensione, che hanno le belle donne, verso i maschi che dovrebbero essere di loro “competenza”; belli, alti, magri, artificiosamente abbronzati, ignoranti quanto basta, glabri come il culo di un bambino, anabolizzati di mestiere, “biondo scemo”, e con le mandibole giuste e i denti bianchi.
Non vorrei essere nei panni di quei vecchi riccastri, per quanto concerne le storie d'amore, perché sono convinti che l'uomo maturo “attizzi”, poverini, e non sanno che appena il santuario verrà violato con una promessa di matrimonio o di convivenza, diventeranno essi stessi dei Moloc, con le corna abbastanza grandi per appenderci degli ex voto, ma senza alcun adoratore.
Finito di suonare scendemmo dal palco, ognuno con le proprie priorità. Io e Maurizio andammo a bere al banco, gli altri, chi toccandosi i capelli fingendo di metterli a posto, chi gesticolando per darsi importanza, chi sostando pomposamente nelle scalette approfittando del palco vuoto, vagavano per il locale mettendosi in bella mostra.
Pareva di essere nel “quartiere rosso” di Amsterdam.
Le Vanità non sono tutte eguali, perché gli orpelli con cui ci si adorna sono esche precise per precisi individui. Alessandro non tentava di ammaliare con le stesse armi di Enzo, perché l’uno rivolgeva le sue attenzioni alle bimbette speranzose d’incontrare un “moderno Principe Azzurro” (alias un elettrocalamitato travestito da rock star umanista e perpetuamente solidale), e l’altro voleva far colpo su ventenni da centro sociale occupato il cui massimo sono quei rockettari vestiti di pelle che ai concerti vomitano addosso ai loro fans. E diversi obiettivi aveva Giacomo, che, convinto di emanare un fascino intellettuale (questa del “fascino intellettuale” non l’ho mai capita. Ci sono donne che leggono un libro e, trovandosi di fronte ad una bella frase, non s’innamorano delle parole ma di Colui che le ha scritte. E’ come se una donna che a letto fate im-pazzire di piacere, invece che innamorarsi di voi s’innamorasse di vostro padre), corteggiava, naturalmente senza darlo troppo a vedere, ragazze universitarie di quelle che in meno di due ore sono in grado di progettarti un ponte lungo cinque chilometri, ma che se le chiedi dov’è nato Garibaldi non lo sanno.
Ultraspecializzazioni. Fra non molti anni faremo la fine dei dinosauri.
Credo che l'unica differenza che c'è fra la vanità maschile e quella femminile, sia solo nelle opportunità che hanno i possibili obiettivi. Una donna che va con un bell'uomo che si sfoggia, sente un rimorso maggiore di quello che provano gli uomini che vanno con le vanitose, perché sa di aver ribaltato un concetto di cui il sesso al quale appartiene dovrebbe esserne il beneficiario. Sono poche le donne disposte a pagare un uomo per andarci a letto, e questo succede perché nell'immaginario collettivo sono loro a dover rappresentare la preda che trasmette desiderio. La donna che si fa conquistare da un uomo vanitoso, dopo aver fatto l'amore con lui, soffre di un ine-narrabile senso di colpa trasmessogli da un altrettanto inenarrabile complesso d'inferiorità, e questi stati d'animo non si colmano con l'emancipazione. Non c'è niente da fare.
La verità è che una donna ha insita nella propria natura sessuale la necessità di sentirsi desiderata, cosa di cui gli uomini possono fare benissimo a meno, altrimenti non vedremmo dei vecchi riccastri sposarsi con ventenni bellissime che sono eternamente alla ricerca di “qualcosa di meglio”.
Una volta scesi dal palco io e Maurizio ordinammo due Negroni. Fu allora che il suddetto signore, seguito da cagnolino in minigonna “spaccata”, raggiunse il nostro tavolo e chiese il permesso di sedersi. Ingombrava elegante l’area che occupava, con un paio di brache grigio chiaro di frescolana e una camicia nera a maniche corte. Non portava cravatta, e la giacca era da lui maltrattata, stretta nella mano sinistra e tenuta all’altezza della coscia. Le sue mani erano grandi, addirittura enormi. Il suo viso era paonazzo, quasi da beone, e veniva reso dolce dagli occhi azzurro chiaro, che in quel “quadretto” ornato da capelli bianchi davano al tutto un’espressione pacata e saggia. Era di corporatura robusta, anche se asciutta, e il suo torace carenato trasmetteva alle spalle una potenza che forse non avevano.
Qualche anno prima doveva essere stato uno “splendido quarantenne”, e oggi tentava di prolungare quella recente forma con atteg-giamenti e gesti palesemente fuori moda. Saltava agli occhi, quell’uomo era decisamente avulso dal contesto.
La ragazza invece sapeva di “hostess”. Non parlava, rideva a co-mando, beveva con la testa girata dall’altra parte, respirava allargando le narici come i pesci aprono le branchie, e ogni tanto lasciava che lo spacco della sua gonna mettesse in onda gradevoli “filmini”. Il suo viso era bianco latte, le sue mani estremamente curate, e le braccia in dotazione erano finissime. Aveva i capelli lunghi, lisci e biondi, che, per quanto erano scolpiti, sembravano tenuti insieme da una quantità industriale di lacca.
Dopo aver fatto le presentazioni, in cui disse di chiamarsi Marco Gagliardi, cominciammo subito a parlare di quel che sapevamo fare, di quello che ci piaceva e di dove avevamo intenzione di arrivare.
Né io né Maurizio ci chiedemmo chi fosse costui che s'interessava in quel modo alla musica che facevamo, ma questo fatto non era strano. In quel locale venivamo accalappiati ogni sera da qualcuno che voleva parlare di musica con noi, e così non ci trovammo nulla di anormale. Anzi, qualcosa in verità la trovammo, e non ci dispiacque; il signor Gagliardi, diversamente dai ragazzi che ogni se-ra volevano dibattere di musica, per lo meno non era ubriaco.
- Non è facile sentire il genere di musica che avete suonato stasera. - disse parlando seriamente e con lo sguardo fermo - Di solito i locali come questo sono ricettacolo di “bimbi” che vogliono gli si racconti una “vita spericolata” o la “solidarietà umana”.
- E lo dice a noi? - rispose Maurizio - Pensi che per suonare un pezzo degli Oregon, io e lui, - disse indicandomi – abbiamo dovuto sostenere un anno di battaglie con gli altri del gruppo. Fare quel genere di musica alla mano tante volte non è che sia proprio opportunismo. Molto dipende da chi hai come compagno, e spesso è proprio il genere da classifiche che ti permette di essere apprezzato.
- Sì, lo so. - disse l'uomo - Ci vuole coraggio per suonare quello che ti piace. E' questo che ho apprezzato in voi. Il vostro senso di sfida, di mettervi in gioco. E' naturale, suonando i Queen non puoi che essere apprezzato, ma nel vero senso della parola, però! Col cartellino sulla giacca. - e rise.
- Non si rischia niente. - intervenni io - E' per questa ragione che non si è appagati per nulla. Ciò che ti può dare a livello emotivo la musica che fai senza rischiare niente, è niente! Secondo i nostri compagni quello che facciamo non è arte, ma solo la possibilità di portarsi a letto qualche sbiadita donnetta. Ma di quelle veramente stupide, però!
- Vanità! - rise Gagliardi - E' normale. Non crediate che per altri gruppi o altri musicisti, anche per quelli che sono già famosi, sia diverso. Voglio dire che è più natura che situazione.
- Mi dispiace ma non sono d'accordo. - dissi - I difetti, e tanto più un difetto come la Vanità, non dovrebbero influenzarci nel nostro lavoro, e ancora meno se il nostro lavoro ha a che fare con l'arte. Mi dice lei come fa a nascere in Italia un Frank Zappa o un Pat Metheny se il clima e gli artisti che ci sono si accontentato di fare musica furbetta, che abbaglia, è vero, ma che tecnicamente non ha nulla, e che, per questo stesso motivo, dura dall'oggi al domani? Andiamo! La cultura musicale che ha preceduto gli artisti che sono rimasti nella storia della musica, quasi mai aveva a che fare con movimenti, dinoccolati e di altro genere, o con la Moda. La musica classica esiste da migliaia d'anni, e il jazz ha radici nell'etnica e nel blues, cioè in quei tipi di musica che ci viene tramandata da secoli! E poi, spesso le ragazze che “becchi” in un certo tipo di locali e per merito d'atteggiamenti precisi, altro non ti possono dare che quello che hai speso per “beccarle”: nulla.
- Va beh! - esclamò il Gagliardi - E' chiaro che non si può sperare che le storie che nascono in certi posti come possono essere i locali notturni o le discoteche, siano relazioni importanti e con un certo spessore. Comunque può accadere anche il contrario.
- Per caso, Gagliardi, per caso. - disse Maurizio.
Per un'attimo pensai che anche la mia storia con Marta era nata in un locale, e subito mi rimproverai di essermi così esposto nei confronti della mia coscienza.
Improvvisamente Gagliardi disse:
- Comunque desidererei sentirvi in privato. Faccio l'arrangiatore per una casa discografica e vorrei vedere se si può fare qualcosa.
Ci lasciò un biglietto da visita e prendemmo appuntamento per la settimana successiva, un Mercoledì. Non ci sembrava vero. Un arrangiatore s'interessava alla nostra musica.
E' divertente sapere che le confutazioni che facciamo sulle discipline della vita prendono vigore in noi quando vengono apprezzate da chi ha esperienza in materia. Oggi notiamo spesso che una questione diventa “cruciale verità” quando come antefatto o come chiusura porta la frasetta incontestabile “uno scienziato ha detto” o “uno scienziato ha fatto”.
Forse l’importanza di essere artisti è tutta qua.
Con quello stesso spirito apprendemmo l’interesse di Gagliardi nei nostri confronti. Il solo fatto che la nostra arte interessasse un individuo che si poteva ritenere un esperto, bastava a farci diventare degli artisti veri. Cademmo subito nel laccio di prenderci sul serio. Dovevamo prepararci come si deve. Presto ci saremmo dovuto im-pegnare ad un altro livello.
Quando per qualche giorno non ci vedevamo, lei tornava sempre piena di racconti o episodi con cui passare la serata a parlare, e mi faceva ridere davvero, con quelle delizie. Anche lei era appassionata di Letteratura. Non lo dava a vedere, ma si capiva che la sua non era solo cultura didattica, nozionismo. Inoltre. Era una ragazza bellissima.
Ben presto fui catturato da quella che in seguito divenne una eterna incertezza. Infatti ero combattuto e infastidito dal dubbio che il gruppo non la vedesse tanto di buon occhio. Era quanto di più distante esistesse dal loro modo di concepire l'obbligatorietà di quella nostra presenza in quel posto. Sembra assurdo a pensarci adesso, ma per gli altri del gruppo era inconcepibile il fatto che qualche donna venisse in quel locale non per farsi ammaliare da noi, ma solo per passarsi una serata senza particolari costrizioni o necessità, così, spensieratamente.
I miei amici erano abituati ad avere a che fare con le mediocrità che quell'andazzo gli procurava come unico svago, e ad aver la consapevolezza che tutto girasse intorno a loro. Gli pareva strano che al mondo potesse esistere qualcuno che non badasse alla loro presenza, soprattutto se quel qualcuno veniva dove suonavamo noi e, secondo il loro modo di veder le cose, doveva averci a che fare.
Quest'idea divenne sempre più forte in loro, tanto che si erano qua-si convinti di essere dei proprietari feudali, e che su tutto ciò che di lì passava avessero diritto di prelazione, di scelta. Una proendrìa sessuale. Non ammettevano, per esempio, che una bella ragazza andasse in quel locale e invece che “farsi fare” da uno di noi uscisse con qualcun altro che non era “un artista”. Sembra incredibile ma, anche se non era detto in maniera chiara e diretta, la situazione era proprio questa. Pareva di essere dentro un territorio di caccia esclusivo.
Ricordo che allora pensai che “il fascino della divisa” non colpisce solo le donne, ma anche coloro che suppongono di diffonderlo nel mondo. Noi, per il nostro “ruolo pubblico”, eravamo una specie di Ammiragli, Generali, Aviatori. I miei compagni erano convinti che le ragazze entrassero nel locale e, immancabilmente, restassero affascinate dalla nostra “divisa di musicisti”. Appena una ragazza li guardava loro ringraziavano il Dio della Musica. Questo si chiama “rincretinimento di gruppo”, ed ha la sua fetta di studio nelle “patologie suggestive”.
Io non me la prendevo più di tanto. Consideravo che le ragazze che uscivano coi miei compagni erano, nel novanta per cento dei casi, interessanti come andare a vedere una retrospettiva di film bulgari o dal Dentista. Quasi sempre si trattava di bimbette ambiziose che avevano capito male il nostro lavoro, e che uscivano con noi per il solo gusto di farsi additare come “ragazza del cantante o del chitarrista”. Generalmente erano mosce come bucce di banana, e avevano il tracciato nell'elettroencefalogramma piatto come un microchip. Naturalmente erano anche vanitose, e una delle disgrazie peggiori che può capitare ad un uomo (l'ho capito a mie spese) è quella di uscire con una donna vanitosa. A dar retta alla sua vanità, agli ammiccamenti stupidi fatti ad altri uomini, alle movenze ruffiane, al suo esibizionismo marchiano e spesso fuori luogo, ci si dovrebbe picchiare ogni quarto d'ora.
Se posso dare un consiglio; non sposatevi mai con una donna che si è rifatta le labbra col silicone. Quelle femmine sembrano sempre distribuire bacini a tutti, e passereste la vostra vita a far risse per difendere il vostro onore di marito da chi ha confuso un “gommato Pirelli” con una avance.
Forse era per questo motivo che io non avevo assiduamente la ragazza. Ogni tanto uscivo con una donna, ma era solo per provarmi, per constatare se piacevo ancora e se ero capace di conquistare. Anche se quasi mai la conquista che facevi si rivelava tale, sovente, però, riuscivo ad estrapolare convinzioni che mi persuadevano di avere ancora delle possibilità, soprattutto con le donne più grandi. Erano loro, infatti, a suscitare il mio interesse. Le bimbette non le sopportavo. L'unica cosa che mi procuravano erano erezioni immediate che poi, una volta che tutto era finito, scendevano inesorabilmente come la mia considerazione nei loro confronti.
Marta aveva la mia età, e se da una parte c'era il pericolo, una volta innamorato seriamente, che per la sua bellezza sia fisica che mentale in modo astuto mi tradisse, dall'altra c'era la certezza che con lei non ci si annoiava di certo. Ma forse questo era solo un ottimismo senza ragione generato dalla speranza di piacere.
Quando la incontrai per la seconda volta ( e la conobbi davvero) fece subito colpo su di me. Allora mi rimproverai quanto stupido e pieno di pregiudizi ero stato la prima volta che la vidi. Natural-mente a lei non dissi nulla, ma, inquieto, mi domandavo come mai io, che difficilmente ciccavo a considerare le persone, quella volta avevo completamente sbagliato giudizio.
Lei, quella sera, non aveva occhi che per me. Durante tutti i pezzi non abbandonò il mio sguardo che un paio di volte (che stavo già per giudicare troppe). Ero in quella fase, narrata prima, di disillu-sione forzata. In pratica non mi fidavo. Tanto più che il mio giudizio precedente sulla ragazza in questione era stato quantomai negativo. Quindi, se non altro per tenere fede alla configurazione che me n'ero fatta (questione di coerenza), non la degnavo di una seppur misera considerazione. Certo, la guardavo, ma come si guarda la partita alla Tv, o qualcosa che c'interessa ancor meno.
Ma lei insisteva. Mi guardava sorridendo e non aveva l'aria di voler litigare. La smorfia che mi aveva lasciato in eredità uscendo dal ristorante sembrava aver smarrito ogni ragion d'essere. Solo questo fatto mi permise di giudicarla diversamente. “Se non altro”, mi dissi, “non è una che porta rancori per questioni futili”.
Subito sperai che il desiderio fosse ciò che avevo sempre creduto; un sentimento che si sviluppa appena trova fonti di reciprocità, e più esso è forte più ci sono speranze che abbia trovato. Del resto l'illusione s'aggrappa a noi se trova motivo, e il motivo è dato da chi ha un principio d'illusione, ed è quindi esso stesso ragione di reciprocità. “Se non l'avessi guardata non mi sarei accorto che mi stava guardando, e così è per lei”, mi dissi.
La speranza che nutrono i disillusi è simile alla “debolezza dell'ottimismo” nella quale cadono gli apolitici e gli anarchici sotto le elezioni. Speri sempre che il tuo voto, questa volta, sia decisivo per il cambiamento. Quasi mai è così. E allora quella delusione servirà per i prossimi dieci anni a farti astenere politicamente. L'amarezza che resta è che soltanto quando tutto è finito che ti accorgi di esserci “cascato nuovamente”, e la rabbia che ti nasce dentro è ciò che presto battezzerai “disaffezione politica”. Ma questa sorta di “movimento mentale” non è così scontato in amore, perché per appagare i nostri “pruritini del cuore” siamo disposti a rimettere in gioco tutto, ogni nostro stato d'animo e ogni nostra convinzione, tanto che per appagarlo “grattandoci”, siamo in grado di sopportare qualsiasi specie di delusione.
La disillusione amorosa è una bomba ad orologeria che aspetta il consumarsi del tempo per esplodere in una pirotecnica evoluzione di passioni.
Il pomeriggio avevo litigato con Alessandro per problemi legati alla nostra musica, e lui continuava a tenermi il broncio come un bambino dell'asilo. “Sicuramente”, mi dicevo, “lei è qui su un suo preciso invito”. Non a caso era l'unico che aveva salutato.
Quando finimmo di suonare, Alessandro, insieme a tutti noi, scese giù dal palco e andò, non senza tirarsi indietro i capelli e dopo aver sostato vistosamente al centro della scena, i cinque gradini che portavano al palco vuoto, al tavolo di Marta. Io posai la chitarra e mi avviai verso il banco, dove molti volevano offrirmi da bere. Rifiutai con grazia e, nascostamente, mi feci fare un Negroni.
Li guardavo da lontano.
L'errore nel quale inciampano quasi tutti gli inesperti, è quello di cimentarsi nelle discipline di cui non capiscono nulla esagerando le porzioni per dissimulare la loro inesperienza. Così finiscono involontariamente per non avere mezze misure e offendere o infastidire chi hanno di fronte. Del resto causa più danni un filantropo che per una volta si comporta egoisticamente, piuttosto che un egoista nato.
Alessandro non aveva il portamento di un modello, ma quello di un bamboccio da pizzicotti sulle guance e affettuosi baci di zie. Ciononostante, gesticolante e sorridente, in piedi, fingeva di parlare in modo serio, anche se non curante, proprio come un consapevole “bello”. Lei ascoltava. Pareva di essere a teatro, ma la recita del “protagonista” aveva preso un’involontaria ironia che sfocia in quel fastidio da cui non si rimonta neppure col rimborso del biglietto. Non per altro, per la pomposa importanza che lui dava ai gesti, agli sguardi tutt'intorno, quando salutava ostentatamente qualche inutile personaggio che poco distante passava, nonché alzando il tono del-la voce non appena gli sembrava di dire qualcosa di originale.
Quando arrivava il momento nel quale si costringeva, senz'altro violentandosi, ad ascoltare, assumeva una posizione da “fermo-immagine”, rigidamente dinoccolata, alla maniera dei neri d'America, con una gamba piegata e l'altra diritta, una mano sul tavolo e l'altra sul fianco, tenendo la testa leggermente reclinata, e modellando il suo volto mellifluamente, facendolo diventare da angioletto, simulando una condizione paradisiaca falsa e ributtante.
Certamente stava usando quel tempo di forzato silenzio per pensare qualcosa di originale da dire non appena Marta glie ne avesse dato l'opportunità. A parta Maurizio, gli altri tre del gruppo, a distanze pressappoco regolari, facevano lo stesso.
Credo fermamente che soltanto in rari momenti si possa davvero afferrare il significato che il vocabolo “Vanità” ha. Infatti non sono le azioni clamorose a farci capire le inezie che riguardano questo difetto, ma più quelle nascoste, che nessuno nota. Magari una mezza frase, una parola, un gesto, l'esser colti da un amico a fare qualcosa di poco chiaro nei suoi confronti, il cercare, anche velatamente, di mettere qualcuno in cattiva luce agli occhi di persone che invece lo tengono in grande considerazione. Sono queste le occasioni in cui ci accorgiamo di essere uomini di scarso valore, perché non diamo vita a queste meschinità per sopravvivenza, ma per Vanità, per essere “riconosciuti” più belli e intelligenti di altri. Non sono i furti o gli omicidi, le “tammurriate” o le frasi urlate che ci fanno scoprire lo spessore degli individui, ma i loro comportamenti nascosti. Un vanitoso può sfoggiare il suo esibizionismo lavorando in Comune, allo sportello dove si rifanno le Carte d'Identità o gli Stati di Famiglia. Non servono le folle per dar sfogo, e quindi sottoporre gli individui, alla nostra Vanità, bastano soltanto due persone, magari una sola, che particolarmente c'interessa e sulla quale vogliamo far colpo. In effetti una recita vanitosa non ha come obiettivo la collettività, ma, fra questa, un’unica persona.
Stavo per attaccare il mio Negroni quando Alessandro, sempre tenendomi il broncio e dopo aver tentato di tutto per rovinarmi la piazza con la sua amica, venne a dirmi che Marta voleva che an-dassi al suo tavolo. Lo guardai mentre conquistava il palco fingendo di mettere a posto il microfono, col suo passo claudicante, sincopato. Fece quei gradini come se fosse Wanda Osiris.
Risi. Risi di gusto.
Non era una di quelle serate in cui sentivo, più che in altre, il bisogno di prendere le distanze dal mondo, quindi accettai e raggiunsi il tavolo di Marta.
C’aveva messo i gomiti sopra, e con le mani aperte si teneva il mento. Mi guardava, mentre mi avvicinavo, con un vago sorriso sulle labbra, e i suoi occhi, che la volta prima avevo confuso con un paio di telecamere di quelle usate per spiare gli impiegati mentre sul posto di lavoro oziano o si fanno gli affari loro invece che darsi da fare, quella sera luccicavano come lampioni di fine ottocento intenti ad illuminare accidiosamente i lastrici azzurri e pallidi. Non mi ero affatto sbagliato, la prima volta, confutando i suoi capelli. Parevano avere una vita propria, e si muovevano anche se lei teneva la testa ferma.
- Mi stavo chiedendo - iniziò - come certe persone possono cambia-re, anche d'aspetto, quando sono lontane da particolari eventi come possono essere le feste di compleanno. Come stai?
- Credevo di averti offesa in qualche modo. - risposi io in soggezione.
- Ci vuole ben altro per offendermi. L'importante è sapere con chi si ha a che fare, e voi quella sera eravate troppo ubriachi per poterlo rivelare appieno. Se non ricordi il mio nome, io sono Marta.
- Gianni, piacere. - dissi stringendo non troppo forte la sua mano.
- Davvero ti diverti a fare quello che fai? - mi chiese.
- Intendi dire a suonare? – risposi chiedendo.
- Beh, vedo che sei un ottimista. Se quello lo chiami suonare allora sì, a suonare. - disse piegando la testa da una parte come solo le donne sanno fare.
Sorrisi in modo che nelle mie intenzioni voleva essere simpatico, ma che da sé, probabilmente, aveva preso strade che non mi appartenevano.
- Ma i Queen non sono malaccio come si dice in giro. - non lo diceva quasi nessuno - Sono famosi. - continuai cercando di ostentare convenzionalità, campo in cui se non primitivo ero davvero alle prime armi.
- Certo. Anche l'Aids è famoso, ma non vedo perché dovrei averci a che fare. - rispose lei finendo in un sorriso che piano piano divenne scrosciante e rumoroso.
Avevo iniziato male, si capiva. In certi casi è sempre meglio essere sé stessi, senza cercare inutili e anemici compromessi che possono farci apparire democratici e tolleranti fuori luogo, senza un proprio pensiero, nudi. Stavo facendo la figura dell'invertebrato, senza spina dorsale.
- Presento una mozione. - dissi alzando un dito.
- Parliamone. - rispose lei ridendo.
- Comincio da capo?
Marta sorrise bonariamente, come una mamma italiana.
Perché c'innamoriamo di una donna molto spesso basta che lei ci dia del “tu” guardandoci negli occhi, sovente che gli scappi un po’ di forza in più quando ci stringe la mano, e quasi sempre che trattenga il suo sguardo su di noi per qualche secondo più del necessario.
Subito cadiamo nella tentazione di prendere tali gesti e trasformarli in simbolismi che non vediamo l'ora di reinterpretare con la convinzione d'esserne stati i protagonisti. Può darsi che, in questa veste improvvisata di esegeti, ogni tanto ci vada bene, ma a volte il “tu” che ci ha dato è perché pensava di conoscerci già, la forza che ha messo nel stringerci la mano è solo una forma di educazione e di rispetto, e lo sguardo del quale noi ci credemmo oggetto, era solo mira sbagliata, strabismo o l'essere assorta nei propri pensieri.
Tornato al banco ordinai un altro Negroni, che scolai in un batter d'occhio. Dopodiché mi avviai verso il tavolo dove lei, col ditino alzato, prometteva falsi rimproveri.
- Il guaio di questo replay, - disse appena giunsi nei pressi del treppiedi - è che mi sono dimenticata cosa ti avevo chiesto. Peccato, me l'ero preparato così bene....……………..
Ridemmo. Ridemmo per gran parte della serata. Ma non di quelle risate fatte per obbligo o educazione, ridemmo di gusto. Io, un paio di volte, dovetti alzarmi per continuare a suonare, ma quando ritornavo al suo tavolo ritrovavo verve e comicità. Neppure l'inno nazionale, quella sera, mi avrebbe schiodato da quella sedia, d'accanto a lei.
L'autocompiacimento che Marta mi provocava mi faceva star bene, e cercando di rinnovarlo, con domande volutamente stupide, con occhiate intense e prolungate, con lusinghe datate e fuori tempo massimo, con atteggiamenti e galanterie che non avevano nulla del secolo ventunesimo e che si prestavano come antefatto ad un infe-rente ed obsoleto baciamano, speravo che quella serata non finisse mai.
Continuammo a bere e scherzare fino a che non ci ritrovammo tutti e due abbastanza ubriachi da dimenticare che in quel posto non ci si poteva comportare in quel modo, che quel genere di goduria e di divertimento andavano presi sottovoce, quasi in silenzio, nessuno avrebbe dovuto accorgersene, soprattutto i miei compagni.
Loro erano degli abitudinari. Se qualcosa doveva cambiare volevano saperlo con giorni d'anticipo, come per le canzoni avevano bisogno di una “scaletta”. Dovevano prepararsi, avvicinarsi a piccoli passettini, facendo largo uso di luoghi comuni, come un tossicodipendente, scalandosi le dosi di droga, si disabitua all'assuefazione. Inoltre. Loro, come veri “artisti”, non si sprecavano in quella maniera, non si davano così completamente. Erano sempre distaccati quanto basta, anche se falsamente simpatici, da poter dissimulare, in maniera voluta e ostentata, cittadinanza in un altro pianeta. Ecco, si comportavano da marziani. Inarrivabili. Mentre invece erano solo dei ragazzotti stupidi e vanitosi che suonavano in uno scalcinato locale a centomila lire la sera.
Ma bisognava capirli. Soltanto là dentro erano a loro agio e si sentivano qualcuno, mentre nel resto delle loro giornate ritornavano ad essere degli individui mediocri, che come tutti erano soggetti agli strani sconvolgimenti del tempo, dei governi, dei mercati. Infatti, fuori da quel locale e dal loro “ruolo” di musicisti, nessuno li notava.
II.
La svolta, se così si può chiamare, venne un giorno in cui io e Maurizio trovammo, in un bar non distante dalla sala dove provavamo, il coraggio di farci le nostre ragioni. Affermammo, in maniera forte e categorica, che eravamo stufi di suonare soltanto “merdate”, che avanti di questo passo non saremmo mai approdati a niente.
- E va bene! - disse Alessandro a Enzo e Giacomo – Facciamoli contenti. Altrimenti crederanno davvero di essere dei perdenti a vita e tenteranno il suicidio.
Così ci concessero di scegliere quasi la metà dei pezzi da fare sull'intera scaletta. Come mia madre che, sapendo che a me piacciono soltanto le caramelle alla frutta, comprava sempre quelle alla menta (“così durano di più”, diceva pensando di farmi, e di farsi, un favore), allo stesso modo loro, piuttosto che sciogliere il gruppo, e quindi uccidere un sogno, lasciarono decidere a noi le canzoni da suonare la sera.
Frustrare i propri veicoli di piacere dev'essere un po' come accettare il contraddittorio; una forma di castrazione.
Anche la cocciutaggine è un brutto difetto, e ancor più brutto diventa se l'applichiamo ai vizi che abbiamo, e, fra questi, quello di non riuscire a considerare i propri difetti. Considerare seriamente i propri difetti è un atto di estremo sadomasochismo, è come esporsi volontariamente al pubblico ludibrio.
Quelli che meno di tutti riescono a far questo sono i vanitosi (quindi Alessandro, Giacomo ed Enzo), che nella presunzione di saper nascondere la propria vanità arrivano addirittura a convincersi di non avere difetti. Se ci fate caso noterete che un vanitoso, per quanto disposto sia ad ammettere i propri difetti, non si troverà mai d'accordo con voi sulle pecche che avete visto in lui. E' come andare in Comune a chiedere un certificato; lo sportello è sempre un altro. Certo, “lui ha dei difetti”, ma non sono sicuramente quelli che voi avete creduto di vedere.
Io e Maurizio scegliemmo tre pezzi di Peter Gabriel, tre di James Taylor, due di Pat Metheny e uno di Frank Zappa. Non erano pezzi che si potevano suonare in quel locale, ma i patti son patti. Così iniziammo a prepararli in sala. I pezzi di Gabriel e di Taylor non furono difficili da tirare su, e nemmeno “Last train home” di Pat Metheny. Più difficoltosi del previsto si rivelarono “Third wind” di Metheny e “Evil Prince” di Zappa. Comunque, alla fine, più o meno, riuscimmo a riprodurli fedelmente.
La volta in cui decidemmo di suonare i nuovi pezzi nel locale era un Venerdì, la serata nella quale potevi permetterti di uscire dai binari consueti. Facemmo tutti i nuovi pezzi, e, io e Maurizio, ci divertimmo parecchio. Non c'era molta gente, ma facemmo prevalere l'ipocrita scusa secondo la quale “meglio pochi ma buoni”. Certo, sapevamo che la serata dopo, il Sabato, non sarebbe stata la stessa cosa. E infatti fu così.
Quello era il giorno nel quale avevano la libera uscita ragazzine e ragazzini che volevano sentirci suonare i soliti Queen, U2, Jovanotti, Vasco Rossi eccetera. Per quei “liceali in vacanza” quella era musica che loro consideravano “cult”. A noi non restava altro che eseguire e subire. Naturalmente solo io e Maurizio subivamo le forzature del mercato, perché gli altri erano “nel loro”. Alessandro poteva atteggiarsi come una vecchia checca in andropausa che cerca soltanto il martirio, Giacomo, il batterista, sollevato dal dover venire dietro a me e a Maurizio (doveva suonare tutta la sera in quattro quarti) si riposava dalla faticaccia del giorno prima, ed En-zo, il bassista, incazzato perché completamente sano il Venerdì, quel Sabato poteva sbizzarrirsi con Negroni e Glen Grant poiché la tecnica di quei pezzi non richiedeva uno sforzo particolare che non fosse il “ton-ton”.
Il Sabato avrei fatto di tutto per restare a casa. Qualche volta sono riuscito a darmi malato, ma siccome suonavamo anche la sera prima, non potevo farlo spesso perché avrei finito con lo smarronare. E poi quei soldi, benché pochi, mi servivano. Gli altri invece sembravano contenti. Non avevano la premura di piacersi prima che piacere, e non sentivano, come la sentivo io, l'eterna urgenza di smentire la critica cittadina. A loro bastava poter bruciare vanità, partecipare a quel grande circo comicamente megalomane e narcisistico al quale il ruolo di modelli avventizi, a cui si sottoponevano volentieri, li costringeva. Per nulla ripugnati, continuavano ad andare avanti in quella mistificazione dell'arte, della nostra arte, che erano ben felici di propugnare agli ignoranti spettatori.
Comunque, in quel periodo, niente era più lontano dalla mia testa della preoccupazione di cosa pensassero di noi quelli che capivano di musica. Marta mi aveva lasciato il suo numero di telefono la sera che per la seconda volta la conobbi, ma, completamente ubriaco, ero riuscito nell'incolpevole intento di perderlo.
Non sapevo come fare per ritrovarla. Alessandro, ovvero l'unico ponte verso quella tanto agognata casualità da me un po’ ingenuamente creduta Amore, non sapeva né dove abitava né il suo numero di telefono. Solo allora mi disse che lui non la conosceva più di tanto, che era solo una amica di sua sorella, una sua vecchia compagna di Liceo. Anche se non lo davo a vedere, ero disperato. Come una novella Cenerentola avevo perso la mia scarpina. Semmai fosse stata la mia scarpina.
Che ridere. Non è certo una svista asserire che negli “ovvero” nuotano le realtà come nel mare dei “semmai” affogano i veri intenti.
Mi sentivo amareggiato, deluso, dimenticato, e la consapevolezza che Marta, presumibilmente, non si rendesse neanche conto dei dolori che mi stava procurando, mi lasciava in uno stato d'acèdia retorico e fastidioso. La lontananza non è la fine di tutto, perché il saperci pensati può annullare la materiale distanza. Nel mio caso, però, non v'era nulla di preciso, di certo, e il fatto di non aver approfittato di quella sera per metterle le briglie, lasciava svariate possibilità, alimentate dal mio scetticismo, che lei non mi pensasse affatto, e che fosse già abbandonata nelle braccia di altri cento. Si sa, “la gelosia ha tante facce quante sono il numero delle cause incerte che la fanno nascere in noi”, scriveva Proust. In quei pochi giorni avrei voluto sapere Marta con un ragazzo ben preciso, con nome, cognome e indirizzo, sul quale poter lanciare improbabili anatemi, piuttosto che non saperla sola e quindi con un imprecisato numero di amanti senza volto molto più difficili da sconfiggere.
Anche se ero sicuro che lei presto sarebbe tornata in quel locale, avevo comunque l'ansia di rivederla. Ero conscio di non esserne innamorato, almeno, non ancora, ma la sua presenza mi procurava quella leggerezza al cuore che gli adolescenti sentono davanti alla loro ragazzina. Mi piaceva questo stato, e cercavo di galleggiarci il più possibile. Il problema era che una volta provato ciò che io ritenevo essere “il massimo” non avevo alternative che non fossero quelle di cercarla o di suicidarmi.
E' strano quel che succede ai nostri corpi quando una persona con cui sei stato particolarmente bene sparisce e non si fa più vedere. Ci sembra quasi che quell'intruso, di cui noi in così poco tempo già sentiamo di non poter fare più a meno, ci abbia felicemente spostato le nostre cose consuete, e che le abitudini alle quali una volta eravamo attaccati tornino spocchiosamente ad ingombrare la nostra vita, strappandoci il nuovo scenario proprio mentre stavamo entrando in simbiosi con lui. Le odiamo, allora, quelle cose consuete, e sentiamo perfino di poter rinunciare facilmente a quella che era la nostra vita soltanto perché il nuovo personaggio, così caro al nostro cuore, fatica ad entrarvi.
Chissà per quale motivo la reazione alla mia mal celata disperazione si risolveva tutta nella tentazione di strappare i miei documenti. Forse li accusavo d'essere proprio loro a tenermi legato al mio passato, diventato così odioso per me, perché Marta non vi prendeva parte se non come sogno vago, come voglia di raggiungere la tanto agognata felicità.
Oh! come mi rammaricavo di non essere mai stato un contemplatore! Rammentavo a malapena i tratti del suo viso, delle sue labbra, la forma dei suoi occhi o la sua risata. Quante volte, in quei pochi giorni, mi sono rimproverato l'ubriachezza di quella sera. Non per la paura di aver fatto qualche brutta figura, ma perché la mia condizione di barcollamento mentale mi precludeva quell'oggi di godere, sebbene soltanto nei ricordi, del suo viso, del suo corpo, delle sue parole e del clima che si era stabilito fra noi quella sera.
In quelle poche settimane fui tentato sovente di chiudere tutto dentro il cassetto dei ricordi, ma mi sembrava di essere ingeneroso innanzi tutto con me stesso. Come potevo arrendermi e lasciare che tutto finisse, così com'era cominciato, per caso o per inerzia? E già mi dicevo che la felicità è la più immeritata di tutte le casualità.
Se bene ci pensiamo nessuno di noi, seppur felice, ha ricercato, con abnegazione spropositata, quella felicità di cui poi è stato “vittima”. Sì, perché la felicità, e quasi sempre la felicità amorosa, ci vien su dal di dentro sottoforma di tenera e dolce amarezza, un languore che ha la capacità di soffocare in noi qualsiasi altro moto del cuore e ogni coscienza, in quell’istante, d’essere felici. La vera felicità è come un atto sessuale, che soltanto nei ricordi si riesce a gustare completamente.
Quando ero lì lì per mettere da parte lo stupido orgoglio e, armandomi di zaino, bussola e ramponi, andarla a cercare, ecco che lei, così come la prima volta, mi appare, seduta allo stesso tavolino, come appare un fantasma in una nottata di vento e pioggia.
Sentii che dentro di me qualcosa sobbalzava, si muoveva, si chinava come verso chi è generoso con lei, tanto che la sua presenza in quel posto mi parve più un atto santo di misericordia che, com'era, quello prosaico di un'innamorata. “Stai buona”, dicevo a denti stretti alla mia pancia. Subito pensai che l'adempimento di una speranza fosse un chiaro segno d'intesa. Avevo sperato e pregato che lei venisse, ed era venuta. Allora mi costrinsi a pensare al Destino, all'ineluttabile, e già mi vedevo sposato con Marta e padre di tre bambini.
Mi saluta da lontano, con la manina. Io rispondo con un sorriso. Incredibilmente (quando ci si mette anche la sfiga!) stavamo suonando “Show must go on”. Proprio davanti a lei, alla quale i Queen, come a me, stanno sullo stomaco. Il guaio era che, essendo Sabato, quella era più o meno la scaletta! La solita robaccia! Ero deciso di non farmi ribeccare da lei proprio su questo punto. Così parlai a Giacomo e Alessandro minacciando di andar via se non avessimo fatto qualche pezzo della scaletta del Venerdì. Loro accettarono, di malavoglia ma accettarono. Mi esibii in “Third wind” di Pat Metheny. Che saccente! Che vanitoso! La svisa è davvero notevole, ma tutto andò per il verso giusto. Dopo aver concluso, accompagnato da pochissimi applausi, scesi dal palco e mi diressi verso il suo tavolino.
- Finalmente - disse lei appena mi ebbe a portata di voce - qualcosa di meno noioso!
- Hai solo questo da dire per Pat Metheny? - chiesi io ridendo.
- Scherzavo. - aggiunse - Avevi detto che mi telefonavi o sbaglio?
- Volevo chiamarti, ma ho perso il tuo numero la sera stessa che me lo hai dato. - risposi io cercando di essere più convincente possibile. Era vero, anche se non sembrava verosimile.
- Devo crederci? - continuò lei alzando un sopracciglio alla maniera dei doganieri sospettosi.
- Se vuoi te lo giuro!
- Calmati. Se lo dici con questa foga ci credo, - sorrise - non hai bisogno di giurarmi niente!
Non ero più tanto sicuro di non essere innamorato di lei. Tutto combaciava. Tremore, secchezza delle fauci, tachicardia, sudorazione, alterazione della vista, giramenti di testa, nausea. Mi sem-brava d'aver fatto indigestione. Lei doveva essersi accorta di qualcosa, perché mi guardava con un sorriso ebete sulla faccia. Cercai di recuperare la pacatezza che mi ha sempre contraddistinto, ma allungando una mano per spegnere la sigaretta nel portacenere, rovescio prima il mio bicchiere, poi il suo addosso a lei. Le sporco tutto il vestito, e per rimediare dico:
- Scusami, sono un imbranato. Comunque non doveva costar molto.
Lei da principio mi guarda sbigottita, quindi divertita, infine scoppiando in una rumorosa risata. Il ghiaccio era sciolto, sopra alla sua gonna, e riniziammo a parlare come ci era successo nell'occasione precedente. Di nuovo notai che nel parlare era esageratamente ricercata.
La vanità dialettica, nel suo allestimento, richiede la stessa attenzione di quella che si ha nel vestire o nell'atteggiarsi. Bisogna curare le frasi in modo da non cadere nelle ripetizioni, negli errori grammaticali, negli anacolutismi, nelle false originalità e nelle considerazioni scontate. Come quando si scrive un libro. In effetti il libro è uno sfoggio di vanità, detta “saccenza”, di chi lo ha scritto. La differenza è che lo scrittore termina di godere quando porta a compimento l'opera, mentre i discorsi del vanitoso hanno proprio nella loro conclusione il principio del compiacimento, perché il vanitoso non gode di quello che dice, ma dell'effetto che le sue parole hanno sugli altri.
- Senti, - mi disse avvicinando lentamente la sua faccia alla mia - hai finito di suonare?
- Sì, per stasera credo di sì. - rispondo.
- Bene. Allora usciamo un po', così ti riprendi.
Uscendo noto che Maurizio è nella sua auto e sta “tirando”. Coca. Qualche tempo dopo lo troverò nel bagno della sala prove con una siringa piantata nel braccio.
Appena fuori dal locale, che si affaccia sul mare, sento pervadermi dall'intimità che prende gli innamorati, quel sentore che c'illan-guidisce modellando il nostro volto e trasformandolo in quello di un perfetto deficiente.
Scivolai lentamente fra le sue labbra, come in balìa di un buco nero che tutto risucchia con la sua forza negativa. Mi specchiai nel suo viso, cosa che non facevo da anni, e mi trovai insolitamente bello. Bello come lei.
Forse quella fu una delle poche volte, assai rare nella mia vita, in cui mi sentii bene con qualcuno che non ero io. Si sa, l'Iconocla-stia ti porta all'isolamento.
Quando ripenso a quella prima volta con Marta credo che il Destino, se esiste, sia veramente beffardo. Tutti gli uomini credono che la vita, le cose, il mondo, esistano in loro funzione, e che se-guano il modello di certe macchine con meccanismi d'inerzia. Tutto va da sé, una volta innestato. Noi siamo qui a subire, inconsapevolmente, ciò che queste macchine, che sia per un caso o perché è il loro lavoro, inavvertitamente o per un preciso disegno cosmico, ci offrono. Nulla è più distante dal nostro cervello di credere che noi siamo parte attiva di tale meccanismo, che siano proprio gli individui ad innestarlo e a dar vita e indirizzo a quel che gli succede.
Quella notte feci l'amore con Marta. Lo facemmo in una camera di un albergo vicino, col trasporto proprio degli adolescenti che scoprono l'estrema duttilità dei loro corpi.
Non scorsi nessun erotismo, in quel nostro primo incontro. Tutto era congelato dall'emozione. E poi, “Erotismo”! Cosa vuol dire? Quando sei lì, in camera con la donna di cui sei innamorato, nudo, anche lei nuda, cosa c'è da erotizzare? Tutto è già abbastanza erotizzato da sé! Aiutato dalla presenza del letto, del comodino, della tappezzeria, della luce soffusa dell'abat jour, mescolata, come olio nell'acqua, a quella diffusa del giorno che penetra fra gli intervalli regolari della persiana, e che dov'essa è tirata su, in una misera striscia, riporta confusamente sul letto piatto, sulle pareti a fiori, su screpolate labbra secche, i ricami curati delle tende. Un gioco lumi-noso di sfere stroboscopiche che riflettono il clangore intontito del sesso, dell'amore. Sei indeciso, allora. Fai ruotare gli occhi, stordito. Guardi quella donna e nel pensare di prenderla ti chiedi se per caso non stai rovinando qualcosa di prezioso, un'amicizia, un amore vero. E' lì che abbassi lo sguardo e ti ritrovi spento. Il tuo desiderio non è più sudore, ferocia erotica, orgasmo, seme e capelli in bocca, ma carezze, baci, tenerezza, lacrime e giuramenti. E non vorresti più essere un uomo, un uomo al quale le tradizioni orali e letterarie impongono di prendere quella creatura di una specie diversa, che ti guarda da quel letto, a gambe larghe, col muschio del suo sesso che per te, in quel momento, non è più veicolo di piacere, ma bellezza della natura, panorama marino, barriera corallina, covo di micromiceti, ma un figlio caro, adorato, che una madre ha ricercato costantemente, e vorresti sentire le sue mani non sul tuo sesso, in quell’istante volgare organo dissacratore, ma sui tuoi capelli, carezzevoli, solide, che ti proteggono dal mondo e alle quali, senti, puoi abbandonarti fiducioso.
Come tutto è più basso nel sesso!
Purtroppo i rapporti sessuali con le donne che amiamo sono simili a quelle “via Crucis” a cui ogni tanto si sottopongono peccatori incalliti e senza rimedio; non vediamo l'ora che finiscano per tornare a fantasticare perversioni su donne astratte alle quali non dobbiamo rendere conto di nulla. Per tale motivo non ho mai comperato quei calendari che ritraggono in posizioni erotiche donne belle e famose. Irraggiungibile per irraggiungibile preferisco crearmi da me un'immagine su cui fantasticare, senza dover pagare per sfogliare ragazze la cui cellulite è “modificata a colpi di mouse”.
Per anni avevo evitato di mettermi con ragazze di cui, sentivo, potevo anche innamorarmi. Non volevo correre il rischio, come mi era successo in passato, di idealizzarle rendendomele sacre e, per questo, ridurre il rapporto sessuale ad un atto irrispettoso e dissacrante, perché quella stupida devozione m'inibiva a tal punto da farmi provare un indicibile rimorso e uno scarso eccitamento. Così uscivo solo con “smandrappate” che assumevo per una sera, per portarmele a letto, e che la mattina dopo potevo licenziare senza il rimorso per i contributi o la liquidazione. Tutto possiamo dire, ma il rapporto sessuale, per quanto bene vorremmo alla donna che abbiamo sotto, o a fianco, o sopra, è sempre qualcosa di scarsamente sentimentale, di animalesco, e con loro non riusciamo a liberare completamente la nostra libido senza avere il timore di fare la figura dei depravati, degli “eretici” che pisciano sull'altare di una chiesa, e passare poi mille notti insonni per il rimorso. Sennonché, alcuni anni dopo, veniamo a sapere che è proprio per la nostra poca depravazione che quella donna ci ha lasciati.
Comunque tutto andò bene, e ognuno di noi fu contento di quel “pranzetto consumato in fretta e furia”. Certo, la realtà di questi scambi è che sono, almeno all'inizio, fine a sé stessi. L'ultima cosa che un individuo pensa quando fa l'amore è che “si sta dando”, e questo tanto più vale quando veniamo assorbiti e intontiti dalla devozione di cui sopra (perché pensare che alla donna di cui siamo innamorati piaccia ciò che le stiamo facendo ce la renderebbe molto meno “dèa”, poco “santa”, più puttana e, per questo, meno amabile). Non si arriva mai a pensare che in verità è molto peggio, che l'inevitabile sciagura è che ci si sta mettendo in gioco. Presto sentiremo la necessità di provare e di provarci, di metterci in ballo, di capire fino a che punto amiamo e siamo amati, se la persona che abbiamo di fronte sia realmente quella che crediamo di conoscere, e non c'è niente di più falso dell'impressione che ci può fare la persona che amiamo o che crediamo di amare.
Chiaramente tutto questo lo affermo ora, ora che posso dire di essermi sbagliato. Allora non avevo le idee così chiare. Non mi mancavano certo gli spunti, qualcosa iniziai a notare già dopo pochissimo tempo che stavamo insieme.
Spesso Marta voleva convincermi della sua assoluta fedeltà, di quella che lei amava definire “coerenza”. Il guaio era che non potevo provare certe cose che vedevo sia nel suo carattere che nel suo pensiero, assai vicino a ciò che il mondo chiama “moderno”. Si può tradire anche stando chiusi in una scatola da scarpe. Talvolta le sue affermazioni mi lasciavano perplesso, e mi facevano sorgere il dubbio, già allora, di essermi sbagliato. Lei, sempre portata a convincere gli altri di essere originale, tentava di spacciarsi per “socio” di quel club inesistente che nel mondo è denominato, pressappochisticamente, anticonformismo; la consapevolezza di appartenere ad un tempo tremendo in cui ogni buon stato di coscienza, se non fa parte di quel genere di coscienza moscia, conforme al mondo, e che fa del libertarismo una forma di egoismo non troppo occulta e piuttosto furba, è considerato arretratezza o maschilismo. Come m'innervosivo per il fatto che certe cose non sono dimostrabili in senso stretto!
A sera la guardavo dal palco sorprendendola, non poche volte, a fissare non me ma uno dei miei compagni. Cosa voleva dire? Notai che quando camminava nel locale teneva il petto in fuori, sporto come un vaso di gerani su un davanzale, ed il posteriore leggermente ricurvo, in modo che si notasse.
Quando la guardavo nelle sue escursioni fra i tavoli, vedendo il suo corpo deformato come un arco da tiro, scuotevo la testa. Marta non aveva il fondo schiena fatto in quel modo, e infatti quando eravamo soli era piatto, un tutt'uno con la colonna vertebrale. Perché lo teneva così solo per strada o nei locali? Il mio cervello iniziò ben presto a rovellarsi. Era forse esibizionismo? vanità?
Cominciai ad essere nervoso.
Se un vanitoso non è capace di nascondere la sua vanità è meglio che lasci perdere e cambi atteggiamento! Come sono ridicoli quegli esibizionisti convinti che la loro megalomania non si noti, sicuri di essere riusciti a nasconderla perfettamente. Questi individui sono delle vere e proprie figure retoriche che camminano, preterizionali, paralessici, contraddizioni viventi, ossimori che respirano, e sono convinti a tal punto di apparire naturali, che la vanità con la quale martoriano la vista di chi hanno intorno sembra essere il loro fedele specchio dell'anima.
Ma anche questi si possono “scoprire”. Quando girano la testa lentamente, quando prolungano indefinitamente una nota, quando tentano di farci credere d'essere sinceri mentre sillabano le frasi e sbattono ridicolmente le palpebre, perfino quando ci ostentano eloquentemente la loro attenzione verso i nostri discorsi.
Sono certo, la Vanità è l'unico difetto che non si può occultare, e coloro che pensano il contrario sono proprio i vanitosi, che nel loro slancio interpretativo diventano l'unico esempio vivente del signi-ficato della locuzione “Segreto di Pulcinella”.
Ognuno di noi vorrebbe assicurare il mondo intero della sua estraneità di fronte ai puerili esibizionismi, ma ci capita spesso di farci coinvolgere a tal punto dalle nostre convinzioni sul nostro corpo, dall’illusoria consapevolezza ch'esso sia qualcosa di desiderabile, che il compiacimento che proviamo ci rapisce in una giostra megalomane costringendoci a rivelare la nostra reale pasta, il nostro egoismo, il nostro egocentrismo, e, più che ogni altra cosa, la nostra vanità. Ogni cosa, nel mondo, ha origine da essa o dall'impossibilità di appagarla.
Certo, anch'io, come molti, avrei voluto affermare, senza temer smentite, di stare insieme ad una persona meravigliosa, che nulla ha da nascondere perché genuina, incolpevole, sincera e vera. Ogni uomo della terra ama crogiolarsi al tepore di quella ambiziosa speranza d'aver a che fare con una donna diversa, che non ama particolarmente sfoggiarsi, ma purtroppo sovente ci rendiamo conto che se una donna di tal fatta esiste non siamo certo noi ad averla in custodia.
Presi l'andazzo di vedermi ogni sera con quella che tutti definivano, con un pressappochismo da far invidia a mormoni e bahisti, la mia donna. Ancora oggi non so se lei sia mai stata, anche solo temporaneamente, la mia donna. Quel che so con certezza è ciò che sentivo.
L'amore che portavo a Marta non lasciava il minimo spazio a considerazioni di carattere più generale e realistico. Il fatto di averla conosciuta in quel locale era completamente scomparso. Eppure, a ripensarci oggi che sono meno manipolabile, già allora era un fatto degno di nota. Io in quel posto ci lavoravo, e probabilmente, se non fossi stato spinto dall'incombenza di vivere, non ci avrei mai messo piede, soprattutto per divertirmi. Ma allora lei, lì, cosa ci faceva?
Mistero.
Marta, così mi parve all'inizio, non era tipo da facili divertimenti, e un locale come quello non aveva la forza per spingere una persona d'intelligenza media a farsi frequentare. E soprattutto un tipo come la “mia Marta”. Lei aveva la giusta visione della vita, era il classico esempio di donna che per fare una qualsiasi cosa doveva avere motivazioni precise, non era abituata a sprecarsi.
Nonostante i miei dubbi il nostro rapporto si trascinò per diverso tempo. Gli ingredienti erano gli stessi di quella prima sera. Io suonavo, e quando avevo finito scendevo e mi adagiavo accanto a lei, al suo tavolo, il più delle volte senza parlare.
Evidentemente entrambi avevamo la corda che avevamo, se tutte le possibilità discorsive che avevo visto le prime sere si erano già esaurite. In quelle occasioni pareva che un gelo d'indifferenza avesse avvolto i nostri sentimenti. Dopo qualche chiacchiera fra commensali nelle quali io rimanevo puntualmente escluso, si usciva per an-dare in spiaggia o in una stanza d'albergo a fare ciò che le coppie di tutto il mondo, più per tacita convenzione che per reale desiderio, fanno.
Anche se a me piaceva tantissimo fare l'amore con lei, quasi sempre ricavavo da quegli incontri abborracciati, soltanto eterne menzogne di lealtà, fiducia, amore.
Datemi retta, quando una donna vi ama in questa maniera scappate. I nostri rapporti erano lo specchio fedele dei nostri altalenanti sentimenti, della scarsa sincerità, della menzogna, di una fiducia ceduta “una tantum”, delle ammissioni “quid pro quod”. Un “dare per avere” paralessico, muto ma chiaro, evidente.
Quest'illusione d'amore andò pian piano scemando fino a diventare scialba, e quel rapporto soltanto un riflesso condizionato, una costrizione.
L'amata, quando è consapevole dell'amore che le vogliamo, sa con certezza che qualsiasi carognata ella ci faccia noi non sapremmo reagire che volendole ancora più bene. Quello che non sa è che accatastando carognate su carognate rende le nostre aspettative sempre maggiori. Questo, l'ho imparato a mie spese, non è un bene per noi, perché il “ritorno”, i momenti piacevoli che viviamo con lei, è sempre qualcosa d'improvviso, e quindi di scarsamente goduto, e non fa altro che aumentare le nostre sofferenze, perché, come scriveva Salomone, “chi accresce il suo desiderio accresce anche il suo dolore”.
Ma forse l'amore per una donna vanitosa è una prigione d'incertezze dentro la quale amano segregarsi certi uomini votati al martirio. La loro voglia di soffrire per amore deve trasmettergli qualcosa di vivo ch'essi non sono in grado di scovare nella quotidianità della propria esistenza, e sono continuamente alla ricerca di quel “colpo di grazia” che li convince di essere al mondo. Protraendo la relazione con una vanitosa riescono a sentirsi parte dell'umanità attraverso le pene d'amore ch'ella gli infligge, e usano quei dolori come serbatoio della loro coscienza d'esser vivi.
Credo fermamente che le ingiustizie che ciascuno di noi vorrebbe gli fossero propinate quotidianamente, debbano essere accuratamente ricercate, magari nelle file truccate agli sportelli, magari nelle altrui raccomandazioni, o forse nel chiudere gli occhi davanti ad una storia improbabile, come fu la mia con Marta. Questo bisogno di soffrire è ciò che ci rende forti di fronte alle disgrazie, alla nostra stessa morte.
Il ricordo delle umiliazioni inflittemi da Marta ancora oggi mi aiuta a campare, facendomi nascere dentro una rabbia che, unita alla delusione, mi coadiuva nell'autopropinarmi una sorta di solidarietà che riesce a confortarmi delle ingiustizie subite, passate o presenti che siano.
Ero arrivato a convincermi a tal punto d'essere senza rimedio, che l'infelicità di cui godevo presto divenne per me un’assuefazione.
Rammento che poco prima del fattaccio, quando Marta per una volta era riuscita a farmi stare bene, io, per riappropriarmi della mia infelicità, dovevo infliggermi con convinzione una specie di auto sublimazione. Faticavo, ma dopo qualche istante riuscivo a risentirmi vittima di un'ingiu-stizia.
L'amore illanguidisce. La sofferenza invece ci rinvigorisce a tal punto che se una donna ci dice “ti odio” non è raro finire per sentirsi ringalluzziti. Il nostro ragionamento pare esser questo: non ci si risponde mai “Lo odio” se prima non ci si è chiesti: “Lo amo?”
Tale sicurezza arriva perfino a perpetuare in noi un pianto che gli altri non riescono a capire; la nostra speranza di esistere, seppur odiati, nei pensieri di quella donna.
Com'è strano il mondo. Ci riteniamo dei duri, dei mastini, perché non abbiamo mai visto la Morte da vicino, sia quella Reale che quella Metaforica, e ci siamo convinti che le disgrazie accadano sempre agli altri. Ma non appena superiamo la soglia del dolore che siamo in grado di sopportare, subito ci convinciamo di soffrire ingiustamente. Non esiste contrappasso per noi. Inaspettata-mente, e chissà per quale motivo, questo fatto basta da solo a rinvigorirci. In quell’ingiustizia ci sentiamo riempiti di coraggio, quello stesso coraggio che nella normalità ci mancherebbe. Così diamo vita ad un ridicolo e retorico circolo vizioso; vogliamo sentirci vittime senza rimedio ma siamo costantemente alla ricerca di una cura, e fra queste un abbaglio, l'Amore, che riteniamo la più indolore, e che invece è assai frequentemente il principio della nostra malattia.
Di tanto in tanto avevo la tentazione di tornare a perdermi per le strade del mondo. Chi era questa sconosciuta alla quale avevo aperto le porte del mio cuore? Mi sembrava di non saperlo più. Era importante saperlo?
Oggi credo di sì, ma allora non m'importava poi molto d'essere ricambiato. Il mio amore mi bastava, mi appagava completamente. Sicuro, non era una cosa normale, e talvolta queste idee mi convincevano di non essere adatto alla “sistemazione”. Ciononostante quella provvisorietà non mi dispiaceva. Pertanto continuai la storia con quella ragazza. Non so perché. Ero innamorato, è vero, ma non senza via di scampo. Probabilmente avevo bisogno che qualcuno mi chiedesse: “Hey, ma cosa stai facendo?” Forse solo così mi sarei salvato da ciò che in seguìto accadde.
III.
L'amore che portavo a Marta mi spingeva a fare cose che se avessi visto negli altri mi sarei giurato di non frequentarli più. Avevo preso l'abitudine di chiederle, ogni volta che mi alzavo dal tavolino per andare a prendermi da bere, se voleva qualcosa anche lei. Questa mia galanteria divenne presto un suo vizio, e spesso mi scoprivo ad alzarmi dalla sedia e andare a prendere da bere solo per lei.
Esasperante gentilezza? Mah!
Non mi piaceva il suo modo di fissare le facce. Marta aveva nei suoi occhi neri la profondità sfuggente del corruttore di costumi. A sua insaputa, più per consuetudine che per intenzione, essi scrutavano nelle anime di quelli che potevano diventare dei condannati, e fra questi l'unico certo, io, la possibilità di appagare la sua vanità di donna. Pareva usare il viso degli altri come “Stele di Rosetta”, come caleidoscopio o specchio riflettente. Leggeva le espressioni facciali come uno scrittore sta attento all'inflessione vocale del critico che legge un suo libro. Forse s'illudeva di poter capire quale giudizio aveva di lei dato quel volto, ma, così mi sembrava, quasi sempre non riusciva che ad estrapolare incertezze. In questo Tempo di Grandi Omologazioni bisogna essere degli esperti contemplatori per tradurre un gesto mitico-simbolico, tanto più, quindi, per inter-pretare un naso corrucciato o l'improvviso movimento di un sopracciglio. Restava delusa, allora, e io dovevo preoccuparmi di dimostrarle che non mi ero accorto di niente.
Ero ossessivo? Forse.
Sovente, quando alcune volte subivamo la compagnia di qualche nostro amico, mi scoprii a darle ragione anche se pensavo avesse torto marcio, e, addirittura, a dirottare i discorsi su ciò che sapevo le avrebbe fatto piacere. Quando spendeva una parola d'apprezzamento per una persona che conoscevo e che sapevo assolutamente insulsa, per accontentarla ed evitare di aprire qualche pericoloso contenzioso che per ripicca sua mi avrebbe privato di favori futuri, sia di carattere sessuale che di carattere personale, mi costringevo ad essere d'accordo con lei.
Come dite? “Complicità amorosa”? Magari.
A giorni, dopo qualche piccolo litigio, tentavo di rimontare andando via pur volendo, invece, rimanere accanto a lei. La mia speranza era quella di essere seguito. Era il grido di dolore di chi è caduto nelle mani del nemico, l'Amore, e sta per essere trucidato. Probabilmente ciascuno di noi nella sua vita è già morto tre o quattro volte, in questo senso. E non se ne rammarica, intendiamoci, perché la morte, a meno che non sia quella pragmatica, fisica, universale, è sempre presupposto di rinascita, unico istante in cui davvero si sente la vita in tutta la sua concretezza. Per questo motivo molti di noi agognano soffrire, perché sappiamo che a quella “morte” seguirà una rinascita, e allora ci cerchiamo questa fine simbolica perché così speriamo di poter gustare nuovamente, e più in profondità, la vita.
Cosa spinge un uomo a ricercare quel che in realtà vuol fuggire? Forse la convinzione che la Morte, nonostante tutto, non arriverà, che il bello della vita, in fondo, è tutto qua.
Non è dunque improbabile che quel mio “andar via da lei” fosse solo la richiesta muta d'essere salvato, e in questo, sotto sotto, ancora la voglia di soffrire.
Ero diventato onomatopeista. Appena qualcuno pronunciava il suo nome o soltanto quello della strada dove lei abitava, subito sentivo un tuffo al cuore, una scarica di adrenalina che mi scuoteva il petto, la testa, e che mi mandava in ebollizione il sangue. Tutto questo accadeva nonostante la “sbadataggine” di Marta nel provarmi il suo amore.
Questa obnubilazione amorosa aveva come valida diagnosi il mio sentimento, che soffocava in me qualsiasi voglia di far considerazioni che mi avrebbero permesso di prender coscienza della con-dizione precaria del nostro rapporto. Sapevo di essere ricambiato, ma mi mancava l’inequivocabilità dei gesti, quell’esporsi completo e inopinabile che mi desse la possibilità di consolidare i miei sogni e i miei desideri amorosi cancellando qualsiasi dubbio, dubbio che nell’arco della giornata puntualmente faceva intempestive quanto terrorizzanti apparizioni.
L'ansietà del mio amore mi stava rendendo succubo di lei? O forse era quel suo centellinare coccole, ad accrescere il mio sentimento?
“Amor mi sprona in un tempo ed effrena
assecura e spaventa
arde e agghiaccia
gradisce e sdegna
a sé mi chiama e scaccia
or mi tene in speranza ed or in pena”
Quando leggevo questi versi del Petrarca il sangue mi si raggelava nelle vene. Che meschini, noi uomini! Siamo tutti figli di Laio in questo porco mondo, smaniosi di rientrare dentro quel buco nero che un lontano giorno ci esturbò.
Divenni presto inquieto, incerto se abbandonarmi, almanaccando sulle poche ammissioni d'amore che lei mi concedeva, facendomi coinvolgere completamente in quel rapporto, o, riprendendo personalmente la guida di me stesso e la direzione delle mie azioni, ristabilire le distanze fra noi.
Quei comportamenti, esageratamente “galanti”, li pagavo più tardi, quando la notte andavo a dormire a casa, e, nel mio buio, mi rimproveravo il fatto di essere troppo acquiescente ed ecumenico, cioè, proprio quel che avevo sempre evitato di essere.
La solitudine è quella condizione che spinge gli individui a fare i conti con sé stessi. L'inibizione che intorno a loro crea il mondo, folla e movimento, li aiuta a nascondere per qualche mezza giornata il loro completo asservimento all'amarezza della realtà. Restano intontiti, inebetiti. Poi, a casa, nella loro camera da letto, soli, riescono a rinfacciarsi tutto, sapendo bene che hanno una notte davanti per rifarsi l'espressione del viso e rinfrancarsi da quell'auto analisi nell'attesa quieta del domani.
Ma cos’erano tutte queste incertezze che il mio cuore faceva proprie con l’inevitabile conseguenza di farmi indicibilmente soffrire? Era dunque questo malessere l’innamoramento? Ma quel che sentivo non aveva molto da spartire con ciò che le tradizioni letterarie avevano tramandato. Questa ossessione non era uno stato permanente di oblìo dannunziano, e neppure la sensazione di vivere più del necessario. I contorni si fecero più chiari, ed io capii che il nostro rapporto era quanto di più distante esistesse da ciò che avevo ritenuto essere la felicità. Immediatamente chiusi gli occhi e impressi quei contorni nella mente, battezzandoli “Tormento”.
Un giorno, dopo aver finito di far l'amore, mentre lei era sotto la doccia, io, disteso sul letto, voltai la testa lentamente, e nello specchio rividi il mio volto. Non mi riconobbi subito, e questo essere estraneo a me stesso mi fece sobbalzare di sgomento. Nel guardare i miei occhi liquidi, limpidi come un ingenuo, il mio cuore rimase senza respiro. Fu in quell'istante che per la prima volta mi resi conto d'essere prigioniero. Più che la mia faccia, riflessa in quello specchio scorsi la certezza di un vicolo cieco, o, peggio ancora, la piccola entrata di un enorme labirinto nel quale, come in un sogno, ci si sente rapiti, e la frenesia di uscirne ci porta ad infilare una porta dietro l'altra, restituendoci come unico risultato quello di farci perdere definitivamente.
Talvolta, essendo magnanimo con me stesso, mi giustificavo dicendomi che l'amore è anche questo genere di comportamenti. Non ci credevo più di tanto, ma questo tentativo di autoconvincimento mi serviva per non mandare all'aria tutto, cosa che senz'altro sarebbe successa se avessi cercato di cambiare abitudini alla nostra relazione. Avevo sbagliato fin dall'inizio, questo lo sapevo benissimo, ma ormai l'irreparabile era stato consumato.
Mi sentivo prigioniero. Non tanto di Marta, quanto della paura di affrontare la vita da solo, senza di lei. Non perché fosse in grado di darmi eccessive sicurezze, questo non l’ho mai creduto. Ero più che conscio d'esserne innamorato, e mettere fine a quegli eterni istanti, alle sere trascorse a fissarla dal palco o a sentire la sua presenza quando andavo in giro smanioso di vederla la sera o il giorno dopo, mi sarebbe costato troppo.
Non sono uno sprovveduto, e mi rendo perfettamente conto che la sofferenza portata dalla fine di un amore, di un'illusione terminata male, non è mentale ma proprio fisica. Forse perché “quella fine” non dà possibilità di rinascita, e ti lascia in uno stato permanente di “non-morte” che ha insito in sé nessun appagamento, né della sofferenza e men che mai della felicità.
Spesso mi è capitato di paragonare la fine di un amore a quando tiravo su un giro di chitarra, una canzone, che poi, arrangiandola con gli altri del gruppo, finiva per essere stravolta e cambiare completamente significato. Vedevo quel mio pezzo masticato male, portato in giro e rimesso lì, dove tutti lo potevano guardare, completamente sfigurato. Il guaio era che, seppur molte volte poco convinto, anch'io avevo preso parte a quello stravolgimento. Una forma di “Autoinqui-sizione”.
Certo, il sentimento che proviamo per una donna ci costringe a cambiare il nostro approccio col mondo, ciò che non avevamo mai creduto possibile, ma non dovremmo arrivare a stravolgere quel che siamo, il nostro animo profondo!
Ripensandoci mi chiedo spesso se l'Amore altro non sia che il totale autoannullamento. Ci si vede nell'altro come in uno specchio, e questo ci basta. Aspettiamo che sia lui, o viceversa lei, a prendere le decisioni per noi, a dirci quello che dobbiamo o non dobbiamo fare, come ci dobbiamo muovere. Ci si autoannulla, ci si autolimita, ci s'impongono barriere che con l'andar del tempo e il perdurare delle relazioni siamo sempre meno pronti ad abbattere quando, in una proposta di lavoro o d’invito a cena, si profila l'occasione per rinnegare il nostro status di coppia. Ci si abitua addirittura a parlare al plurale, come se fossimo una Società a Responsabilità Limitata, o come quei Luminari che parlando di sé stessi dicono “Noi”, intendendo tutto il Corpo Scientifico. Certo, si può affermare, senza temer smentite, che un rapporto di coppia abbia la stessa legittimità di una Corporazione.
E' l'ansia di trasmettere agli altri il nostro desiderio, la nostra speranza di venire accettati come unica entità nella convinzione che quell'accettazione, quell'inglobamento da parte della società, dia forza e rinvigorisca il nostro amore. Così, quando la Società va in fallimento e i rancori vengono a pignorare tutte le nostre speranze e molti di quegli esili ricordi, dobbiamo reinventarci, rifondare una società a conduzione unica, magari qualcosa di piccolo, un laboratorio che non vogliamo più dividere con nessuno. Forse perché così speriamo di prolungare quella sofferenza in attesa della rinascita.
In realtà quel plurale è una sorta d'esagerata riverenza verso noi stessi, perché non consideriamo mai la nostra donna come un altro individuo, ma come quel qualcosa in più che riempie la nostra vita, che ci appartiene, un arto o una fase complementare, un messaggio in codice da decifrare per capire dove possiamo arrivare.
Purtroppo riusciamo a comprendere tutto questo solo quando l'amarezza ci ha definitivamente marchiato nelle carni, e quando la voglia di rivalsa si è impossessata di noi a tal punto che subito vogliamo trovarci un’altra donna per far pagare a lei, in un colpo solo, tutte le umiliazioni subìte da quell'altro amore finito male.
I rancori più duri a morire sono quelli che si portano per quelle ingiustizie che ci sono state fatte senza clamori, per quelle offese la cui causa è talmente confusa che non ce la possiamo prendere apertamente. Così sovente accade che continuiamo ad odiare per anni, perché o non abbiamo nulla di legittimo, e di così riprovevole agli occhi degli altri, da rinfacciare a Colei che secondo noi ci ha offesi, o quella stessa offesa che ci è stata fatta, nonostante sia subdola, ma per noi bruciante, nascosta, ma per noi presente, è tuttavia talmente inconfessabile, soprattutto da parte nostra, che ci vergogniamo di ammettere che in qualche modo siamo stati toccati, di essercela presa, insomma. Nel mio caso, non so se dir “per fortuna”, l'enormità fu così evidente che se mai porterò ancora del rancore nei confronti di Marta, cosa che non mi sembra possibile, quel senti-mento sarebbe non solo giustificato, ma addirittura inevitabile.
Quello che provavo per Marta era talmente una cosa mia da sfiorare la masturbazione. E' scontato asserire che l'amore è la più nobile forma di egoismo. Il tener conto dell'altro è fine a sé stessi. In realtà non ci preoccupiamo mai di voler bene ad un'altra persona, ma sublimiamo il rapporto con quell'individuo che vorremmo essere noi.
Anche l'amore, in fondo, è una forma di narcisismo. Ce ne rendiamo conto quando un storia finisce. Allora, e solo allora, capiamo che ciascuno di noi sta male per le proprie carenze, e non perché gli manca qualcosa che è al di fuori del suo corpo. L'amore che vorremmo dare agli altri è in realtà l'amore che vorremmo gli altri ci dessero.
Probabilmente anche con Marta fu così. Quando ripenso al suo modo di camminare, ciò che subito di lei mi affascinò, e al suo modo di parlare, entrambe peculiarità delle sue premeditazioni di “come porsi al mondo”, mi rivedo schiavo non solo di quei gesti ma anche di me stesso, della mia voglia di rivederli e dell'agonia nell'aspettarli. Mi sentivo un morente. In breve tempo, come diciamo a Genova, mi accorsi di essere “bello che andato”.
Ma Marta pareva non pensarla alla stessa maniera. I suoi “addobbi vanitosi”, seppur fosse vero che all'inizio avevano me quale obiettivo, non erano studiati in maniera d'affascinare un uomo preciso, ma esposti come “offerta gratuita” verso l'intera umanità. Una auto referenza, una specie di pubblicità della propria persona.
Come i potenti del mondo, che hanno a disposizione mezzi che gli consentono di entrare giornalmente in un delirio di sola andata, anche lei tentava di costruire un sorta di “monopolio dell'interesse”, cosa che ogni ragazza libera vorrebbe mettere in atto. Il punto era che lei aveva me, non era libera, e che il suo rappresentava un chiaro caso di “conflitto d'interessi”. Ecco, ironicamente si può affermare ch'ella si prestasse ad essere oggetto delle “attenzioni di un Antitrust”.
Che difetto immortale e pericoloso è la Vanità! Un egoista è egoi-sta quando ne ha le opportunità! E un gozzovigliatore, perché abbia la possibilità di gozzovigliare, ha bisogno d'essere seduto ad una tavola imbandita! Mentre la Vanità è un difetto che solo la solitudine può frustrare. Non v'è nulla da mostrare se non c'è nessuno che guarda. Ma in questo mondo, per trovare un po’ di pacifica solitudine, dovremmo diventare degli anacoreti e andare a vivere in alta montagna.
Mi fanno ridere quelli che si sottopongono volontariamente ad essere spiati da una telecamera ventiquattrore su ventiquattro. L'emozione che provano dev’essere un po’ simile a quella che prende gli assassini, i quali, sempre volontariamente, chiedono di essere sottoposti alla macchina della verità; la speranza e la voglia di vedere se riescono a fregare chi hanno intorno. Il rischio non è una cosa innocua: pr quegli assassini è il carcere a vita, a volte la pena di morte, mentre per gli “scopofili” consiste nell'essere giudicati globalmente. Questo non è un bene, perché i nostri comportamenti nove volte su dieci sono frutto del caso, di uno stato d'animo o di sbadataggine, e se la telecamera ti sorprende a dire una stronzata, poi non è difficile né tanto raro essere giudicato uno stronzo ad libitum.
L'unica cosa che allora speravo, nei miei ragionamenti “semi-incoscienti” d'innamorato, era che il mio fisico non si assuefacesse anche alla vanità di quella donna. Ne sarei morto.
Quando ero da solo mi sorprendevo a fare stupidi paragoni con gli altri del gruppo. Pensavo a come fossero ingenuamente semplici nell'amare. Non bisogna essere dei geni per saper dire “ti amo” alla propria donna, ma bisogna certamente esserlo per avere il coraggio di piangere quand'ella ci lascia. Come sono vigliacchi gli uomini che non lo sanno fare! Allora mi convincevo che il mio modo di voler bene a Marta fosse quanto di più intelligente esistesse sulla faccia della terra. Faceva leva sulla comprensione, sul farla sentire bella, intelligente, importante, sulle facili lusinghe, su un romanticismo esasperato e opprimente che m'illudeva d'essere un maestro nell'amare.
Oggi ho capito che ognuno di noi pensa questo di sé stesso. Il nostro modo di amare è il solo, l'unico, il più vero e particolarmente intelligente.
Sorridevo quando Alessandro mi parlava delle ragazze che aveva “conquistato”(!), che aveva fatto innamorare di lui. E ancor più ridevo quando poi queste stesse ragazze conoscevo! Giovincelle di sedici, diciotto anni, per le quali il massimo era essere riprese da una telecamera o conoscere un personaggio famoso!
Ma anch'io non avevo molto da star allegro.
Quante volte, guardandomi nelle facce della gente che veniva nel locale, mi son rivisto stupido, ridicolo, in balia di un fiume in piena. Il fiume in piena non era Marta, non completamente. Piutto-sto era l’inebetimento che quel sentimento per lei mi provocava, ero io che, assorbito dal mio amore per lei, avevo perso sia il vizio che il gusto di dire di no.
Ricordo che in quei giorni di assoluto abbandono, quando lei mi faceva qualche dispetto, io non avevo altra arma per difendermi che non fosse quella di cercare di far la pace.
Il coraggio che hanno molti uomini nel protrarre una relazione con una donna che, sanno, li tradisce, è assai simile a quello di certi scrittori libertini che scrivono la loro biografia osando mettere tutta la verità nero su bianco. Non c'è compiacimento nel divulgarla, ma solo dolore.
Intendiamoci, Marta non mi aveva tradito, non materialmente. Tuttavia il suo modo di farsi guardare mi rendeva nervoso, facendomi sorgere il dubbio che non badasse a me e fosse sempre “alla ricerca di qualcosa di meglio”.
Era furba, lei. Quando, quelle poche volte, avevo il coraggio di rinfacciarle qualcosa, metteva su un muso che mi faceva venire l'ansia di riguadagnarla al mio amore, unica cosa che per me contasse davvero. Allora cedevo, e a Marta, che mi ricattava sentimentalmente, ero sempre pronto a dir di sì. Anche se in quel tempo ancora non me ne rendevo conto, ero incapace di reagire.
Ad osservarla mi sembrava sempre smaniosa di trovare il modo per tradirmi. Non era così male, questo. Poiché se avevo ragione d'essere geloso potevo ancora trovare il coraggio per troncare quella relazione. Le gelosie senza motivi visibili finiscono in dramma.
Rammento una sera, al bancone del locale mentre bevevamo in silenzio. Fummo avvicinati da due Carabinieri in borghese. Venivano nel locale solo raramente, quando i turni glielo permettevano. Lei, che da qualche minuto stava “puntando” uno dei due, sembrava smaniosa di presentarsi. Allora si misero accanto a noi e cominciarono a parlare. Di musica, naturalmente.
L'osservavo dialogare con “l'inbanderuolato” mentre il suo collega mi teneva impegnato dicendomi quanto per lui fosse stato una rivelazione l'ultimo album di Eros Ramazzotti.
Quando si fece tardi e venne il momento di andare via, avvicinandomi a Marta ed al suo non troppo occulto corteggiatore, la sentii pronunciare queste parole. “Lo vedi? C'è sempre lui!”
Anche quella volta non risposi, e, come succede a certi codardi senza rimedio o a coloro che non hanno mai la risposta pronta, soltanto una volta a casa, nella mia camera, sprofondato nella delusione e febbricitatamente inquieto, riuscii a rimproverarmi la mia mancanza di reazioni.
Andiamo! Non potevano mica arrestarmi!
Come dite? Ero esageratamente geloso? Certo! Era l'incertezza di sapermi amato che mi faceva diventare geloso, e la mia gelosia era un modo per proteggere il nostro rapporto. Mi spiego meglio.
Quando, alcune volte, Marta si mostrava gelosa di me, il mio amore, lusingato da quella gelosia, cresceva. Era come se della sua gelosia se ne nutrisse, e io, speranzoso d'essere ricambiato, mi mostravo geloso convinto d'indurre in lei quello stesso meccanismo che s'innestava nel mio corpo accrescendo il mio amore, sperando sì che la sua psico accettazione delle sublimazioni a cui davo vita funzionasse come funzionava in me, nel mio cervello. Ero certo che la Gelosia del nostro partner fosse l'ultimo baluardo che la disaffezione alla sua faccia deve superare per farci trovare la forza che ce lo fa lasciare, perché più esso si dimostra geloso di noi, più difficile è per noi rompere la relazione, e, con tale convinzione, mi mostravo geloso, sovente perfino quando non lo ero.
M'inquietano coloro che s'impongono d'essere freddi col loro partner per ostentare una irragionevole “emancipazione”, perché credo che il loro rifiuto della gelosia sia solo una scusa alla quale si aggrappano per evitare di dire la verità al loro partner, e cioè, che non lo amano più. E comunque esistono anche quelli che invece sono convinti davvero che la gelosia non sia frutto d'amore ma di egoismo. In verità la gelosia, nove volte su dieci, nasce dal “sentirsi poco amati”, e se una donna vede che suo marito è geloso, non dovrebbe cadere nel tranello di confutare la sua eventuale stupidità, ma porsi questa domanda: “riesco a farlo sentire amato?”
Chi non è geloso non è interessato.
Dunque, che fossi geloso era vero. Non sono mai stato un campione nel temperare malizie, anche se non credo che questa sia una mia rinfacciabile colpa. Il nostro Dubbio, che in altre discipline del-la vita è chiamato “esser cauti”, è la sola campana di vetro dentro la quale possono sopravvivere gli Amori, che altrimenti si troverebbero come canne al vento, vittime, come i Tempi, di ciò che spesso cambia. La Fiducia c'entra poco con l'Amore, e non si può certo dare gratis. Non è un vuoto a perdere. Non ci si fida mai perché si ama, ma perché ci si rende conto di essere amati. Tutto è una dimostrazione continua, non v'è niente di vero a priori. Chi fa credito della propria Fiducia senza sapere nulla di certo è destinato ad andare incontro alle delusioni. La Fiducia è la Pietra Tombale dell'amore.
La rabbia che quelle occasioni mi facevano affiorare mi costringeva a ripromettermi, con me stesso spergiuro, che la prossima volta sarebbe andata diversamente, o che “questa gliela avrei fatta pagare”. Non c'era nulla di più falso.
Quando il giorno dopo la rivedevo e dissimulavo ostentatamente arrabbiatura, bastava un suo semplice gesto, che fosse un bacio o, ancor meno, uno splendido sorriso, per farmi dimenticare tutto. Lei, per qualche tempo, tornava ad essere “la mia Marta”, non avendo occhi che per me.
Com’erano dolorosi tutti quei dubbi! E com’era doloroso quel sentore che mi convinceva di quanto io fossi per lei soltanto un palliativo, un riempitivo, una scusa per far passare il tempo, e che in fondo Marta sperasse di conoscere qualcun altro.
Per me questo solo fatto, cioè che lei non mi considerasse degno di essere l'uomo della sua vita, era un dolore cocente che mi straziava il cuore, e anche oggi, quando, pescato chissà dove, mi ritorna in mente, mi fa montare un'ira furiosa tale da rovinarmi la giornata. Chi si credeva di essere?
Non è un caso vedere oggi donne sposate, anche di trenta o quarantanni, mandare “a ramengo” il loro matrimonio solo perché invece di esser state guardate da due o tre uomini, come solitamente gli succede, un giorno vengono fissate da quattro o cinque. Tanto basta per illuderle d'essere preziose, troppo preziose, per “quell'inutilità di uomo” che hanno sposato. Questo dimostra che la vanità, come ogni altro difetto, non è una cosa innocua. Certo, non tutte sono fatte così, ci sono anche quelle che adorano farsi guardare ma che non hanno intenzioni che non siano limitate al compiacimento, il problema, però, è che noi non possediamo strumenti in grado di trebbiare le une dalle altre, e questa impossibilità ci spinge a diffidare di ogni loro gesto e momento della giornata.
Esattamente come io diffidavo di Marta.
Qualche rara volta, prima del fattaccio, cercavo di convincermi che quel genere di situazioni che subivo e che soffrivo, la sua mania di guardare gli altri uomini, i suoi scherzi inopportuni, il suo pressappochismo quando parlava della nostra storia, e il fatto che mi escludeva sistematicamente dal suo futuro, fossero il giusto salario da pagare alla sua bellezza. Questa effimera convinzione, tuttavia, non poteva curarmi più di tanto il cuore, perché, a pensarci bene, capivo d’aver raggiunto il “punto del non ritorno”, e mi rendevo conto che se mai ci fossimo lasciati avrei dovuto recuperare la mia vecchia vita, vita che a quel punto giunti sentivo estremamente estranea.
Consideriamo tale la bellezza quando ha a che fare con noi, è il desiderio di mettere in relazione con noi qualcosa di esterno che ci è particolarmente piaciuto. Se c'innamoriamo di una donna è perché riusciamo ad inserirla nel nostro immaginario di vita a due, e vediamo in lei un futuro luogo comune che è in grado di riempire le nostre nuove abitudini rimuovendo le vecchie. La delusione non è data che da un principio d'illusione, e forse quello che ci fa più male quando una storia finisce non è tanto la perdita di quei nuovi luoghi comuni, per i quali così ansiosamente avevamo faticato per far diventare nostri, quanto la costrizione di dover fare la pace con i vecchi.
Assai di frequente pensavo a quanto fosse inutile e stupido innamorarsi. Soprattutto di ragazze conosciute in un certo tipo di locali. Avevo sempre pensato che l'amore sincero, vero, fosse una cosa meravigliosa, oggi sono convinto che non sia sempre così. Ma si sa, come in passato anche nel prossimo futuro le nostre convinzioni non saranno altro che quel veicolo che ci rende alienata e alienabile la realtà, ben misera consolazione per la storia delle nostre vite.
Marta diceva di amarmi, ma, sono sicuro, il suo amore non era uguale al mio, e questa disparità in un rapporto di coppia può essere determinante per decidere equilibri e durata di un amore. Lei, questo lo capii a mie spese, durante il giorno poteva fare a meno di me. Io, quando non ero con Marta, altro non agognavo che di vederla. Era proprio un bisogno fisico, la necessità di appagare e calmare i miei doloranti sensi; vista, tatto, olfatto.........……………….
Niente al mondo era più importante per me che guardare Marta, baciare Marta, abbracciarla forte e farci l'amore. Il problema era che lei non sembrava dello stesso avviso.
Per capire lo spessore dell'amore che la nostra donna ci porta, dovremmo chiederci più spesso cosa sarebbe disposta a fare per noi, e se non scorgiamo risposte in arrivo, tentare di abbassare il livello d’importanza del rapporto.
Talvolta Marta diceva che l'amavo come un ragazzino, che l'amore che le volevo rasentava l'idolatria adolescenziale, un possessivismo e un egoismo da pena di morte.
Oggi so con certezza che la vera bambina era lei.
Sempre attenta agli sguardi degli altri uomini, spesso sfoderava quel tipo di vanità furba che non compromette completamente, ma che da sola basta a farci capire di aver a che fare con una megalomane, una sfrenata esibizionista disposta a tutto pur di farsi notare. In quegli istanti questo suo passeggiare in quelli che io ritenevo, e ritengo, difetti, me la sviliva compiutamente. Il suo ricamare di-scorsi di scuse con l'uncinetto, me la faceva odiare. Anche la sua vanità non era così palese come quella, per esempio, dei miei compagni del gruppo, ma era comunque abbastanza per cercare quell'autocompiacimento che l'attenzione di “terzi” poteva darle.
Proprio ciò che odiavo di più al mondo.
Per crearsi una vanità propria da spacciare per qualcos'altro e consona alle aspettative altrui (quel che pensiamo gli altri si attendano da noi), è necessario trasformarsi in registi di noi stessi, considerare la scenografia, i costumi, studiare attentamente la sceneggiatura della commedia che vogliamo mettere in atto, che bramiamo allestire.
Marta pareva non aver lasciato nulla al caso, neppure i movimenti o le battute impreviste. Era abilissima ad improvvisare, che fosse un gesto con la mano o la scusa per attraversare la sala di un locale indossando così i panni di “prima donna”.
Io subivo. Subivo perché non avevo in me quella determinazione che mi avrebbe consentito un gesto risolutore. Ciò che meno mi aspettavo, cioè che quella determinazione arrivasse da fuori, da un fattore esterno, da un episodio nel quale la mia responsabilità, che fosse per meriti o per colpe, era alquanto limitata, avvenne.
L’IMPORTANZA DI ESSERE ARTISTI
I.
Per tutto il periodo in cui stavo con Marta continuammo a suonare. Finalmente avevamo deciso di fare qualcosa di “nostro”, ed il tempo che perdevamo in sala a provare aveva cominciato ad avere qualche senso. Non suonavamo perché volevamo incidere ed avere successo, anche se in questi casi è meglio parlare per sé stessi.
Passavamo giornate intere a tirare su dei “pezzi”, a costruire, a creare. Eravamo combattuti su quale genere di musica buttarci. I gusti erano molto diversi fra loro.
C'era chi amava la robaccia che facevamo di solito al locale, e chi, attirato verso quel tipo di originalità moscia, voleva diventare il Peter Gabriel o lo Sting del Terzo Millennio. Io e Maurizio volevamo fare davvero qualcosa di nuovo, anche se in musica ormai non s'inventa più niente. Così, per i primi Tempi, altro non riuscivamo ad eseguire che un qualcosa di ibrido che conteneva i gusti di cinque individui. Era chiaro, se volevamo fare musica che potesse piacere dovevamo scegliere cosa tenere e cosa scartare.
Ci furono un paio di mesi di lotte interne al gruppo nelle quali, come cani che pisciano su più ruote possibili, ciascuno di noi tentava di delimitare il proprio territorio. Pochi erano disposti a cedere su quelli che chiamavano “principìi musicali”. Per esempio.
Alessandro era davvero poco propenso a fare del jazz o dell'etnica. Lui voleva avere la possibilità di cantare qualcosa che ammaliasse le ragazze. Non voleva sentir parlare di Pat Metheny o degli Spyro Gyra. Per qualche tempo io e Maurizio riuscimmo a convincere gli altri di poter fare qualcosa di molto simile agli Oregon ma con armonizzazioni che avrebbero permesso ad Alessandro di cantarci sopra, e quindi di sfoggiarsi. In pratica volevamo dargli un contentino. Ma lui non si faceva persuadere così facilmente.
Il vanitoso confonde le sue opportunità con la vita vera, e se gli sottrai il suo habitat naturale, per Alessandro il locale e tutto quel corollario di allestimenti che gli offrivano la possibilità di sfog-giarsi, egli si sente come se fosse in cattività. La tentazione di “sventolarsi” è un po’ simile a quella che prende gli appassionati del tavolo verde; più si guadagna più vien la voglia di continuare a giocare.
Tirammo su diversi pezzi, alcuni dei quali abbastanza buoni, usando tutte le tecniche che sapevamo; dissonanze, salti, stacchi, sincopato eccetera. Durante i concerti riuscimmo ad inserirne alcuni, ai più sconosciuti, che ci appagavano sia artisticamente (per me e Maurizio era così) che moralmente. Erano “movimenti” dei Montreaux, alcuni di Nando Lauria e di Tuck and Patty. Presto mi accorsi che i miei gusti mi rendevano troppo lineare, scontato. Diedi un’occhiata, e mi resi conto che le mie svise erano tutte in LA e in SOL. Sorrisi. Era proprio la semplicità di cui accusavo i gruppi che non mi piacevano. Così tentai di cambiare il mio modo di suonare, e ne ricavai alcune soddisfazioni.
L'unico problema era la miseria che il nostro pubblico rappresentava come “ascoltatori”. La gente che veniva nei locali dove suonavamo era considerata dai gestori come una preda. Dovevamo fare Vasco Rossi perché così quegl'imbecilli bevevano Tequila e Whisky, consumazioni che costavano di più. Vasco ti do un consiglio; fatti pagare. Non solo dalla SIAE per i diritti, ma anche dai produttori di liquori.
In quel modo ridotti, solo pochi individui riuscivano ad apprezzare quel po' po' di sforzo che facevamo. Ben presto capimmo che quei pezzi non potevano monopolizzare la serata, e fummo costretti a ritornare dalle parti di Sting, Peter Gabriel, Queen e Beatles. Non c'era nulla di più frustrante. Mi sentivo una bagascia di quelle da cinquemila lire la botta. L'Arte è prima di tutto “creazione”, e se esegui sempre cover, “roba altrui”, non puoi dirti artista.
Fu in una serata come tante che la fortuna, veramente cieca in quell'occasione, venne a sbattere il muso su di noi. Era un Venerdì e il locale era semi deserto. Così iniziammo a suonare quel che ci garbava. Nel pubblico di quella sera, sagacemente occultato, c'era un misterioso personaggio. Non lo avevamo mai visto. Era un amico del barista, e per tutta la sera non fece altro che osservarci. Beveva seduto ad un tavolo con accanto una ragazza che poteva essere sua figlia.
Quelle donne belle che stanno con uomini vecchi o brutti ma ricchi e famosi, vedono in loro l'emanazione fascinosa di una vita segreta il cui santuario vorrebbero violare. Sanno che con le sue possibilità, che poi sono soldi e conoscenze, potranno appagare più facilmente la loro Vanità, e sconsacrare il Santo dei Santi di quella celebrità e ricchezza uscendoci insieme, è un modo per impossessarsene. Naturalmente non è gratis, anzi, dovranno offrire quale olocausto la loro bellezza, la loro giovinezza, e quella naturale propensione, che hanno le belle donne, verso i maschi che dovrebbero essere di loro “competenza”; belli, alti, magri, artificiosamente abbronzati, ignoranti quanto basta, glabri come il culo di un bambino, anabolizzati di mestiere, “biondo scemo”, e con le mandibole giuste e i denti bianchi.
Non vorrei essere nei panni di quei vecchi riccastri, per quanto concerne le storie d'amore, perché sono convinti che l'uomo maturo “attizzi”, poverini, e non sanno che appena il santuario verrà violato con una promessa di matrimonio o di convivenza, diventeranno essi stessi dei Moloc, con le corna abbastanza grandi per appenderci degli ex voto, ma senza alcun adoratore.
Finito di suonare scendemmo dal palco, ognuno con le proprie priorità. Io e Maurizio andammo a bere al banco, gli altri, chi toccandosi i capelli fingendo di metterli a posto, chi gesticolando per darsi importanza, chi sostando pomposamente nelle scalette approfittando del palco vuoto, vagavano per il locale mettendosi in bella mostra.
Pareva di essere nel “quartiere rosso” di Amsterdam.
Le Vanità non sono tutte eguali, perché gli orpelli con cui ci si adorna sono esche precise per precisi individui. Alessandro non tentava di ammaliare con le stesse armi di Enzo, perché l’uno rivolgeva le sue attenzioni alle bimbette speranzose d’incontrare un “moderno Principe Azzurro” (alias un elettrocalamitato travestito da rock star umanista e perpetuamente solidale), e l’altro voleva far colpo su ventenni da centro sociale occupato il cui massimo sono quei rockettari vestiti di pelle che ai concerti vomitano addosso ai loro fans. E diversi obiettivi aveva Giacomo, che, convinto di emanare un fascino intellettuale (questa del “fascino intellettuale” non l’ho mai capita. Ci sono donne che leggono un libro e, trovandosi di fronte ad una bella frase, non s’innamorano delle parole ma di Colui che le ha scritte. E’ come se una donna che a letto fate im-pazzire di piacere, invece che innamorarsi di voi s’innamorasse di vostro padre), corteggiava, naturalmente senza darlo troppo a vedere, ragazze universitarie di quelle che in meno di due ore sono in grado di progettarti un ponte lungo cinque chilometri, ma che se le chiedi dov’è nato Garibaldi non lo sanno.
Ultraspecializzazioni. Fra non molti anni faremo la fine dei dinosauri.
Credo che l'unica differenza che c'è fra la vanità maschile e quella femminile, sia solo nelle opportunità che hanno i possibili obiettivi. Una donna che va con un bell'uomo che si sfoggia, sente un rimorso maggiore di quello che provano gli uomini che vanno con le vanitose, perché sa di aver ribaltato un concetto di cui il sesso al quale appartiene dovrebbe esserne il beneficiario. Sono poche le donne disposte a pagare un uomo per andarci a letto, e questo succede perché nell'immaginario collettivo sono loro a dover rappresentare la preda che trasmette desiderio. La donna che si fa conquistare da un uomo vanitoso, dopo aver fatto l'amore con lui, soffre di un ine-narrabile senso di colpa trasmessogli da un altrettanto inenarrabile complesso d'inferiorità, e questi stati d'animo non si colmano con l'emancipazione. Non c'è niente da fare.
La verità è che una donna ha insita nella propria natura sessuale la necessità di sentirsi desiderata, cosa di cui gli uomini possono fare benissimo a meno, altrimenti non vedremmo dei vecchi riccastri sposarsi con ventenni bellissime che sono eternamente alla ricerca di “qualcosa di meglio”.
Una volta scesi dal palco io e Maurizio ordinammo due Negroni. Fu allora che il suddetto signore, seguito da cagnolino in minigonna “spaccata”, raggiunse il nostro tavolo e chiese il permesso di sedersi. Ingombrava elegante l’area che occupava, con un paio di brache grigio chiaro di frescolana e una camicia nera a maniche corte. Non portava cravatta, e la giacca era da lui maltrattata, stretta nella mano sinistra e tenuta all’altezza della coscia. Le sue mani erano grandi, addirittura enormi. Il suo viso era paonazzo, quasi da beone, e veniva reso dolce dagli occhi azzurro chiaro, che in quel “quadretto” ornato da capelli bianchi davano al tutto un’espressione pacata e saggia. Era di corporatura robusta, anche se asciutta, e il suo torace carenato trasmetteva alle spalle una potenza che forse non avevano.
Qualche anno prima doveva essere stato uno “splendido quarantenne”, e oggi tentava di prolungare quella recente forma con atteg-giamenti e gesti palesemente fuori moda. Saltava agli occhi, quell’uomo era decisamente avulso dal contesto.
La ragazza invece sapeva di “hostess”. Non parlava, rideva a co-mando, beveva con la testa girata dall’altra parte, respirava allargando le narici come i pesci aprono le branchie, e ogni tanto lasciava che lo spacco della sua gonna mettesse in onda gradevoli “filmini”. Il suo viso era bianco latte, le sue mani estremamente curate, e le braccia in dotazione erano finissime. Aveva i capelli lunghi, lisci e biondi, che, per quanto erano scolpiti, sembravano tenuti insieme da una quantità industriale di lacca.
Dopo aver fatto le presentazioni, in cui disse di chiamarsi Marco Gagliardi, cominciammo subito a parlare di quel che sapevamo fare, di quello che ci piaceva e di dove avevamo intenzione di arrivare.
Né io né Maurizio ci chiedemmo chi fosse costui che s'interessava in quel modo alla musica che facevamo, ma questo fatto non era strano. In quel locale venivamo accalappiati ogni sera da qualcuno che voleva parlare di musica con noi, e così non ci trovammo nulla di anormale. Anzi, qualcosa in verità la trovammo, e non ci dispiacque; il signor Gagliardi, diversamente dai ragazzi che ogni se-ra volevano dibattere di musica, per lo meno non era ubriaco.
- Non è facile sentire il genere di musica che avete suonato stasera. - disse parlando seriamente e con lo sguardo fermo - Di solito i locali come questo sono ricettacolo di “bimbi” che vogliono gli si racconti una “vita spericolata” o la “solidarietà umana”.
- E lo dice a noi? - rispose Maurizio - Pensi che per suonare un pezzo degli Oregon, io e lui, - disse indicandomi – abbiamo dovuto sostenere un anno di battaglie con gli altri del gruppo. Fare quel genere di musica alla mano tante volte non è che sia proprio opportunismo. Molto dipende da chi hai come compagno, e spesso è proprio il genere da classifiche che ti permette di essere apprezzato.
- Sì, lo so. - disse l'uomo - Ci vuole coraggio per suonare quello che ti piace. E' questo che ho apprezzato in voi. Il vostro senso di sfida, di mettervi in gioco. E' naturale, suonando i Queen non puoi che essere apprezzato, ma nel vero senso della parola, però! Col cartellino sulla giacca. - e rise.
- Non si rischia niente. - intervenni io - E' per questa ragione che non si è appagati per nulla. Ciò che ti può dare a livello emotivo la musica che fai senza rischiare niente, è niente! Secondo i nostri compagni quello che facciamo non è arte, ma solo la possibilità di portarsi a letto qualche sbiadita donnetta. Ma di quelle veramente stupide, però!
- Vanità! - rise Gagliardi - E' normale. Non crediate che per altri gruppi o altri musicisti, anche per quelli che sono già famosi, sia diverso. Voglio dire che è più natura che situazione.
- Mi dispiace ma non sono d'accordo. - dissi - I difetti, e tanto più un difetto come la Vanità, non dovrebbero influenzarci nel nostro lavoro, e ancora meno se il nostro lavoro ha a che fare con l'arte. Mi dice lei come fa a nascere in Italia un Frank Zappa o un Pat Metheny se il clima e gli artisti che ci sono si accontentato di fare musica furbetta, che abbaglia, è vero, ma che tecnicamente non ha nulla, e che, per questo stesso motivo, dura dall'oggi al domani? Andiamo! La cultura musicale che ha preceduto gli artisti che sono rimasti nella storia della musica, quasi mai aveva a che fare con movimenti, dinoccolati e di altro genere, o con la Moda. La musica classica esiste da migliaia d'anni, e il jazz ha radici nell'etnica e nel blues, cioè in quei tipi di musica che ci viene tramandata da secoli! E poi, spesso le ragazze che “becchi” in un certo tipo di locali e per merito d'atteggiamenti precisi, altro non ti possono dare che quello che hai speso per “beccarle”: nulla.
- Va beh! - esclamò il Gagliardi - E' chiaro che non si può sperare che le storie che nascono in certi posti come possono essere i locali notturni o le discoteche, siano relazioni importanti e con un certo spessore. Comunque può accadere anche il contrario.
- Per caso, Gagliardi, per caso. - disse Maurizio.
Per un'attimo pensai che anche la mia storia con Marta era nata in un locale, e subito mi rimproverai di essermi così esposto nei confronti della mia coscienza.
Improvvisamente Gagliardi disse:
- Comunque desidererei sentirvi in privato. Faccio l'arrangiatore per una casa discografica e vorrei vedere se si può fare qualcosa.
Ci lasciò un biglietto da visita e prendemmo appuntamento per la settimana successiva, un Mercoledì. Non ci sembrava vero. Un arrangiatore s'interessava alla nostra musica.
E' divertente sapere che le confutazioni che facciamo sulle discipline della vita prendono vigore in noi quando vengono apprezzate da chi ha esperienza in materia. Oggi notiamo spesso che una questione diventa “cruciale verità” quando come antefatto o come chiusura porta la frasetta incontestabile “uno scienziato ha detto” o “uno scienziato ha fatto”.
Forse l’importanza di essere artisti è tutta qua.
Con quello stesso spirito apprendemmo l’interesse di Gagliardi nei nostri confronti. Il solo fatto che la nostra arte interessasse un individuo che si poteva ritenere un esperto, bastava a farci diventare degli artisti veri. Cademmo subito nel laccio di prenderci sul serio. Dovevamo prepararci come si deve. Presto ci saremmo dovuto im-pegnare ad un altro livello.
II.
Ogni tanto ripenso ai tempi in cui muovevamo i primi passi nel mercato discografico, e ogni volta mi metto a ridere da solo. Si capiva ad occhi chiusi che non eravamo pronti. Dell'arte avevamo soltanto una vaga idea, un’idea piuttosto “romantica”, direi. In realtà le cose non sarebbero andate come speravamo.
Non avremmo potuto fare ciò che volevamo, almeno, non all'inizio. Eravamo più manovali, operai, che artisti. Nessuno ci concedeva nulla, neppure facendo musica. Tutto questo quando conoscemmo Gagliardi non lo sapevamo ancora, e fu per noi la delusione più cocente.
Credo che in Italia ci sia la categoria più pavida del mondo, gli imprenditori, e, fra questi, la più vigliacca in assoluto, quella degli editori. Altrimenti non si spiegherebbero tutte le “vaccate” di dischi e di libri che vengono messi in circolazione solo perché incisi e scritti da chi ha già un nome.
Quando il Mercoledì preposto arrivò, eravamo visibilmente eccitati. Era il nostro primo approccio con un mondo lungamente desiderato, e chissà per quale sorta di motivo eravamo tacitamente convinti che fosse necessario presentarsi con un certo snobismo. Il motivo di tale comportamento era piuttosto chiaro; non volevamo cadere in mani sbagliate che, notando la nostra smania di voler entrare in quel mondo, avrebbero potuto approfittare di noi sfruttandoci. E' vero, per quanto riguardava muoversi in quell'ambiente eravamo degli sprovveduti. Così, come caute serpi, cercammo di non ostentare altro che indifferenza.
Soprattutto nei riguardi di quell'arrangiatore.
Gagliardi era la classica persona convinta di conoscere appieno l'animo umano. Durante quelle prove arrivò addirittura a dirci quale musica secondo lui era adatta alle nostre facce. Sicuro, mi rendo perfettamente conto che non si può mettere Charles Manson su un palco a monologare sulla “sfera della morale”, o il Marchese De Sade a strimpellare la chitarra cantando di castità, ma era comunque troppo!
Chissà per quale oscura ragione certi adulti sono certi che qualsiasi cosa essi dicano debba essere presa sul serio da coloro che ritengono essere alle prime armi. Intendiamoci, non voglio rinfacciare gli anni a nessuno, ma ho sempre creduto che sono le cose che si sono vissute a fare degli individui dei plausibili esperti, e non la loro età. E' anche vero che chi ha tanti anni (ma in realtà ne bastano solo pochi più degli altri) in genere ha avuto più possibilità di vivere esperienze, ma questo non è né sempre giusto né sempre degno di nota.
Conosco dei veri e propri Filosofi che vivono per strada facendo i barboni. Quando li incontro rimango sempre affascinato da quello che dicono, perché dimostrano di avere un'esperienza e una cultura che sono fuori dalla portata di certe “educande agiate”. Ma non appena me ne vado lasciandoli lì a divorare la loro precarietà, la prima domanda che mi viene in mente è; dal momento che sono così colti, perché mai vivono per strada? E la risposta che mi do somiglia più ad una scusa. Del resto ci sono persone convinte che la strada insegni a vivere, e persone che la strada ha rovinato. Di solito sono le stesse.
Appena entrò, dopo qualche chiacchiera, ci disponemmo e ini-ziammo a suonare. Suonammo pezzi di genere diverso. “Her town too” di James Taylor, “Evil Prince” di Frank Zappa, alcuni pezzi di Gabriel e Sting per finire con “Ruby, My dear” di Monk, in una versione rivista per pianoforte e chitarra che avevamo tirato su io e Maurizio. Gagliardi ci guardava celando un falso ottimismo. Poi disse:
- Bisogna lavorare di più sulla vostra personalità, su quello che potrebbe essere il vostro genere, il vostro stile. Il basso è troppo presente rispetto alla batteria. Mancano le tastiere, comple-tamente. Maurizio, dov'eri? Se ti nascondi dietro la chitarra allora è inutile essere in cinque. E tu, - disse rivolto a me - fai un giro e parte la svisa, ne fai un altro e riparte la svisa. Non va mica bene sai? Troppo lineare, scontata. Dovreste dare al pubblico qualcosa di meno immaginabile, perché, diciamoci la verità, uno che conosce soltanto Eminem o Jennifer Lopez dopo il primo giro sa già dove andrete a parare!
Quel discorso era deliziosa musica per le mie orecchie. Non desideravo di meglio che suonare pezzi un po' meno scontati e che avessero dato la possibilità al gruppo di sciorinare la tecnica e la fantasia.
Gagliardi aveva ragione, dovevamo cambiare.
Così, appena uscì dalla sala, ci mettemmo attorno ad un tavolo e cominciammo a discutere sul da farsi. Maurizio aveva tirato su un paio di bossanova con la tastiera e, tornati agli strumenti, provammo ad andargli dietro. Non mi dispiacevano affatto.
Provammo per due-tre mesi di fila, tutti i giorni. Anche gli altri, piano piano, si stavano appassionando a fare dell'altro. Lasciammo Gabriel e Sting alle loro elucubrazioni umanitarie, buttammo i Queen nel cestino della carta, e cambiammo completamente il modo di concepire certe cose. Non saremmo più scaduti nei facili sentimentalismi, per quanto ci sarebbe costato non avremmo più accontentato il nostro pubblico, quello del locale, che mettendo qualche moneta sul bancone voleva sentirci cantare monotonie datate che ci avevano stufato. Avremmo dovuto limitare le nostre apparizioni in quel locale al Venerdì o al Sabato, un giorno, non di più, giusto per mantenerci la sala prove. Il comporre ci avrebbe assorbito completamente. Se volevamo fare musica non solo per divertirci dovevamo impegnarci e ragionare ad un altro livello.
Gagliardi si fece vedere spesso, dandoci consigli e accorgimenti che ci sarebbero serviti in futuro. Non era malaccio, ma aveva sempre la presunzione di saperne più di noi. Anche se forse era vero, il suo managerismo sfiorava l'ossessione. Certo, eravamo solo dei ragazzi che andavano seguiti costantemente, ma non poteva imporci i vestiti, le auto, i nostri gusti musicali, e addirittura le ragazze e gli amici! Di tanto in tanto mi veniva la tentazione di mandarlo a quel paese.
Con Marta, quando ci vedevamo (sempre poco), cercavamo di andare d'accordo. Io ero più che mai innamorato di lei, e il dolore che la sua lontananza mi procurava lo sfruttavo per comporre, fare musica e scrivere testi. Mai capito perché quelli del gruppo incaricarono me della responsabilità di scrivere i testi per le nostre canzoni. Così, siccome Alessandro era il cantante, passavo assai più tempo con lui che con Marta.
Io scrivevo, e poi, quando portavo il risultato di notti insonni, con Alessandro provavamo la metrica. Era un lavoro che mi piaceva e mi dava soddisfazione. I testi avevano sempre qualcosa che andava rivisto, corretto. Sovente mi sorprendevo, orgoglioso, fiero di me stesso, ad autocompiacermi per ciò che avevo scritto. Alessandro mi riempiva di complimenti e, forse per questa ragione, sopportai meglio la sua vanità, il suo essere prolisso, i suoi atteggiamenti da “prima donna” e la noia che si portava sempre dietro e che era alquanto smanioso di scaricare sugli altri. Parlava già con l’importanza di un artista, sillabando le parole, facendo frequenti pause e usando termini che non aveva usato mai.
Marta non mi sembrava più la stessa. Voglio dire che, sentendosi trascurata, aveva perso quella vena polemica che aveva persuaso il mio istinto a digerirla quando la conobbi. Era diventata inappetente, sembrava stanca, lontana, ancor più disillusa. Forse quel “non essere al centro dell'attenzione” la faceva soffrire più di quanto io stesso mi accorgessi. Ma c'era anche dell'altro. Lei non sembrava convinta del lavoro che facevamo. Diceva che le ricordavamo quando era piccola e con alcune sue amichette volevano mettere su un'orchestrina.
Quando parlava in quel modo credevo che in fondo dicesse quelle cose per invidia, per gelosia. Marta, infatti, come più tardi ebbi modo di rendermi completamente conto, era una di quelle ragazze che vogliono l'attenzione su sé stesse ma senza darlo troppo a vedere.
Sempre pronta ad affermare che nulla la interessasse di meno della considerazione che gli altri potevano avere di lei, si notava ad occhi chiusi che bluffava spudoratamente. Come molte ragazze che sono convenzionalmente belle, in verità non ambiva che essere l'argomento preferito dei ragazzi. Quando non la si considerava tendeva a chiudersi e a mostrare quel tipo di vanità furba che tenta di mettere addosso agli individui la frenesia di sapere a cosa stesse pensando. Doveva sentirsi unica, sicuro. Unica come me, come tutti.
Se glielo avessi chiesto, presumibilmente, sarebbe salita volentieri sul palco a cantare, anche se aveva la voce da cornacchia. Lei non cantava, gracchiava.
Quando, dopo aver finito di fare l'amore, la sentivo cantare sotto la doccia, spesso pensavo che ci fosse qualche perdita nella conduttura idraulica. Ogni volta, non appena aveva finito di lavarsi e usciva dal bagno, le chiedevo se aveva tirato lo sciacquone.
- Perché? Non ho mica evacuato! - rispondeva sgomenta.
- Come no! - insistevo io - Hai cantato per mezzora!
Lei, allora, un po’ se la prendeva, anche se io cercavo di dimostrarle subito che stavo scherzando.
Per carità! L'ultima cosa che volevo era aprire un contenzioso con lei su come si canta o su chi ha la voce più bella in Italia e all'estero. Credeva di capirsene. In realtà andava dietro al flusso migratorio dei quotidiani specializzati, anche loro servi sciocchi che agognano abbassare il capo davanti ai loro padroni (che sovente nemmeno gli chiedono di farlo), e che tentano di spacciare ridicoli strimpellatori per veri e propri artisti.
Impazzisco dalle risate quando guardo quelle Tv specializzate in Musica che vendono “pentatoniche” per alta tecnica musicale. Scale che un bambino di otto anni riesce ad eseguire dopo averle osservate due volte. La comica è che scusano ogni cosa con “le emozioni”, tanto che le contrizioni ch'esse causano negli animi degli ascoltatori diventano immediatamente bravura.
Anche un bambino si emoziona leggendo fumetti, ma non per que-sto si può dire che Topolino abbia lo stesso spessore culturale di “Delitto e Castigo”!
Sono convinto che oggi sia più che mai necessario fare precise differenze, altrimenti tutto è Arte, e se tutto è Arte niente è Arte. Dovremmo riconsiderare il significato del termine “artista”.
La Tv, per un buon novanta per cento un catalizzatore d'inutilità, ricettacolo d'idioti, ha influenzato gran parte della società convincendoci che ogni cosa è una questione di gusti. Il modello televisivo è diventato un parametro buono per tutte le stagioni e per ogni continente. Per esempio.
Molti dicono che non ci sono più bravi scrittori, ma poi senti che il loro massimo di libro è un giallo che scopiazza il cinema o i telefilm televisivi. Se non si scrivono più romanzi non è tanto perché non ci sono più scrittori in grado di farli, ma quanto perché non ci sono più lettori in grado di leggerli.
In realtà se si legge poco la colpa è proprio degli editori e dei critici letterari, perché un libro bello fa venir voglia di leggere, mentre uno brutto la fa passare. Le recensioni dei libri editi sono sempre belle, e così vai in libreria ad acquistare e puntualmente ti ritrovi fra le mani un “pacco”. Oggi l’unica ragione per entrare in una libreria e recarsi al banco delle “nuove uscite”, sono Aldo Busi, Ian McEwan, e forse la Petrignani. La Letteratura corre dietro alla Tv senza averne i tempi, e il risultato è molto più basso delle reali possibilità, perché l’immagine inibisce la fantasia.
Questo discorso tanto più vale per la musica.
Oggi credo che Marta non sapesse mentire, almeno, non perfettamente. Mi diceva di non essersela presa, ma per tutto il giorno cercava di evitare i miei baci e le mie carezze, mettendo su un “muso da prima elementare”. Quando io le ripetevo che avevo scherzato, lei, sorridente, mi assicurava di non essersi sentita “toccata”. In verità lo era stata. A quel punto non sapevo più che fare e subivo le sue ripicche senza colpo ferire, come un santo consumato o un futuro martire.
Non mi piacevano queste situazioni, e l'unica arma che avevo per difendermi dal mondo, innanzi tutto da Marta, il “mio” mondo, era quella di buttarmi sulla musica. Questo avvenne sempre più fre-quentemente, tanto che se oggi posso dire di essere diventato un discreto chitarrista, lo devo probabilmente anche a quella situazione.
Talvolta ero tentato di dirle quanto poco le si addicesse quel broncio, ma non lo feci mai. Lei avrebbe sicuramente negato di avere un broncio. L'unica cosa che riuscivo a fare era quella di guardarla mentre suonavo, quando veniva a sentirci, o quella di pensare a lei fra un accordo e l'altro quando, con una scusa volutamente stupida, restava a casa o si costringeva a fare dell'altro e ad andare in un posto qualsiasi solo per non venire con me.
Era il suo modo di farmela pagare.
Dopo quelle poco edificanti scenette, entravo in una sorta di Limbo, speranzoso che lei mi perdonasse quella sua stupidità. Comprendevo che le mie colpe erano in realtà le sue, ma, come un cagnolino affettuoso che scodinzola dopo esser stato preso a calci dal suo padrone, la mia priorità era che tutto si appianasse alla svelta.
Non riuscivo a capire dove voleva arrivare, ma l'amore che le portavo mi precludeva qualsiasi reazione, e allora non mi restava che subire. Certo, vi direte, quando è troppo è troppo! Ma la sofferenza che provavo, e che lei pareva agognare propinarmi, spesso mi serviva per cercare stupide e inutili scuse alla mia incolpevole esistenza.
Meritavo quella vita? E chi lo sa! Forse sì. Ma non come molti credono. Il Destino non c'entrava un fico secco. La mia voglia di soffrire era assiduamente ricercata da me come certi piazzisti cer-cano nuovi clienti. L'ho sempre saputo. Chi ci chiamava “artisti” non sapeva realmente chi si trovava di fronte.
Quando con Marta si litigava ero sempre io a cercare pretesti cre-tini per fare la pace. Lei, allora, come se facesse solidarietà a paesi del terzo mondo, mi guardava con la testa reclinata e l'espressione compassionevole, contenta di elargire un po' di carità, come quelle nazioni ricche che regalano milioni di scarpe da tennis al Bangladesh. Si sa, esistono individui che hanno ricevuto così poco dalla vita, e sono talmente abituati a prendere calci in bocca, che se per una volta beccano solo uno schiaffo credono sia un atto di stima. Io, in quel tempo, ero uno di questi. Quando lei mi perdonava una sua mancanza, un suo capriccio, ero felice come un bimbo di quattro anni nel lettone di mamma e papà.
Ci sarebbe voluto davvero poco per fermarmi un momento e capire che ero schiavo di lei, del mio amore per lei, che mi stavo vendendo, e neanche troppo bene, ad una donna che non era sicura di volermi comprare e continuava a tirare sul prezzo, ma, probabilmente perché avevo questa certezza, ciò che evitavo di fare era proprio far affiorare nel mio cervello tale consapevolezza.
Cristo come l’amavo! Oggi mi è difficile ritrovarlo, quell’amore, e assai frequentemente mi chiedo quali sono le ragioni che spingono ad amare. Non è stravagante, nel mondo affollato che ci circonda, avere nella testa un’unica persona? Non avere presente che quell’individuo? Nel cuore un solo desiderio? Nella bocca un solo sapore? Nelle mani irrimediabilmente quel tatto, quel corpo? E le corde vocali! Che leggero era il suo nome a pronunciarlo! Certo, stavo vivendo per le sue braccia, qualche volte sinceramente strette alla mia vita, per i suoi baci, eredità che mi spronava a ricordarla quando ero lontano da lei, per le sue carezze, per i suoi occhi, sguardo che illudeva come i suoi gesti, per le sue vesti, per le sue parole, rapito, catturato una volta per tutte dal suo alito di vita e dalla sua esistenza. Un amore compiuto, così compiuto da non saper ricono-scere alba e tramonto, bianco e nero, vita e morte, terra e cielo, acqua e fuoco. Un’indelebile illusione che mi strappava la vita in ogni momento, in ogni situazione, in ogni nome.
Considerando, fu per questa situazione con Marta che mi buttai a capofitto sulla musica. Ero terrorizzato dall'idea che la nostra storia sarebbe potuta cambiare, e speravo, tenendomi lontano da lei quando sentivo che era in vena di far ripicche, di continuare a mantenere quello status quo. Lo so, non era una grassa consolazione, ma quella storia mi serviva come punto di riferimento per sapere dove andare quando avevo finito di far “l'Artista”. E poi perché, naturalmente, ero innamorato di lei. Così m'illudevo di riuscire ad amalgamare le uniche due cose che la vita mi aveva dato; il mio amore per Marta e il mio amore per la musica.
III.
Gagliardi ci aveva promesso un disco nel giro di tre o quattro mesi. Questo significava impegnarsi per comporre e per migliorare i pezzi che avevamo già. Qualche rara volta ero convinto che la cosa si potesse fare, ma quasi mai era così. Non potevamo basarci su quello che non avevamo; la sicurezza.
Qualcuno di noi, Alessandro ed Enzo in testa, era convinto di poter riuscire a sfondare. Io e Maurizio eravamo abbastanza increduli, e vivevamo alla giornata.
C'impegnavamo, ma ci sembrava sempre poco. Eravamo pieni di dubbi, soprattutto sulla nostra musica. Come dovevamo presentarci al pubblico? Non lo capivamo, non lo sapevamo. Così tirammo su due gruppi di pezzi, uno più tecnico e l'altro più commerciale, di facile ascolto.
Quando li risentivo mi veniva il mal di stomaco. “Siamo rimasti delle bagasce da poco prezzo”, mi dicevo. Pensare a noi come ad “artisti” mi sembrava un'iperbole. O meglio, una catacresi. Il nostro gruppo accostato alla musica e all'arte. Una locuzione inserita in un contesto non adatto a lei, un vocabolo pronunciato fuori luogo, non nella sua comune accezione. Ogni volta mi veniva l'atroce dubbio che con la musica avessi poco da spartire. La nostra Vanità stava alla musica come la Letteratura alla Tv, e parlare di libri in televisione è come riempire d'acqua una scatola di cartone.
Ero pienamente assorbito dal lavoro che dovevo fare. Il giorno lo dedicavo alla sala, a suonare con gli altri provando i nuovi pezzi, e la notte a scrivere i testi per quelle canzoni. Gli altri erano ben felici che fossi io a scriverli. Non perché li scrivessi eccessivamente bene, ma per l'onere che mi ero assunto. Avevo buttato giù della roba che non mi sembrava cattiva, anche se ero scettico sulla sua funzionalità. Una canzone parlava di ecologia (che tristezza!), e un'altra della situazione famigliare di Alessandro. I suoi genitori aveva-no divorziato. Ne scrissi una che sbandierava la mia disillusione su tutto. Gli altri erano contenti di quella roba, tranne Maurizio, che mi disse:
- Sono cose deliranti. Ma dove le hai prese?
Io feci una smorfia e tirai avanti. Dedicai un pezzo anche a Marta. Lo intitolai “Una donna”, e in pratica raccontava di che cosa aspiravo in fatto di personalità femminile e di sentimenti. Chissà, forse avevo l'intenzione di dirle ciò per cui mi mancava il coraggio quando mi trovavo davanti la sua faccia.
“...…............considerando, non c'è molto da dire”.
Così intitolammo quello che doveva essere il nostro primo album. Era una frase che Giacomo aveva rubato ad un Vigile Urbano una mattina. Questo Vigile gli aveva fatto la contravvenzione perché lui, non avendo trovato parcheggio, aveva messo l'automobile in doppia fila. Mentre riempiva la contravvenzione, Giacomo gli parlava cercando di fargli cambiare idea. Imperterrito, l'Urbano, aveva continuato a compilare il foglio che attesta quanto ingiusto e pieno di automobili sia il mondo, e alla fine, viste le insistenze di Giacomo, con una sufficienza vanitosa, disse:
- Guardi la situazione. Considerando mi pare non ci sia molto da dire.
In quei giorni così convulsi mi sentivo attorcigliato. Era uno strano senso d'impotenza, mi sentivo contratto, ansioso, soprattutto la notte. Non stavo molto bene, ma facevo di tutto per non mollare.
Marta non mi aiutò per niente. Più probabilmente era lei che aveva bisogno d'essere aiutata. Da qualche tempo, come già detto, la vedevo diversa, lontana, distratta e fin troppo incoerente, proprio ciò che aveva sempre sostenuto di non essere.
In quella decina di mesi Marta era cambiata.
Ostentava solitudine e vittimismo. Era vero, aveva quasi perso quell’albagia di fondo che quando era in forma la rendeva antipatica, ma questa nuova ipocondriaca condizione da “fraticello del 1300”, per chi come me la conosceva bene, l'aveva trasformata in un personaggio ridicolmente retorico. Come quelle donnette dell'antichità che vedevano Gesù in ogni albero e in quasi tutti i temporali, pareva essere pervasa da quel misticismo che da fastidio a chi, come me, è realista. Era poco credibile.
A distanza di anni capii quel suo comportamento.
Quando la considerazione degli altri nei tuoi confronti comincia a scemare, sei portato a credere che il mondo voglia metterti da parte. E allora sei proprio tu, anticipando e mistificando più del necessario, a volerti sentire più solo di quello che effettivamente sei, proprio come faceva Marta quando, per colpa del mio lavoro, non potevo calcolarla più di tanto. Vorresti anticipare (probabilmente per mettere alla prova il tuo cuore e il tuo cervello) ciò che temi l'umanità voglia propinarti, e allora ti convinci, falsamente, che in verità sei ancora più solo di quello che ti sembra.
Si sa, sprecata l'emozione del primo impatto, consumato il pathos, tutto diventa possibile e più sopportabile. La stessa ragione che si è avuta per la messa in scena del “Lago della Duchessa”.
Non mi sono mai sentito così “umano” come quando, in quel periodo, dovevo sempre stare attento a porgere a Marta quel poco di solidarietà di cui ero capace. Ma nel far questo ero troppo goffo. Avevo terrore delle sue reazioni. Allungavo una mano con l'intenzione di carezzarle un braccio come un bambino allo zoo infila la mano nella gabbia delle scimmie per offrire una banana. Non ci voleva molto a capire che non ero affatto portato a fare l'umanista. Nemmeno nei suoi confronti.
Marta, quando non era troppo assorta nel contemplare la sua inappetenza, o creduta tale, da me ma anche dagli altri, diceva di amar-mi di un amore nuovo. Io sapevo che il suo era soltanto egoismo, ma volevo “accocolarmi” in quell'eufemistico amore che lei mi porgeva come un mendicante porge la mano ai passanti; anche quello era un chiedere, e io lo sapevo benissimo.
Fu allora che capii di quale sorta di vanità Marta era padrona. Lei, che ostentava anticonformismo, altro non era che una vanitosa della peggior specie, quella falsamente intellettuale, portata, quasi istintivamente, a sventolare una saccenza compassata che vuole costringere gli individui a darci per “colti” in modo scontato. Dava l'impressione, a chi poco la conosceva, di non darsi troppa preoccupazione per ciò che gli altri avessero pensato di lei, del suo modo di vestire, del suo scarno vocabolario, di come flirtava, di ciò che pensava, ma, se la si studiava bene, agognava con tutte le sue forze ammaliare. Ammaliare non visivamente, o non solo, ma anche implicitamente. Amava fare la misteriosa e insinuare nella testa della gente la curiosità di chiedersi come doveva essere fatta.
Una vanitosa per principio.
E' incredibile, ma avevo sperato, fino a quel momento, di essermi sbagliato quando, quella prima volta che la vidi, diedi di lei il giudizio di “furba vanitosa” che mi era parso di vedere. Non volevo ammetterlo (soprattutto a me stesso), ma c'erano svariate possibilità che ci avessi preso.
Così passavo il tempo a cercare di non pensare a ciò che il mio cervello, e le situazioni tutte, m'imponevano di credere, e cioè, di trovarmi davanti alla stessa persona di quella sera in quel ristorante, il giorno del mio compleanno.
Siamo convinti che quel che pensiamo, spesso facendo dietrologia, sia sempre esagerato rispetto alla realtà. Soprattutto noi italiani, abituati ai misteri delle stragi di Stato, siamo fatti così. Sovente però accade che la dietrologia con la quale c'impacciamo i movimenti fisici e mentali, rimanga indietro rispetto alla realtà vera.
Questo succede per le stragi di Stato, ma anche per le considerazioni, amorose o di altro genere, che facciamo sulle persone che conosciamo. Così, a distanza di anni, veniamo a scoprire che l'ap-partamento nel quale fu tenuto prigioniero l'onorevole Aldo Moro era di proprietà dei Servizi Segreti, e che, facendo la perizia sonora al filmato di Zapruder che riprende l'attentato a Kennedy, si sente che i colpi sparati non erano tre ma addirittura dodici.
E' sempre peggio di ciò che possiamo arrivare ad immaginare.
Allora speravo che Marta non fosse così, ma lei pareva far di tutto per smentirmi. Io, per non essere costretto ad ammettere d'averci proprio azzeccato, continuavo a sostituire i miei istanti, quelli in cui più spesso mi sembrava di aver ragione, con altri spensierati, giulivi, giocondi, che non lasciassero il tempo a pensate premeditazioni. Ma si sa, “stupido è chi lo stupido fa”, e io, in quei frangenti, mi sentivo proprio un emerito deficiente. Il guaio era che ero cosciente di farlo apposta.
Talvolta paragonavo la mia situazione con Marta ai “diritti umani” più volte sbandierati dalle Nazioni Unite quando gli americani sono in procinto di far la guerra a qualcuno.
Si parla sempre di “diritti fondamentali” senza riuscire né a spiegarli né a specificarli. Perché accade questo? I diritti che c'imponiamo cambiano secondo cultura, gusti e priorità, sia morali che fisiche. Gli occidentali sono convinti che il Mondo sia solo il posto dove vivono loro, e non riuscendo a reprimere il vizio d'indossare abiti coloniali, cadono frequentemente nella tentazione di omolo-gare gli altri popoli al loro stesso modo di vivere. Questo succede col supposto “Villaggio Globale”, ma anche coi “diritti” che vo-gliamo imporre a popoli che non hanno la nostra stessa cultura. E' così che finiamo per perderci. E' come cuocere una quaglia in un lago. Le differenze sono tali e di una così enorme quantità che chi si avventura in quel labirinto sovente fa la fine di Icaro.
Marta, sempre implicitamente, sbandierava la sua sofferenza, ma in concreto era solo un meschino tentativo di attirare l'attenzione sul suo misero quotidiano. L'incosciente, però, ero solo io. Mi costrin-gevo a quel rapporto in cui ero sempre io a dare e lei a prendere. Perché lo facevo?
Ero innamorato. Innamorato di quel genere di amore che tutto perdona, che tutto copre, che tutto spera, più adatto ad una congregazione cristiana del primo secolo che ad uno squinternato rapporto d'amore del ventunesimo.
C'era, comunque, la musica a tirarmi su. L'unica cosa che pensavo assiduamente in quel periodo era come fare per avere la sala prove tutti i giorni e ad un prezzo ragionevole, accessibile a cinque disoccupati quali noi eravamo. Accadeva che suonavamo di frequente anche fuori dalla sala, in spiaggia o a casa di qualcuno di noi, ma questo avveniva quando eravamo ottimisti e ci facevamo prendere dal delirio di poter riuscire ad agguantare la fama, perché di solito eravamo quanto di più noioso potesse trovarsi sulla piazza.
I pezzi dell'album erano quasi pronti, ne mancavano giusto un paio, che comunque avevamo già, erano solo d'aggiustare un pochino. Ci fissammo un limite massimo e decidemmo d'incidere tutto il materiale pronto su nastro. Quindi l'avremmo dato al Gagliardi.
L’emozione era palpabile, il nervosismo anche. Soltanto io non ero eccitato, gli altri erano ormai diventati dei contenitori, degli scatoloni, dei bidoni di ottimismo, perfino Maurizio. L'unico mio ottimismo si risolveva in tre parole:
- Staremo a vedere.
SINDROME D'AMORE
I.
Durante i mesi in cui eravamo presi dal registrare il nostro disco non mi accorsi che in Marta qualcosa stava cambiando. Il nostro rapporto era diventato come una di quelle macchine da lavoro obsolete; appena qualcosa si rompeva era impossibile metterla a posto. Non per mancanza d'individuazione dei nostri sbagli o per qualche sciocco egoismo, era molto peggio.
Ciascuno di noi due si chiudeva in un silenzio materiale che poi era difficilissimo frantumare. Questo silenzio nasceva e cresceva per la nostra assoluta mancanza di vigore nell'affrontare i possibili contrasti, e i problemi, che all'inizio potevano essere risolvibili, piano piano si esacerbavano. Sia io che Marta volevamo avere ragione senza dibattere minimamente le questioni. Dopo qualche giorno finiva che uno di noi (quasi sempre ero io) si arrendeva. Questo avveniva, naturalmente, senza ammettere niente, ma a Marta, quelle poche volte che si costringeva a darmi ragione, e a me non importava far chiarezza sugli eventuali incomprensioni, ma solo sentirci vincitori.
La sua vanità era più mitigata, adesso, e seguiva solitamente il suo umore. Quando era contenta, felice, mi riempiva di coccole, mi vezzeggiava, e ripeteva che mi amava. Il problema era che quella buona vena la faceva cadere nella tentazione di sfoggiarsi, di farsi ammirare. Quindi, proprio da poveretto, frequentemente mi sorprendevo a sperare nel suo broncio, nelle sue arrabbiature, perché quando era inquieta si dimenticava, forse, dell’esistenza degli altri uomini. Ecco, non era improbabile che la sua irrequietezza fosse l’unica condizione morale che aveva la potenza di cancellare, per qualche istante, la sua vanità, il suo esibizionismo.
Tutte queste situazioni io le vivevo con l’animo del condannato.
Avevo il terrore, una paura fottuta, delle sue reazioni. Tale fobia sconfinò presto in alcuni ridicoli, anche se perfettamente comprensibili, comportamenti.
Mi accorsi che la mia condizione d’onomatopeista stava peggiorando sempre più. Così presi il vizio di viver le giornate con gesti e situazioni palliative. A volte guardavo la vetrina di un negozio nel quale Marta frequentemente si fermava, e, illudendomi di riprendere da essa ciò ch’essa un dì catturò, verosimilmente l’immagine di lei, passavo alcune mezzorette a scrutarla come fa un basista preparando un colpo in una Banca.
Molto spesso mi accadeva di annusare i suoi vestiti, frutto, dopo aver fatto l’amore, di sue dimenticanze, o di cercare nei miei il suo profumo, come se quel contagio fosse anch’esso una dimenticanza che mi offriva l’occasione di annullare, fra noi, la momentanea distanza. Fissavo le altre ragazze tentando di scorgere in loro una qualche somiglianza d’espressioni facciali o di gesti cadenzati che permettessero alla mia memoria un più facile richiamo di lei, delle sue smorfie e del suo modo di voltare la testa altrove. Mi ritrovavo a pensare: “Ecco, i suoi capelli”, vedendo i capelli di un’altra, oppure: “Quella gonna ce l’ha anche lei”, sperando che colei che l’indossava fosse una sua cara amica, qualcosa e qualcuno che potesse riaccostarmi, sebbene soltanto nella fantasia, alla sua vita, e, tramite questo riavvicinamento, a vivere più intensamente la mia.
Parlavo con la sua inflessione, usavo vocaboli suoi, gesti che non mi appartenevano e pensieri che non molto tempo prima avrei ritenuto stupidi, ma che quell’oggi mi riempivano della sua presenza. Una sorta di “effetto placebo” che mi aiutava non solo a sopportare la sua lontananza, ma addirittura a goderne.
Prendevo la sua personalità per mano e la plasmavo, cosa che Marta non mi permetteva di fare. Ne ricucivo gli strappi, facevo carezzevoli orli, appuntavo ghirlande meravigliose di baci e abbracci profumati, abbacando, speranzoso, che l’abito appena imbastito un giorno potesse diventare reale, della mia taglia.
Cadevo sempre più spesso in questo meccanismo, perché il mio cuore lo viveva con tranquillità, tranquillità che al suo cospetto mi mancava. Com’è naturale, data l’assenza fisica, da parte sua non c’erano reazioni, in quelle mie fantasie, e di conseguenza il mio rapporto con lei era senza rischio alcuno. Soltanto lontano da Marta il mio amore viveva compiuto e senza timori.
Col gruppo si era tutti presi a voler registrare i nostri pezzi su nastro, e tutte le altre questioni passavano in secondo piano. Io ero sempre poco convinto delle nostre possibilità, gli altri invece credevano nel loro talento. Gagliardi era un maestro nel “montare” le persone. Non voglio dire che avesse sempre torto in ciò che faceva e diceva, ma la sua eccessiva sicurezza, che spesso sconfinava nella supponenza a tal punto che lui arrivava perfino a negarci delle spiegazioni, mi dava ai nervi.
Non molto tempo dopo l'inizio dei nostri rapporti capii di trovarmi di fronte ad un mistificatore senza scrupoli. Sicuro, non gli dissi niente perché, stando ai fatti, era anche l'unico che credeva in noi, nelle nostre possibilità, ma seguitava a non piacermi. Gli altri del gruppo invece erano affascinati dalla sua figura e, sempre smaniosi di mostrargli arrendevolezza e acquiescenza, facevano a gara per leccargli il culo. Io, che non sono mai stato uno portato ai facili guadagni o a mercanteggiare certi favoritismi, mi tenevo in disparte.
E' anche vero che Gagliardi non mi era piaciuto, e questo da subito.
Spesso mi chiedo perché appena abbiamo la possibilità di sapere qualcosa in più della persona che or ora abbiamo conosciuto, crediamo che è proprio in ciò che non sapevamo (e che, siamo convinti, lui volutamente ci nascondeva) il suo vero animo. A molti capita di considerare una persona, l'essere di una persona, soltanto per quanto di negativo ha fatto. Le cose positive non contano, crediamo sempre che siano casualità o, ancor peggio, d'essere in grado di poterle fare anche noi.
Di Gagliardi seppi che era un manipolatore d'individui, un aguzzino succhia sangue e un personaggio poco chiaro. A questo punto tutto ciò che di buono aveva fatto, scoperto gruppi e cantanti nuovi e di successo, promosso serate di vera solidarietà (!), aver portato alla celebrità, col suo managerismo, parecchi artisti, passava in secondo piano. Mi ero convinto d'aver davanti soltanto il manipolatore d'individui e l'aguzzino. Non so spiegarmi per quale motivo il bravo manager e l'ansioso umanista erano scomparsi.
Ma, andando avanti, anch'io mi stavo pian piano convincendo che tutto dipendeva davvero da noi. Mi ero forse fatto raggirare come gli altri? Mi accorsi che sempre più spesso mi perdevo ad immaginarmi famoso e ricercato. Mi stavo illudendo, come i miei compagni, che potevamo farcela, dicendomi che in fondo anche chi adesso era famoso prima di diventarlo era stato, come noi, un perfetto sconosciuto. Perché non poteva capitarci la stessa cosa? Per un breve periodo arrivai al punto di credermi un artista. Quell'esaltazione non durò molto tempo, è vero, ma anch'io l'avevo avuta. Come se avessi commesso un omicidio, speravo che nessuno si fos-se accorto di niente.
Chissà per quale tortuosa via siamo arrivati a definire “artisti” tutti coloro che si occupano di qualcosa d'affine all'Arte e non, come sarebbe ragionevole, chi Artista lo è davvero. Oggi non serve esser capaci di recitare per diventare attori, basta soltanto lavorare in un film. Così vediamo modelle e ninfette televisive che vengono assunte da produttori furbi e registi incapaci che hanno solo la malizia di sfruttare la loro popolarità, ma che davanti ad una cinepresa fanno venire il voltastomaco. Il guaio è che poi, dopo aver “girato” uno di quei films italiani di tradizione natalizia, vengono considerate davvero delle attrici. Come se non fosse già abbastanza esagerato parlare di quelle pellicole come se fossero films, uno quando lo fa è costretto anche ad innalzare quei cani che ci lavorano ad artisti veri.
Quando ripenso alle considerazioni che facevo allora, mi ritrovo a sorridere ingenuamente di me stesso, della mia strana e centellinata vanità, di quel futile compiacimento da cinquantenne che per la strada si accorge di essere guardato da una donna.
Un individuo che si autodefinisce “artista” non riconoscerebbe un artista vero nemmeno se gli cascasse sulla testa. L'artista che fa considerazioni sulla sua arte, su ciò che ha creato, è come un organo in mezzo ad altri organi in un medesimo corpo, i quali, non avendo alcuna percezione di sé stessi, non sanno dell'esistenza di altri organi né della loro in quanto organi. Un artista vero non ha percezione dei suoi lavori. Poverino, lui non lo sa di essere artista! In quanto appassionato ed esperto può giudicare e considerare solo i lavori altrui, le creazioni di altri artisti, ma mai la sua, tanto che quando butta giù la bozza di una opera, per correggerla e cercare di migliorarla, ha bisogno di allontanarsi da lei per qualche tempo, quello che serve per perdere confidenza con la sua creazione, in modo che confutandola abbia la distanza necessaria per sviluppare uno spirito critico e quindi migliorarla. Un disco, o un libro, sono come l’imbottigliamento di un vino; per dire se è buono bisogna lasciarlo invecchiare. Chi si autodefinisce “artista” non sa proprio che sia l'arte. La vicinanza appiattisce tutto, così che la nostra capacità di giudizio ne risente e noi perdiamo il giusto arbitrio che ci consentirebbe di fare una valutazione onesta, obiettiva, e quindi un’analisi esatta che ci aiuta a capire pecche e virtù, cosa tenere e cosa scartare.
Giudicarsi dal di dentro non è facile per nessuno, a prescindere che si sia artisti oppure no, e Alessandro, per esempio, che in quanto a musica sapeva distinguere un'armonizzazione jazz da una di altro genere, un quattro quarti da un sincopato, un andante da un allegro, spacciandosi per artista voleva sì convincere gli altri, ma soprattutto voleva persuadere sé stesso di esserlo davvero.
L'artista non è capace di giudicare la sua opera più di quanto un qualunque essere umano sia in grado di giudicar sé stesso in fatto di bellezza fisica. Gli altri del gruppo questo non lo capivano, infatti, tutti quanti, si credevano degli Adone.
Quello fu uno strano periodo. Mi spiavo e scoprivo di avere anch'io quella vanità furba che avevo scorto in Marta. Allora subito me la rimproveravo, e, soffocandola, mi sentivo a pieno titolo parte del mondo, di quel conformismo da cui avevo sempre cercato di stare alla larga. Così passavo le giornate ad autocompiacermi e a rimproverarmi. Soffocavo la mia vanità senza ucciderla del tutto. Quando vedevo che stava per morire allora allentavo la presa e mi facevo cullare per un attimo dal suo dolce tepore che, immediatamente, mi conquistava lasciandomi inerte e inebetito. Non appena mi riprendevo tornavo a soffocarla.
Il moderno universo musicale, con le sue vanità, coi suoi falsi approcci all'umanesimo, alle solidarietà fatte per forza e per denaro, all'arte che ammicca o a quella viscerale, pare, se visto da vicino, come una di quelle prostitute che dopo aver battuto i marciapiedi per anni, ora si sentono in fase calante e decidono di ritirarsi, di andare in pensione. Arrivano a propinarsi un illusorio ragionamento secondo cui “anche se non sono affatto male è arrivato il momento di smettere”. Si concedono, però, l'ultima strombazzata, for-se ad una festa di compleanno, o ad un pranzo di matrimonio, quando si tolgono lo sfizio di fare ciò che avevano sognato da sempre; l'amore in piedi col Capocuoco, magari in cucina, dove da un momento all'altro può entrare qualcuno.
Il mondo della musica accende e spegne fiaccole d'arte nel giro di pochi anni. Quando quello che è sempre stato considerato un artista si rende conto di non riuscire più a vendere dischi, o di non essere cercato da giornali e Tv, o di non avere più niente da dire e, di conseguenza, di non riuscire a creare più niente, allora si attacca alle code di qualche personaggio di cultura.
Che si comportavano in questa maniera, in quegli anni, ce n'erano parecchi. Generalmente si attaccavano alla coda del frac di Luciano Pavarotti, in quel tempo considerato l'uomo di cultura per eccellenza. Lui non se ne curava troppo. Portava i vari falliti in giro per il continente come alla mattina, poco prima di andare al lavoro, si porta il cane a pisciare.
Noi del gruppo chiamavamo questi “eventi” (com'erano considerati dal loro ameno pubblico, da sprovveduti giornalisti e da quelle Tv che avevano la necessità di spacciarli come tali agli agenti pubblicitari che volevano acquistare uno spazio dentro quelle “pagliacciate di spettacoli”) “Le Pavarottate”. Gli “artisti” che vi partecipavano e cantavano e suonavano con lui, erano coloro che facevano parte della “Corte dei Miracoli”. I loro concerti erano “sfilate per la fame nel mondo”. Quando vedevamo qualcuno comportarsi da ipocrita, celiando, dicevamo che era un candidato al prossimo premio “Pavarotti and friends”.
Te li vedevi, vanitosi, consci d’esser riusciti a portare a termine il percorso che avevano sognato fin da piccoli, rispondere con sufficienza a chi li intervistava, fare autografi senza neppure guardare in faccia i loro fans, e alla Tv salutare con poca importanza il pubblico a casa, certi di essere superiori decine di spanne a loro. E poi la solidarietà.
C'è una sottile e ipocrita voglia di crudeltà in coloro che spacciano “pubblicità a proprio favore” per solidarietà. Evidentemente ci hanno preso proprio per coglioni. Il falso altruismo che quegli “spettacoli” ributtanti emanano, è una sorta di territorio neutrale, un porto franco dove si “mollano” chewin gum e tonnellate di caffè da regalare ai poveracci scaricandosele sulle tasse e avendo un sicuro “ritorno pubblicitario”. Ed è pubblicità, questa, che non ha valore quantificabile, tanto vale e tanto costa.
Nel mondo ci sono artisti che hanno costruito la loro carriera facendo solidarietà. Pensiamo un po’ ad alcuni dischi contro la guerra o la fame nel mondo che vengono spacciati dai loro autori come “veicoli esenti da speculazioni e guadagni”. Che vergogna. Non c'è guadagno migliore per un artista di quello che lo presenta al mondo intero come uno “spassionato filantropo”. Pensate un po’ a quanto avrebbero dovuto spendere in pubblicità per presentarsi, ed essere inferentemente considerati, come “artisti umanitari”. Non c'è prezzo che si possa pagare per la propria reputazione, e questo ragionamento ha sia andata che ritorno. Nel mondo dell'arte di reputazioni ci si campa. Non è un caso che i fatti personali, la vita privata dei personaggi ritenuti di spicco, sono sempre eventi da prime pagine di giornali scandalistici e non, e mi fanno ridere quelle star che si arrabbiano quando i giornalisti vanno a mettere il naso nei loro fatti privati. Evidentemente ritengono che i soli fatti che li riguardano e che debbano essere divulgati siano quelli in cui hanno qualcosa da guadagnarci, come quando fanno finta di fare solidarietà. Chissà perché rendere pubblico il fatto che loro siano personaggi con una forte umanità non li infastidisca.
Cari miei, se accettate di farvi belli con quelle notizie, dovete accettare anche che vi si faccia brutti con altre meno lusinghiere, altrimenti rendetevi agnostici, impersonali, e occupatevi solo della vostra arte, senza cercare sotterfugi che vi facciano guadagnare di più. Ragazzi, di Gesù ce n'è stato uno solo, per questo siete poco credibili.
Per tali motivi reputavamo questi “artisti” alla stessa strenua delle meretrici. La vera solidarietà non si può fare che restando nell'anonimato, perché al macellaio non costa nulla regalare un pezzo di carne ad un barbone. Magari del giorno prima, come sono certe “canzoni umanitarie”; un giro di Do, tre facce famose, un bel video, e giù coi contenuti umani! Ma perché gli artisti non s'infilano le mani in tasca e tirano fuori un po’ di moneta sonante? Se è solo una questione di solidarietà come dicono, in questa maniera rinuncerebbero davvero a qualcosa che gli appartiene per una giusta causa, no? La verità è che si potrebbe fare la stessa operazione senza dire che è per solidarietà, ma in quel caso mancherebbe il ritorno pubblicitario.
Sono sicuro che facciano più solidarietà trenta secondi di lacrime sincere che cadono sul viso di un individuo chiuso nella propria stanza, piuttosto che tutti i soldi che possono dare le rock star o i divi cinematografici e televisivi. Come disse Cristo, “a suonar la trombetta dinanzi a sé si ha appieno la propria ricompensa”.
Ridevamo spesso di queste cose, giusto per non piangerci, ma credo che molti di noi agognassero finire nel “calderone Pavarottiano” o nel giro della solidarietà catodica.
La persona che meno di tutti credeva nelle nostre possibilità era proprio Marta. Non ho mai capito se la sua era invidia o ciò che lei riteneva consapevolezza dei nostri mezzi, sta di fatto che non perdeva occasione per tirarmi giù il morale o cercare di disilludermi. Non so perché. Probabilmente per la nostra confidenza. E' più semplice alzare la voce con un parente o con un amico che con uno sconosciuto, perché in questo caso si è ignari della capacità e qualità di reazione.
Lei, come quell'abbronzatura che si prende involontariamente, lavorando o facendo qualsiasi altra cosa, pareva portasse in sé una sorta d'invidia condizionata.
Ma non era proprio colpa sua. E' comico come molto spesso siano proprio le persone che conosci meglio a non avere fiducia in te e in quello che fai. Senza alcun dubbio questo avviene perché devono avere un'alta considerazione del giudizio che hanno precedentemente dato su di te. Gli sembra strano di quanto puoi rivelarti più di quello che ti avevano valutato, stimato. Presumibilmente ognuno di noi (e io ne sono un chiaro esempio) è convinto di non sbagliarsi mai, e dover cambiare idea o giudizio, e quindi approccio con chi si crede di conoscere perfettamente, non fa piacere a nessuno.
Nel Vangelo abbiamo l'esempio di Cristo, che quando tornò nel suo paese natio con la nomea di profeta nessuno gli credette. Penso che quando fece riferimento all'impossibilità d'essere profeta in patria, intendesse sottolineare proprio quest'aspetto.
Si sa, siamo talmente presuntuosi da avere la certezza di conoscere soltanto persone mediocri, o, al massimo, alla nostra stessa altezza. Ma quando un nostro conoscente si rivela essere meno mediocre di ciò che avevamo pattuito con noi stessi, allora è lì che può nascere l'invidia, la gelosia, la derisione, addirittura l'odio.
Marta aveva sempre conservato e nutrito la consapevolezza che, se mai ci avesse provato, poteva riuscire a fare quello che facevo io. Si è sempre considerata al mio stesso livello, se non migliore di me, e nessuno avrebbe potuto farle cambiare idea.
Quel che facevo erano sempre sciocchezze, ciò che dicevo, per quanto originale potesse essere, non era certo distante da quel che poteva pensare o dire lei, i miei amici erano tutti scemi, i miei gusti noiosamente scontati, le mie donne passate delle ninfette, la nostra musica una stronzata. Era talmente sazia di sé che si vomitava di continuo.
Spesso mi chiedevo perché stava con me.
Inutile dire che lei, delle cose succitate, non faceva nulla. Non lavorava che saltuariamente, non aveva terminato gli studi, non aveva hobbies e neanche tante amiche. Aveva continuato a farsi mantenere dai suoi genitori, e sovente pareva dire che ciò che le davano glielo dovessero. Ma, a sentire Marta, non aveva incertezze né sul suo futuro, né su quello del mondo, e neppure sul mio.
Qualche volta, quando avevamo litigato, le scappava di dire che ero un fallito. In realtà era lei ad essere la rappresentazione fisica dell'insuccesso.
Continuava a viversi addosso senza pensare che chi la manteneva, i suoi genitori, viveva di una misera pensione. Trascinava le sue giornate senza far nulla, aspettando la sera per andare in giro ad atteggiarsi o per vedersi con me. Le sue movenze vantavano sapienza e saggezza, ma la sua conoscenza, benché non fosse da “anacoluta”, non era di altissimo livello, e anche quel poco che sapeva era il chiaro risultato di anni passati a non fare nulla.
L'unica differenza che c'era fra me e Marta, era che io non mi repu-tavo di un livello assai maggiore degli altri, perfino di lei, e che non facevo niente per nascondere questo fatto. La consapevolezza delle mie meschinità la mandava su tutte le furie, tanto che a volte dovevo preoccuparmi di tranquillizzarla dicendo:
- Non hai capito. Guarda che parlavo di me.
Lei, che era cosciente del fatto che tutti ci sapessero fidanzati, mi rimproverava queste ammissioni di nullità, ed era portata a farmene una colpa. Io mi sentivo innocuo, e tutto ciò che potevo rispondere a lei che mi guardava cercando di celare l'ira, era di non prendersela più di tanto per le pochezze altrui, fossero le mie o di qualche sua amica o del mondo. L'unica cosa a cui non c'è rimedio sono le altrui insofferenze.
Fu così che scoprii una Marta ambiziosa, che non curava, è vero, la materialità, ma che non disdegnava neanche poter vantare le eventuali qualità di quello che riteneva essere il suo ragazzo, cioè io.
Ancora non capivo di quale genere di amore soffrisse Marta. Ero più che certo dei miei sentimenti verso di lei, anzi, sovente ero succubo di loro poiché non potevo reagire, quando lei mi attaccava, per paura che tutto finisse. Marta, che se n'era accorta, un po’ con questa realtà ci giocava, assai frequentemente facendomi passare per un poveretto senza rimedio, fottuto a vita. Io ero diventato uno squallido cerchiobottista. Davo un colpo a Marta, il cerchio, per non dover litigare di continuo, e uno alla botte, me stesso, quando ero da solo, per darmi ragione, perché forse, come scrisse Andrè Gide, questo “mi consolava di non avere altro”.
Sono fermamente convinto che Marta fosse una di quelle ragazze che una volta esser riuscite a conquistarci credono che quella “cattura” valga una volta per tutte. Lei dava per scontato il nostro rapporto. Poco ci teneva a dimostrarmi il suo amore, e sicuramente si guardava bene dal farlo davanti ad altri uomini, categoricità che le avrebbe precluso il loro l'interesse e, in tale modo, la possibilità di appagare la sua vanità.
Questo non darmi troppe sicurezze che mi avrebbero permesso di guadagnare terreno nei suoi confronti, ho il dubbio fosse una tattica studiata a tavolino. Marta rientrava nella categoria di donne che riescono a tenere il loro uomo per le palle soltanto grazie alle inequivocabili ammissioni d'amore che lui le ha fatto. Era sicura che l'amavo, e usava il mio amore come un'arma subdola.
Raramente si faceva sfuggire un “Ti amo”. Era la sua forza, questo centellinare ammissioni. Io, in quell'oggi, rimpiangevo il fatto di essermi così esposto, ma ormai non potevo più tornare indietro. Tutto questo suo giocare l'avevo capito fin dal principio, ma avevo ritenuto che se mi fossi sciolto io per primo, forse si sarebbe addolcita. Che errore! Uomini, dite “ti amo” alle vostre donne solo salendo i gradini della chiesa, tutt'al più il giorno che le lasciate.
Talvolta mi chiedevo se questo suo modo di amare non fosse una specie di sindrome, una sindrome d'amore. La speranza di piacere, di essere amata, di essere considerata, la portava a ricercare la “visibilità” in maniera esasperata. Oggi penso che non era poi tanto strano quell'amore spiato, confabulato, sussurrato per non farsi sentire, annacquato. Ciò che allora non potevo sapere era dove la sua vanità poteva portarla, ma da lì a qualche tempo me ne accorsi a mie spese.
II.
Marco Gagliardi era certo della venerazione che gli portavamo e a cui alcuni dei miei compagni lo sottoponevano ogni volta che ve-niva a trovarci in sala prove, e che lui se ne compiacesse saltava agli occhi.
Erano soprattutto Alessandro e Giacomo a stargli addosso, a corteggiarlo come si può corteggiare un boia la vigilia della propria esecuzione. Io me ne stavo lontano. Le lusinghe non sono mai ri-uscito a digerirle, sia che avessi dovuto esserne il mittente, sia quelle volte che mi era capitato di esserne il destinatario.
Gagliardi dissimulava sicurezza, ma non era di quelle sicurezze che non tengono conto degli altri perché si basano su ciò che esse stesse hanno, ma di quell'altro tipo che fa leva sulle debolezze altrui, sulle carenze e sulle ambizioni. A lui doveva apparire piuttosto chiaro che noi eravamo dei ragazzotti che non sapevano nulla di mercato discografico, e che quindi, quasi a nostra insaputa, eravamo assai proclivi alla simonia o a cadere nelle braccia delle facili promesse.
Chissà, forse io e Maurizio avevamo sbagliato fin dalla sera in cui lo conoscemmo, quando, ingenui, dicemmo che i nostri compagni tutto facevamo per vanità, così lui, che lo aveva constatato, adesso se ne approfittava.
Il giorno che venne a prendere in consegna il nostro nastro, tutti noi, compreso me, eravamo eccitatissimi. Quell'esaltazione era il frutto dell'illusione di saperci ricercati e, anche se non morbosamente desiderati, importanti per qualcuno. Questo, per il momento, pareva bastarci.
Gagliardi fece tutto il possibile per metterci a nostro agio in casa nostra. Sembravamo una di quelle famiglie povere alle quali è toccata la sorte di essere visitati dal Papa.
Ogni giorno che passava mi sorprendeva a fare comparazioni fra il mio amore per Marta e la mia vita di musicista. Mi chiedevo sempre più spesso se stare con Marta non fosse una maniera per appagare quel rimasuglio di vanità che era rimasta nel mio corpo dopo averla combattuta, come se fosse il resto di un'armata vinta dopo una guerra, la cui prigionia è solo qualcosa che rallenta le operazioni, le tattiche del Generale sul campo di battaglia. Avevo lottato sperando di poter vincere il compiacimento provato a stare sul pal-co, davanti alla faccia degli spettatori, ma forse quel che avevo creduto una facile vittoria non era che una trasposizione, una sostituzione, uno spostamento della mia vanità dagli occhi del pubblico a quelli di Marta.
In quei giorni così febbrili di attesa io avevo completamente trascurato Marta, e lei ne soffriva. Fondamentalmente era una donna sola, che cercava di nascondere la sua solitudine dicendo che del mondo se ne fregava. Ma aveva bisogno di uscire lei, uscire con me, farsi vedere in giro, guardare ed essere guardata, frequentare feste futili e futili amicizie, andare al cinema, nei locali, per negozi, al mare….
A certa gente basta “andare”. Credono che la mobilità riesca a mascherare tutto, perfino la loro pochezza. Così ci si finge viaggiatori, scopritori, consideratori, pensatori che non possono stare fermi perché devono appagare le esigenti richieste del proprio cervello. Magari andando in discoteca la sera, o al ristorante, o a cena a casa di amici, bevendo, fumando e vomitando enfasi e crucialità su discorsi sentiti la sera prima in qualche squallido talk show progressista (quella demagogia umanitaria di cui una parte politica vuole appropriarsi), e ripetuti arrogandosene la paternità, stando bene attenti che in giro non ci sia qualcuno, ogni sera puntualmente rilevato dall'Auditel, spettatore fedele di quello stesso programma. Io, che in quel periodo non avevo molta voglia di mostrarmi al mondo, rispondevo quasi sempre di voler stare a casa. Lei allora diceva:
- Come fai a scrivere se non vedi mai nessuno? Se non conosci la gente? Se non la frequenti?
- Guarda che la gente la conosco già, - rispondevo io - e non mi fa una grande impressione. Conosco abbastanza di loro da preferire di stare a casa, lontano da tutto e da tutti.
La “disillusione iconoclasta” di Marta era già svanita.
Talvolta il suo amor proprio e la sua vanità la portavano ad uscire da sola, ma non sapeva dove andare e un paio d'ore dopo era già di ritorno. Non ammetteva nulla, ma probabilmente senza di me si sentiva fuori posto dappertutto. Non ch'io fossi uno che sapeva vivere o che la facesse particolarmente divertire, ma perché, da vani-tosa, l'unico modo che aveva di far passare il tempo era quello di compiacersi.
Un sistema che aveva preso ad usare sempre più spesso per appagare la sua vanità, era quello di vedere nei miei occhi quella gelosia infantile che lei amava causarmi facendo la stupida con qualche semi sconosciuto o con uno dei miei compagni del gruppo. Per far questo non le serviva tanto, giusto qualche occhiata prolungata, o due paroline a doppio senso dette per scherzare. Il Dubbio si era talmente impossessato di me che a Marta bastava davvero poco per farmi ingelosire.
Ogni tanto Maurizio, quando non era troppo “fatto”, mi chiedeva dove trovavo la forza per non mandarla al diavolo. Domanda a cui non sapevo rispondere se non in modo evasivo e per nulla convin-cente. Qualche volta ammettevo che ne ero innamorato, quand'ero in forma, ma questa scusa non sembrava risolvere la questione una volta per tutte. Riuscivo soltanto a riciclare eternamente la domanda e a cambiare discorso. Maurizio, proprio lui, mi guardava come se fossi uno del Terzo Mondo.
Loro non erano come me, loro riuscivano a non innamorarsi delle loro ragazze, riuscivano a tenerle a distanza. Chissà, forse proprio perché erano vanitosi, e cercando di nutrire la loro vanità rendevano le loro storie d'amore poco importanti.
Gagliardi doveva portare i nastri al Produttore, un tipo per il quale la musica era solo business. Noi dovevamo aspettare. Era riuscito a persuaderci che potevamo aver fiducia, e noi eravamo eccitati come una diciottenne al ballo delle debuttanti.
Dal giorno in cui consegnammo il nastro al Gagliardi fino a che non ci diede risposta, continuammo a vederci e a suonare nel locale, anche se eravamo pagati da fame. Quei pochi soldi ci servivano per mandare avanti la baracca restando lontani da quel tipo di vita che assorbe gli individui omologandoli. Tutto il gruppo era sicuro di non voler fare la vita della normale umanità, affogati dentro la quotidianità del lavoro secolare, mischiati ad un via vai di vite che aspettano la Domenica per dormire qualche ora in più, la fine del mese per intascare l'agognato e sempre insufficiente stipendio, e il Sabato per consumare uno squallido e scontato rapporto sessuale con la propria partner. Non la consideravamo vita per noi.
Eravamo certi che la vita dell'artista fosse un'altra cosa. In giro per concerti, adorati da folle di fans in delirio, continuare a fare musica divertendosi, conquistare ragazze col semplice schiocco delle dita (ah! come davvero tutta la ricerca disperata della “dèa-cagna” si risolva in questo!) ed essere vitali. Inutile dire che ci accorgemmo anche troppo presto che le cose non stavano messe proprio in quella maniera.
Dopo tre settimane Gagliardi ci venne a trovare in sala. Appena varcò la soglia di quel confuso e abborracciato puzzle, lo tenemmo sotto scacco con gli occhi trattenendo il fiato. Dopo averci sotto-posto ad un discorso di circostanza che sicuramente doveva essersi preparato prima, prese respiro e guardandoci negli occhi disse:
- Ebbene, ragazzi. Il Produttore ha deciso di metterci i soldi. Dovrete accettare qualche cambiamento, ma è il minimo. Domani mattina passate da me per il contratto. Alle undici in punto. Vi farò sentire il vostro disco, il risultato finale.
Appena Gagliardi uscì esultammo come hooligans inglesi e decidemmo di andare a festeggiare. Andammo tutti a casa a prepararci. Prenotammo al Ristorante in cui vidi Marta per la prima volta. Portammo le rispettive fidanzate e invitammo qualche amico.
Quando raccontai tutto a Marta lei mi sembrò felice, felice per me. Stranamente non mi fece nessuna raccomandazione né critiche e non ebbe da ridire su niente. Si preparò, come le fidanzate degli altri del gruppo, e uscì con me tenendomi il braccio.
Quel giorno rividi la Marta di qualche tempo prima, quando, per la seconda volta, l'avevo conosciuta. Simpatica, affabile, intelligente, per nulla vanitosa. Passammo la serata a ridere e a scherzare. Pareva d'accordo con tutti, e tutti, a loro insaputa, erano d'accordo con lei. Non aveva voglia di litigare e si comportava cameratamente. Di nuovo mi chiesi se non mi fossi sbagliato nel giudicarla.
Chissà se quello era davvero lo specchio fedele dell’anima sua. Certamente era quello da me preferito, quello nel quale adoravo rimirarmi.
Quella serata finì, come ci accadeva molto spesso quando anda-vamo a mangiare fuori tutti insieme, in sbevazzamenti e comportamenti molesti. Alcuni di noi s'atteggiavano già a star mondiali della musica, nonostante ancora non avessimo fatto neppure il primo passo per essere conosciuti e apprezzati.
Quel che ancora non eravamo si rivelò completamente la mattina dopo, quando, baldanzosi ma diffidenti come cuccioli lontano dalla mamma, entrammo, alle undici in punto, nell'Ufficio del signor Gagliardi. Era in piedi e, piegato sulla poltrona nella quale, accanto al Produttore Lopresti, era seduto un signore alto, che non rideva mai, impomatato come un mafioso americano degli anni quaranta, e vestito con un abito completamente nero, da noleggiatore di sedie di fine ottocento, parlava come un'ex muto miracolato da poche ore.
Salutammo interrompendo quella logorroica cascata di parole. Dopo aver scoperto l'ABC del managerismo discografico, scherzando e ridendo, ci apprestammo a firmare un pezzo di carta che confermava quanto poco spazio ci sia per i sentimentalismi artistici. Si chiamava “Contratto”, e nel corso degli anni ne avremmo firmati a decine.
Gagliardi fece portare da bere e brindammo a quello che doveva essere un nuovo rapporto di lavoro. Dopodiché Lopresti e l'altro signore se ne andarono.
Soltanto allora Gagliardi ci portò in una sala attigua a sentire il risultato finale, il master del nostro disco. Tutto ci saremmo aspettati da uno come lui, ma non ciò che in verità ci fece.
Quando ascoltammo quel nastro stentammo a riconoscerlo. Gagliardi lo aveva completamente cambiato. Aveva rimixato con ar-chi e violini tutto il materiale che gli avevamo dato. Lui diceva che così avrebbe funzionato, avrebbe avuto successo, avrebbe venduto.
Gli altri, ecumenicamente acquiescenti, risposero che andava bene ugualmente. Solo io e Maurizio ci sentimmo derubati di ciò che sentivamo come nostra eredità, nostra creazione, come nostro figlio. Lui si girò verso la finestra e, appoggiato al davanzale, prese a guardare fuori nero di rabbia. Io, fissando il Gagliardi che cercava di fuggire il mio sguardo, dopo pochi minuti aprii la porta e me ne andai.
Girovagai per qualche ora, entrando in diversi bar e bevendo per calmare la rabbia. Poi andai sul lungo mare, scesi in spiaggia e mi adagiai sulla sabbia a pensare.
Ci aveva fregato. Aveva fatto del nostro disco il suo disco, e del nostro modo di concepire la musica nient'altro che spazzatura da gettare via. Ero incazzato col mondo intero. Deluso, amareggiato, distrutto e seriamente intenzionato ad abbandonare tutto quanto, Gagliardi, gruppo, locale e forse anche la musica. Ci era successa la stessa cosa che accadde ai Genesis col loro primo disco, allorché Jonathan King riempì “From Genesis to Rivelation” di arrangia-menti fatti con archi e violini, togliendo a quel disco la sua genuinità. Noi eravamo stati privati della nostra personalità. Marco Gagliardi, questa faccia da “mandilla”, in pratica ci aveva strappato il volto.
Ma soltanto io e Maurizio sembravamo dispiacercene. Per gli altri tre questo fatto non aveva molta importanza. Non si erano ben resi conto che da compositori erano diventati, senza esser stati avvisati, dei semplici esecutori, interpreti. O forse era anche peggio, forse se ne erano accorti benissimo, ma, vanitosi, potevano assumersi la re-sponsabilità d'aver inciso qualsiasi cosa, d'essere accusati di stupro o di omicidio, se il diretto risultato fosse stato il successo.
Dopo un breve giro di parole si erano fatti convincere dal Gagliardi che, per prima cosa, l'importante era farsi conoscere, l'appagamento artistico poteva venire dopo, più tardi, col tempo. E loro avevano annuito come scolaretti rimbrottati dall'insegnante.
Con le scarpe piene di sabbia pensai che Marta avrebbe saputo inevitabilmente tutto, e di conseguenza mi avrebbe giudicato un imbecille, l'ultimo degli sprovveduti. Questo m'infastidiva parecchio, ma era pressoché impossibile nasconderle quello che era successo. Avrebbe comunque saputo. E' strano, ma ricordo che non m'interessava di come mi avrebbe giudicato come uomo, ma ciò che avrebbe pensato di me quale artista. Anche se non ero ancora completamente entrato nell'ottica di considerarmi uno affine all'arte, quel che più mi premeva era non essere reputato una bagascia da poco prezzo, uno che si vende per cercare il successo, per essere riconosciuto quando camminava per strada e per avere stuoli di fans alle calcagna.
Ma chissà, forse anche quella era vanità. Sapevo che non mi sarebbe dispiaciuto essere considerato per la musica che facevo. Purtroppo, però, mi rendevo anche conto che quasi mai è così.
I fans giudicano gli artisti di cui sono gli accoliti non per la loro musica, ma per come si vestono, perché sono conosciuti, perché sono carini, perché sono contro la guerra, contro le armi, contro la fame nel mondo, contro l'Aids, contro la caccia alle balene, per la salvaguardia del panda, del canguro australiano, per la ricerca con-tro il cancro e perché sono sempre in televisione o sui giornali, insomma, delle “politicamente corrette” facce di merda. Niente accenno all'arte, alla loro musica.
Anche i nostri fans, quei pochi che fino ad allora avevamo, ci apprezzavano perché in città eravamo conosciuti e non per il motivo per cui lo eravamo. Per loro potevi essere famoso solo perché eri un terrorista, un assassino, un serial killer o un bombarolo, poco importava. Anche il nostro pubblico riteneva che fosse indispensabile uscire dall'anonimato, perché è la strada più semplice e veloce per poter bruciare vanità. Io non ne potevo più d'esser ritenuto uno da conoscere per potersi vantare.
Avevo la mezza idea di abbandonare tutto. Quel genere di vita era ad un passo dal deludermi compiutamente.
III.
Quando una qualsiasi cosa che avevi desiderato e sperato ti accadesse ti si ripresenta, una volta raggiunta, come cosa trascurabilissima, sentirsi la delusione addosso è più che scontato. Chissà perché quasi tutte le persone credono che nel mondo dell'arte, sia essa musicale o letteraria o di altri generi, siano necessarie, per entrarci e rimanerci, particolari qualità morali. Nulla è più falso. Ci vorrebbe troppa comprensione per trasformare in un paradiso di virtù un mondo che come tutti gli altri mondi è soggetto a gelosie, invidie, banalità e futili ragionamenti. Gli imbrogli, i plagi e le contraffazioni proliferano nel mondo dell'arte come in qualsiasi altra disciplina della vita, e tanto più ne impregnano l'universo musicale, anche se per chiamare arte un certo tipo di musica bisogna essere degli inguaribili ottimisti.
La mattina del contratto non riuscii a restare davanti a quella commedia, ai ragazzi che accettavano tutto, alla faccia rassegnata di Maurizio, al mobilio di quell'ufficio, distaccato, formale, da “Generali”. Uscii con la speranza di scovare un po’ di contatto, di fisicità, e riuscii a trovarle in spiaggia, davanti alle onde calme, placide.
Il mare di Genova non è come gli altri mari, è diverso, pare abbia tempi che non esistono in nessun altro posto. A Genova il mare parla. Racconta di amori finiti male, di amicizie perdute, dei bei tempi lontani, andati ormai. E poi riesce a trasmetterti una dolcezza misteriosa, che forse è il lato segreto di questa città.
Venire a Genova è un po’ come leggere un libro; i personaggi sono discreti, lasciano vivere e soffrire, non ti rubano le tue sconfitte. Le strade non sono altro che nuovi capitoli ansiosi d'essere scoperti, non si lasciano capire alla prima occhiata. Genova esige attenzione, impegno, per essere capita. Genova è una storia d'amore, non un giallo. Non vi sono colpi di scena, a Genova. La sua bellezza è tutta nell'animo, nel carattere, in un viaggio introspettivo eterno e affascinante, nei fremiti, nelle contrizioni con cui l'autore, Dio, l'ha ri-vestita. Una città che sembra passare del tutto, e invece poi ritorna. Una città che ci cambia, che ci coccola, che ci nutre, che ci fa cre-scere, che ci custodisce intatti e ci modella, che ci fa sembrare più belli e intelligenti, brutti e ignoranti, che da noi impara e che a noi insegna. Genova è un archivio del mondo, è la visione della vita nella sua interezza tramite il recupero del Passato, che a Genova non si esaurisce. I suoi personaggi vivono in simbiosi con lei, e nonostante restino sempre gli stessi, uguali, Genova li maneggia, li mescola, li fonde, li separa nuovamente, li traveste, li diversifica, li racconta cattivi e poi buoni, nobili e puerili, stupendi e ancora orrendi. Li stravolge presentandoli in diversi ruoli, e attraverso le sue strade li fa piangere e poi ridere, litigare e contraddire, amare e odiare, morire e rivivere essendo ricordati.
Siamo noi quei personaggi. Noi che non ci conosciamo seppur fratelli, noi che non ci frequentiamo seppur compagni, noi, abitanti di questa città e prigionieri di uno stesso Destino.
Genova è un mistero difficile da scoprire, è un segreto che non si può svelare. Non ha “Stele di Rosetta”, Genova. O la odi o la ami, o la conquisti o ne sei conquistato. Puoi viverla senza scoprirla, ma non puoi scoprirla senza viverla. Genova non è megalomane, non è vanitosa, non è esibizionista. E' gelosa di sé stessa, non fa mai parlare di sé. Genova “imbarca”, non si fa “imbarcare”. E' un burbero professore, questa città. Un professore smanioso di farsi amare dai suoi alunni. Genova è un antico romanzo, scritto una volta per tutte da chi si era allontanato dal mondo. Un’opera proustiana fatta di scatole cinesi, un'enorme madeleine inzuppata nel Mediterraneo il cui gesto nasconde moltissime cose e nessuna.
Genova è Swann ma anche Guermantes, è la bellezza filiale di Gilberte e quella ambigua di Albertine. Ha le pareti foderate di sughero per proteggersi dai clamori esterni ed è disposta a litigare col mondo, ma solo per poterci fare poi la pace. Ogni tanto si perde, Genova, ma dopo un po’ si ritrova.
Genova è mia madre che mi consola delle ingiustizie subìte.
In quella spiaggia mi son ritrovato a rimpiangere i tempi beati dell'ingenua adolescenza, quando tutto era vero, magico, e bastava la colonna sonora di una particolare canzone che ti piaceva per farti sentire il centro del mondo. Ti scoprivi, allora, coi lucciconi agli occhi, cullato da quella musica che dava briciole di paradiso che nessun altro, fosse stato misero o potente, capace o inetto, poteva darti.
Ricordai come avevo considerato un tempo sincopato che unito ad una particolare armonizzazione mi aveva portato ad impazzire di gioia. I Genesis di Peter Gabriel e Steve Hackett. Era quella, l'unica arte che conoscevo. Come consideravo arte il saper scrivere testi che uniti alla musica facessero sognare il cambiamento, la fratellanza, il martirio per i propri ideali, l'amore e non la guerra. Ivano Fossati e Fabrizio De Andrè (che mi piaceva paragonare a Caproni, mio poeta preferito), cantori ineguagliabili della mia Genova, non semplici musicanti, ma artisti della Letteratura contemporanea.
Quell'oggi mi chiedevo dove tutto questo fosse andato a finire. Era possibile che non fosse mai esistito? No, mi dicevo. Quello che avevo sentito nel profondo del cuore, i brividi che il tal pezzo mi aveva provocato, le assurde e inspiegabili nostalgie, non potevano essere scomparsi. Ero consapevole che quei turbamenti di spirito, quelle contrizioni del mio animo, non fossero qualcosa di sprecato, da qualche parte dovevano trovarsi, magari persi nelle irrequietezze comuni, in quelle utopie di adolescente, che non erano morte, tutt'altro. O sul fondale profondo delle mie lacrime, in un'ideologia lontana, ma non persa per sempre. Ne ero certo, quei sentimenti non aspettavano altro che di essere ritrovati. Ero sicuro di non aver sprecato niente di me stesso, del mio amore per la musica, tuttavia ero stanco e disilluso.
Quando subiamo una delusione cocente siamo portati a reagire in due modi diversi, opposti; o ci abbandoniamo e sentiamo di dover desiderare la morte, o, in quella che crediamo una reazione, ci vien su dal di dentro una specie di voglia di rivalsa, di vendetta contro chi, consideriamo, ci ha tradito. Io, che non sono mai stato un lottatore, mi sentivo trascinato verso l'abbandono. Non avevo voglia di reagire e non sapevo neppure contro chi farlo. Non ho mai ambito ad avere così tanti nemici come quella mattina, in quella spiaggia. Tornando a casa li ricercai accuratamente, sguscianti negli autobus schifosi, fermi al semaforo maledetti, nelle disgrazie planetarie di cui le prime pagine dei giornali grondavano, o nelle scontatissime elezioni politiche che con la loro dominante prevaricazione avevano violentato la città ricoprendone di manifesti i muri. Volevo prendermela con qualcuno per rinvigorirmi e trovare quella forza che mi avrebbe consentito la reazione. E invece niente. Per il mon-do pareva non esistessi.
Chissà per quale oscura ragione più che l'amore è l'odio ad aver bisogno delle facce, altrimenti la forza per battere il nemico ci mancherebbe, e ogni sforzo sarebbe vano, e ogni battaglia irrimediabilmente persa.
Se ci capita di essere vittime di un furto, il fastidio che proviamo può essere alleviato soltanto conoscendo, sapendo e vedendo da vicino la faccia di colui che lo ha commesso. Tuttavia i gesti anonimi ci fanno soffrire solo se si rendono colpevoli di torti, mai di amicizie. Se una lettera anonima ci parla d'amore ci lusinga, e la notte dormiamo. Ma se ci minaccia di morte ha la capacità di toglierci il sonno! Eppure l'anonimato dovrebbe essere in ogni caso una vigliaccata. Chi ci ama privandoci della possibilità di vedere il suo viso non è consigliabile come marito per nostra figlia o come socio in affari, perché il male che quell'anonimo c'infligge è quello di esporci a possibili delusioni. Forse era per tali ragioni che i popoli antichi si costruivano degli idoli e delle immagini da adorare. L'odio ha bisogno di nemici visibili esattamente come l'Amore necessita, come punto di riferimento e di appagamento, dei tocchi e quindi della conoscenza.
Allora capii che non c'era rimedio. Fu così che per un paio di giorni caddi nell'abbandono. Ebbi giusto la forza di alzarmi dalla sabbia e far ritorno a casa.
Incredibilmente fu proprio Marta a spronarmi e farmi riprendere. Le telefonai e le chiesi se poteva venire da me. Rispose di sì. Dopodiché accesi lo stereo e infilai Mendelsshon, la sessanta-quattro. Il secondo movimento m'inumidì gli occhi restituendomi un volto umano e consolandomi dell'ingiustizia subita. Dopo una mezzora Marta arrivò. Le raccontai tutto, e lei parve dispiacersi per me. Mi confortò come una mamma conforta il suo bambino che giocando in piazzetta ha perso il pallone, o, ancor peggio, gli è stato bucato dai morsi di un cane. Quella notte facemmo l'amore. Lo facemmo come una delle prime volte, quando l'ansia di scoprirsi era tanta.
Lei sembrava contenta di questo suo nuovo ruolo, quello della missionaria, della crocerossina. Piano piano mi curò le ferite, mi alleggerì di quel dolore al cuore che hanno certi deboli soldati al fronte, quando si vedono circondati dalla morte e si mettono a piangere. Mi regalò parole che nutrirono il mio vocabolario dell'anima, e baci che, come unguenti miracolosi, alleviarono il mio dolore e la mia delusione. Le sue carezze richiusero per qualche giorno il luogo del cuore dove i rancori, come serpi velenose, si vanno a nascondere per entrare in letargo e tornare ad uscire per colpire qualche tempo dopo. Il mio amore per lei fece il resto, e un paio di giorni dopo ero rinfrancato e pronto a ricominciare.
Oggi mi chiedo spesso perché è così strano che si riesca a tirar fuori della dolcezza anche dalle pietre. Non è da poco tempo che mi sono accorto di come qualsiasi persona, per quanto indurita possa essere, sia comunque in grado di tirar fuori della dolcezza quando ce n'è bisogno. Che sia per sé stessa o per gli altri.
Marta, che era quanto di meno sentimentale avessi mai conosciuto, quella sera si rivelò un contenitore di umanità e dolcezza, tanto che mi fece sorgere il dubbio che fosse malata. Aveva sbalzi di umore e di comportamento da far credere che soffrisse di qualche complesso strano. Passava dalla parvenza di un egoismo più sfrenato ad una umanità eloquente e compassionevole, da Madre Teresa di Calcutta, nel giro di poche decine di minuti. L'unica cosa che dal suo viso raramente spariva era l'eterna vanità.
Quando due giorni dopo uscii di casa per mischiarmi al mondo, avevo riguadagnato me stesso. Come prima nulla poteva più scalfirmi. Avevo solo acquistato dell'esperienza in più da mettere nella cascina della disillusione, qualcosa che mi fece prendere coscienza di quanto ancora non fossi completamente deluso dal mondo e dai suoi abitanti, da amici e sconosciuti, ma anche da me stesso.
Ognuno di noi vuole convincersi che il mondo sia meno carogna di quello che è. Si chiama “fiducia verso il prossimo”.
Spesso avevo paura di questo sentore, dell'ottimismo e della fiducia negli altri che ogni tanto mi prendeva. Così mi ero imposto di credere all'idea secondo la quale l'umanità esista soltanto in funzione propria. Mi piaceva pensarla in questo modo, e spesso mi spiavo per sorprendermi a fidarmi degli altri. C’è da dire che in questa veste da guardone di me stesso non godevo più di tanto, perché che mi cogliessi in fallo accadeva davvero di rado, e non perché la mia fiducia negli altri era eccessivamente scarsa, ma perché anch'io, volente o nolente, faccio parte di quest'umanità, e chiedere al proprio cervello di non fidarsi di sé stesso è quantomeno grottesco. Potevo chiedergli di non fidarsi del mio corpo (sua creatura perché sua somatizzazione, che come ogni dispensatore di percezioni cerebrali accumula in sé molti bisogni di fisiche reciprocità), ma non di sé stesso.
La sicurezza che avevo in passato, quella d'indovinare a prima vista il tipo di persona che avevo davanti, se n'era andata altrove la-sciandomi solo e sperduto. Era bastato entrare più profondamente in quel mondo, fare conoscenze, per convincermi di non avere sempre ragione quando puntavo il dito verso una persona e dicevo:
“Quello è fatto così”.
Ci vuole davvero poco per farsi persuadere non solo dal proprio cervello, ma anche da persone e situazioni. Non parlo tanto del Ga-gliardi, anzi, lì ci avevo preso, ma dei miei compagni. Uno passa la vita in casa di persone comuni per accorgersi, neanche dopo tanto tempo, di aver a che fare con dei serial killers.
Gagliardi ci aveva convinto che potevamo sfondare, ma non con la nostra musica, bensì con la sua. E noi ci eravamo arresi. Ripen-sandoci adesso fu davvero facile per lui guadagnarci alla sua causa. Ma la colpa fu anche nostra.
L'umanità è convinta di andare avanti perché l'individuo conserva e nutre l'ambizione del “sistemarsi”. Siamo proclivi a pensare che i nostri desideri siano la ragione primaria per protrarre la nostra esi-stenza, la forza irresistibile della speranza di appagarli. Non è mai così. Quello che ci succede, spesso e volentieri, è determinato da una concatenazione più o meno casuale di cose piccole, che quasi mai chiedono il permesso per entrare nella vita degli individui. Sovente siamo noi ad adattare i nostri desideri alle condizioni che la vita ci mette davanti e che il caso ci procura, e soltanto raramente abbiamo voce in capitolo. Solo verso i sessantanni capiamo che la Vita è una malattia che si trasmette per via sessuale, e che la Morte è il successo di quella cura che c'impongono le ferree regole della società.
Naturalmente è pericolosissimo frustrare la convinzione che siamo proprio noi, di volta in volta, a scegliere, altrimenti si rischierebbe di cadere nell'irresponsabilità generale, e molto di quel poco che siamo riusciti a costruire andrebbe perso. Ma ciò che ci fa chiedere se siamo davvero noi, anche nel pensare, o nell'agire istintivamente, o nella troppa emotività, a dirigere appieno la nostra vita, sono quelle situazioni che ci creiamo per un gesto ingenuo, per la voglia di farci coinvolgere, per l'avventatezza che mettiamo nel desiderare la felicità.
Alcuni sofisti usano il termine “epicureo” per sottolineare il comportamento ingenuo di certi individui in certe situazioni. Ma, dopo essere passati attraverso quelle disgrazie che non ci siamo cercati volutamente, spesso sono proprio quelle nostre quasi involontarie azioni a farci raggiungere consapevolezze determinanti.
Comunque i miei amici del gruppo non furono gli unici a farmi ricredere sull'infallibilità dei miei giudizi. Anche Marta, per quanto poco si somigliassero, mi fece ripensare a certe mie avventatezze applicando a persone conosciute da poco stupidi luoghi comuni.
Avevo sempre creduto che lei fosse una specie di malata convenzionale. Soffriva di vanità acuta, e anche se questa è una malattia che affligge molti individui, io non mi facevo consolare “dal mal comune mezzo gaudio”. Soltanto sporadicamente Marta si lasciava andare a compromettenti verità di appartenenza alla normalità, ma anche qui vedevo che quando lo faceva era come se perdesse qualcosa, dei pezzi che poi non riusciva più a trovare. Un po' come quando si viene messi di fronte al contraddittorio ed essendosi inequivocabilmente compromessi con precedenti affermazioni o precedenti comportamenti, si finisce per sentirsi incastrati.
Marta, che capiva di non avere vie di scampo e di doversi in un certo senso castrare, metteva su un muso che poi manteneva per giorni interi.
Questo suo comportamento mi lasciava basito, e sovente mi domandavo se non avessi a che fare con una bambina di dodicianni o giù di lì. Anche perché la corazza che metteva per respingere i miei approcci di pace si faceva sempre più dura d'abbattere. Marta, ecco, si stava indurendo. Verso tanti, verso tutti, ma soprattutto verso di me.
In quei giorni non avevo ancora abbandonato del tutto l'idea di lasciare il gruppo e la musica. La tentazione era forte. Mi dicevo che l'omologazione non è una colpa grave, che molti vivono omologati ed hanno l'aria di non preoccuparsene affatto. La vita del musicista un po' mi aveva stufato. Era troppo irregolare, e non c'è nulla di originale o di particolarmente emozionante nel tornare a casa tutti i giorni alle cinque del mattino con la consapevolezza di non aver risolto nulla, a parte l'aver intascato le misere centomila lire, e nel disco non ci credevo più di tanto, mi era diventata indifferente la sua sorte, anche perché non lo sentivo più mio.
Quando ci pensavo mi dicevo:
- Se questa è da considerarsi arte...........................
Tutto era cambiato nei miei parametri d'approccio.
Verso la musica, verso i miei amici, verso Gagliardi, verso il locale e ancora più verso Marta. Non avevo ancora capito a cosa si do-vesse il suo improvviso mutamento, ma presto la situazione, e lei stessa, me lo avrebbero rivelato.
IV.
Subito dopo la delusione dell'incontro col Gagliardi mi sentivo giù di morale. Avevo ripreso a suonare con gli altri, sia nel locale che in sala prove, ma non avevo la stessa convinzione di prima. Loro passavano il tempo come al solito, a farsi mistificare compiaciuti e, tanto più adesso che avevano “inciso” un disco, a spacciarsi quali artisti. Io continuavo a non vedere nulla d'interessante in quella vita, ma il gruppo non sembrava essere d'accordo con me.
Perfino Maurizio cominciava a godere di quelle mistificazioni, e un giorno arrivò al punto di dirmi:
- Sai, ogni tanto si possono incontrare persone veramente interessanti perfino in questo locale. Conosci qualcuno da anni, continui a vederlo tutti i giorni, finché uno di questi lo conosci un po' più in profondità e capisci quanto può essere interessante.
Anche lui stava cadendo vittima delle lusinghe.
- Interessanti? - risposi io - Certo, come guardare un frizer che si sbrina. Mauri, noi non abbiamo alcun dovere nei confronti di nes-suno. Non si deve cercare di trovare interessanti le persone con le quali passiamo il nostro tempo, ma dovremmo cercare di passare il nostro tempo con persone che sono interessanti, e se permetti c'è una bella differenza! Non siamo obbligati ad ingoiare individui che non ci sono mai piaciuti solo perché questi continuano a venire nel locale per sentirci suonare.
- E cos'è? - disse lui dopo avermi attentamente ascoltato - Un sillogismo da Settimana Enigmistica?
No, era molto peggio. Avevo deciso di riconsiderare tutti i miei rapporti. Amicizia, amore, affari............………….
Non volevo lasciare più nulla al caso, e soprattutto non volevo la-sciare al caso il mio rapporto con Marta. Perché ci eravamo messi insieme? Ricordai che non mi era particolarmente piaciuta la prima volta che la vidi. Avevo subìto tutto fin dal primo momento? Mi sembrava di sì. Subìto come si subisce la pubblicità alla Tv. E lei, mi amava veramente? Non so quanto questo fosse importante per me. Avevo raggiunto un livello di disillusione tale, anche nel rapporto con Marta, che mi sembrava di essere entrato in quell'età in cui non si bada più di tanto alla reciprocità.
Quando pensavo a Marta come alla mia donna, mi chiedevo quanto lo avessi voluto. Intendo dire, quanto “ho voluto essere il suo uomo”. Fra i nostri due primi incontri, la prima volta al Ristorante e la seconda nel locale, non ricordavo neppure che esistesse. Non l'avevo cercata se non dopo aver constatato che non le dispiacevo.
Rivista alla distanza la nostra relazione somigliava a uno di quegli amori dell'Italia d'inizio novecento, quando una donna e un uomo si mettevano insieme e si sposavano solo perché i loro padri si erano messi d'accordo dieci, venti anni prima. Ecco, pareva che il nostro rapporto fosse stato concordato da qualcuno in chissà quale luogo e in chissà quale tempo. E io mi ero arreso.
Ma in quel rapporto ero davvero io? E l'amore che volevo a Marta era autentico? Le volevo davvero bene?
Oggi, talvolta, mi colgo a pensare che forse tutto nacque per la smania d'innamorarmi. Quando ero meno disilluso ambivo a conquistare il cuore della donna di cui mi ero innamorato, ma crescendo mi son trovato sempre più spesso ad innamorarmi di una qualsiasi donna che sapevo innamorata di me. Non so se era perché non dovevo faticare per conquistarla o per prolungare l'appagamento di quella vanità (sapersi interessanti per qualcuno) in maniera fisica, ma mi rendevo conto di essere un vinto, in amore, un vinto conclamato e terminale. Anche nella relazione con Marta mancavo di quel desiderio, di quell'ardore iniziale che ci porta a corteggiare anziché ad essere corteggiati.
In amore ogni tanto capita di scoprirci meno moderni di quel che avevamo sempre creduto. Io non mi vergognavo di essere corteggiato dalle donne, ma sapevo anche d'essere uomo e di dover tenere fede ad una parte che il copione delle tradizioni orali e letterarie mi avevano assegnato tramite una convenzione sussurrata.
Non so se in questo si possa parlare a pieno titolo di maschilismo, non credo, tuttavia sono anche conscio che un uomo che non prende l'iniziativa con una donna possa talvolta essere considerato un “mollaccione”. Non capisco perché tutto ciò avvenga ma è così.
Forse anche questo è retaggio. Ricordo che mio padre diceva sempre: “Se hai una lite con una donna e questa ti dice che sei un maschilista, è perché hai ragione”.
Io, che da sempre avevo ritenuto i corporativismi soltanto una tana nella quale si nascondono i vigliacchi, mi ero lasciato trasportare dagli eventi fino ad essere compiutamente complice del mio asservimento verso le donne.
Marta aveva voluto che andassi al suo tavolo. Aveva cominciato a parlarmi prendendosi quella confidenza che nessuno le aveva dato. Aveva bevuto con me e con me si era lasciata andare. Probabilmente fu ancora lei a manovrare perché avessimo un rapporto sessuale. Io non avevo saputo far di meglio che subire la sua aggressività di “donna emancipata del Terzo Millennio”, il suo fare sbarazzino, le sue uscite compromettenti. Quanto c'entravo io in questo squinternato amore?
Quando la rivedo in quel ristorante, con la sua bizzarra camminata, col suo sentirsi offesa, con la sua sicurezza da bella donna, col suo fare mellifluo e fastidiosamente compiacente, allora mi convinco che forse non era per me ma per qualcun altro. Ma se così fosse, quanto meritiamo di tutto quel che ci accade se in realtà ogni cosa è già stata predisposta da qualcuno che quasi mai siamo noi? E perché non chiedersi ancora quanto c'entriamo nel determinare le situazioni, la natura, la nostra stessa vita? E le mie scelte, porco Giuda!, dov'erano andate a finire? Era solo una questione di progresso, di modernismo, di libertà?
Non credo che fosse così semplice. Le domande erano più serie. “D'amor si muore”, altro che emancipazione e “risveglio delle coscienze”!
Quando Marta mi disse di essere incinta, di aspettare un figlio da me, la mia infelicità non svanì subito, si acquattò come si acquattano certi felini pronti a saltare addosso alla loro preda. Ora che avevo deciso di riconsiderare tutto il mio amore per lei, il nostro rapporto, Marta mi metteva al corrente di ciò che era la nostra storia d'amore. Mi sembrava un ricatto, una minaccia. La minaccia di chi si sente sotto giudizio e, con la miccia accesa della bomba che tiene in mano, urla: “Muoia Sansone con tutti i Filistei!”
Avevo la possibilità di mantenere un figlio? Fino a quel momento sicuramente no. Ma questo fatto non mi spaventava più di tanto, mi spaventava di più dover stare con lei perché adesso c'era un figlio. Naturalmente per me il figlio c'era. Non avevo nessuna intenzione di rinunciare a quella creatura.
Lei buttò lì quell'affermazione con la pesantezza dei suoi occhi profondi, di quello sguardo che non perdeva occasione per promettere rimproveri. Nel farmi quell'annuncio la sua voce tremava, pareva aver trovato la strada del palato bloccata, e la frase esplicativa uscì dalla sua bocca come un singhiozzo. Io rimasi inebetito per qualche secondo, smarrito e confuso come in un sogno, e non seppi rispondere altro che “Allora?”. Marta parve non voler sentire altro. Voltò le spalle e iniziò a salire i gradini del portone di casa sua. Lentamente. Pareva volermi lasciare il tempo per decidere qualcosa. Io, che non ebbi la forza né le parole per fermarla, la lasciai andare via come quel viaggiante, assiduo consumatore d'autobus di linea, che sentendosi senza ombra di dubbio alcuna in anticipo all'appunta-mento, lascia passare il suo numero senza salirci sopra.
“Le persone si uniscono per autobus che non si prendono alla stessa ora”, mi dico, citando Cèline a me stesso, ogni volta che, guardando mia moglie, le immagini offuscate di quella storia mi tornano alla mente.
Soltanto una volta a casa riuscii a capire a cosa stavo per andare incontro. Allora ritrovai la felicità che un padre dovrebbe avere quando la sua donna gli dice di essere incinta di lui. La paternità è un mutamento non solo dello Stato di Famiglia ma anche, e forse più, della propria natura d'uomo.
Ero smanioso, ansioso di dire a Marta ciò che provavo. Le telefonai alle undici di sera, urlandole tutta la mia felicità. Lei si mise a ridere e senza dire una parola riattaccò il telefono. Era proprio vero, la mia donna aspettava un figlio da me.
Cominciai a pensare che avrei dovuto trovarmi un lavoro serio, ma era cosa da nulla. Avrei continuato a suonare per hobby, per divertimento. C'era da mantenere un figlio adesso, le priorità erano cambiate. “Addio sogni di gloria musicali”, mi dissi senza per altro rammari-carmene troppo.
LA PRIMA VOLTA CHE VIDI MARTA
I.
Una cosa ricordo con chiarezza, che sempre più spesso rimanevo interdetto dallo strano andamento della mia vita. Passavo continuamente dalla delusione più cocente alla felicità piena e senza freni che mi faceva rivalutare ogni volta le cose che mi accadevano. Il fatto che Marta aspettasse un figlio da me mi aveva costretto a riconsiderare tutta la vita vissuta fino a quel momento ed a convincermi d'aver perso troppo tempo. Tuttavia i rancori erano passati, perfino verso il Gagliardi.
Che comica la vita. Sei ad un passo dal dichiarare guerra al tuo nemico, e improvvisamente tutto cambia. E allora i tuoi rancori, le tue rabbie e le tue delusioni, si diluiscono a tal punto nella nuova situazione e nella necessità di dovercisi adattare, che se ti capita d'incontrare il Diavolo in persona non è raro confonderlo col Postino.
Quando gli altri mi chiesero cos'avessi intenzione di fare, se volevo restare o andarmene, io mi presi un paio di settimane per decidere, durante le quali avrei comunque continuato a suonare con loro.
Ormai suonavamo soprattutto in sala prove, nel locale non ci vedevano che una volta al mese. Gli assegni di Lopresti ci stavano man-tenendo in vita, e non avevamo più bisogno di andare in quel posto a suonare. Quando lo facevamo era solo per appagare fisiche vanità, non certo per intascare soldini che ormai non avevano più alcun senso. Il disco era uscito e, cosi diceva Gagliardi, stava andando abbastanza bene. Ero combattuto se trovarmi un lavoro secolare o provare ancora col gruppo.
Gagliardi e Lopresti avevano fatto un grosso sforzo finanziario investendo parecchi soldi per il nostro lancio, ma erano sicuri che saremmo riusciti a sfondare e che loro sarebbero rientrati nelle spese. Dicevano che la critica era favorevole e che, per questo motivo, le speranze di piazzarlo bene erano ottime.
La critica, sia quella musicale che quella letteraria, mi ha sempre fatto sorridere. Chi ha il ruolo di recensire un libro o un disco deve sentirsi una sorta di Giudice Supremo, e difficilmente sarà obiettivo. Perché leggendo un libro egli vede la possibilità di migliorarsi migliorandolo, e ogni volta cade nella tentazione di correggerlo, di mutilare frasi o di aggiungerne di nuove, finendo per cambiare l'opera o addirittura per scriverne un'altra, perdendo il filo condut-tore di ciò che sta leggendo e non poter fare altro che recensirlo negativamente. Del resto anche “La strada di Swann”, il primo volume de “Alla ricerca del tempo perduto” di Proust, fu stroncato, tanto ch'egli lo pubblicò a sue spese. Ma oggi sappiamo che non v'è libro che valga venti righe di quell'opera.
Ricordo che quando sapevo che il Gagliardi doveva venire a darci delle direttive e dei consigli, mi prendeva il mal di stomaco. Le sue idee in fatto di look mi spaventavano. Non volevo farmi snaturare da lui. Era una cosa che non avevo mai permesso a nessuno, né ai miei genitori, né ai miei insegnanti, né alle mie ragazze, perché mai avrei dovuto permetterlo ad uno stronzo qualunque?
Gagliardi venne e ci disse, secondo lui, com'era meglio “conciarsi”. Il majestatis sovente è un escamotage per imporre il proprio volere. Voleva che cambiassimo modo di vestire e il taglio dei capelli, che ci presentassimo come i “ragazzi della porta accanto”. Alcuni di noi, a dir la verità, lo erano già. Io mi dicevo che se il nostro aspetto fisico fino a quel momento non aveva minimamente influito su tutti quelli che venivano a sentirci e che si presentavano diversa-mente da come ci voleva Gagliardi, perché mai avrebbe dovuto iniziare a farlo ora?
Ritengo che non esiste nulla di meno importante delle questioni d'abbigliamento. Per quanto bene un individuo possa presentarsi, alla fine sarà sempre quello che dice, ciò che pensa e quello che fa ad interessare le persone che gli stanno intorno. A me non importava vendermi anche sotto questo punto di vista, ma Gagliardi diceva che era necessario, e gli altri parevano volergli dare ragione.
Non appena cominciammo a provare il nostro nuovo look io mi feci ritornare la voglia d'andarmene. Ma durò giusto un paio di giorni, perché subito iniziammo a prenderlo come un gioco. Quando qualcuno di noi arrivava in sala con qualcosa di diverso, che fosse nell'abbigliamento, nella camminata o nel taglio dei capelli, i giudizi, e insieme gli sfottò, si sprecavano. Quando Gagliardi ci vide la prima volta conciati in quel modo (alcuni di noi sembravano degli spaventa passeri, altri dei tossicomani all'ultimo stadio, altri ancora dei pagliacci), inorridì. Disse che ci dovevamo conciare sì come “i ragazzi della porta accanto”, ma nel senso d'inquilini e non di chi è entrato per rubare.
Capimmo subito che ci voleva addobbati in giacca e cravatta.
Io, da quelle affermazioni, mi sentii sollevato. Anche se non ero completamente d’accordo con lui, ero però sicuro di non piacermi. Non ero d'accordo con lui per due ragioni essenziali; ho conosciuto disgraziati, barboni, tossici e poveracci che per quanto malconci potevano essere conservavano un interesse di cui ritengo siano privi certi manichini di stilisti. Secondo; Gagliardi continuava a non piacermi.
Quello che ci aveva fatto infagottando di archi e violini il nostro lavoro, ogni tanto tornava a tormentarmi le viscere facendomi stare male. Ero certo d'esser stato derubato da lui. Il perché lo capii col tempo. Gagliardi voleva farci diventare una sua creazione, voleva toglierci la nostra personalità, la nostra genuinità, in modo che, una volta portato a termine il suo disegno artistico-criminoso, noi non potessimo più fare a meno di lui. Non lo sopportavo. Sebbene aves-se fatto tanto per noi, o così fingeva che fosse, mi rendevo conto che molto aveva lavorato per sé stesso, per la sua gloria.
Ciò che più mi faceva innervosire era che da lui gli altri accettavano tutto. Molto plausibilmente non erano sicuri del loro talento, ed aver trovato una persona che li esentasse proprio dal tipo di lavoro che non erano capaci di fare, cioè vendersi, li rincuorava. Per fortuna, col successo, avemmo presto la possibilità di scendere a patti con lui e liberarci così dal suo tirannico dominio.
Non appena Marta seppe che il nostro discografico ci voleva vestiti da manichini, ne fu contenta. Mi aveva conosciuto con quelli che amava definire “cenci”, ma che erano i vestiti che portano tutti i giovani della terra, e sapermi più elegante non la infastidiva affatto, anzi.
- Sarà la volta buona che qualcuno ti rende presentabile. – diceva.
Il suo modo di vestire, anche se molto elegante, era abbastanza spezzettato. Lei amava abbinare vestiti e comportamento alla gente che si doveva vedere la sera. Se uscivamo coi suoi o coi miei genitori, vestiva semplicemente, con abiti interi o gonne lunghe e camicette o maglioncini, e faceva la ragazza seria, che non dà confidenza al primo che capita. Se veniva al locale si copriva di jeans dalla testa ai piedi, e faceva “l'attraente compassata”. Se andavamo a mangiare fuori coi nostri amici si comportava da amicona, da simpatica e cara compagna (anche se non disdegnava lanciare occhiate, lasciando, in quel modo e ai miei amici, le porte aperte a qualsiasi soluzione e possibilità) pronta a fare qualsiasi cosa per aiutare i propri “amici”, e si combinava elegantemente, in abito da sera, costringendomi alla cravatta, cosa che odio, e al travestimento. Non la odio per una forma di falso anticonformismo, ma perché mi fa sentire legato, impacciato nei movimenti, e come se avessi un burbero maestro dietro sempre pronto a riprendermi dandomi delle bacchettate sulle dita. La costrizione dell'essere compiti mi ha sempre mandato “fuori giri”.
Spesso, in camera sua, guardandola mentre si vestiva, le dicevo che non c'era motivo di conciarsi in quella maniera, che vedevamo la solita gente che già ci conosceva per tipi scombinati, ma lei non voleva sentir ragioni.
- Cosa li ho comprati a fare questi, - diceva indicando nel suo armadio quanto di più elegante possedesse - se non me li fai mai usare? Per farli mangiare dalle tarme e appestarli con la naftalina?
- Fa’ un po’ come vuoi. - rispondevo io stanco di far la guerra con lei - Tieni presente che non c'è nulla di meno elegante di chi si veste elegantemente soltanto una volta al mese, per le grandi occasioni. I nostri amici ci conoscono come divoratori di jeans e magliette, e vestirsi diversamente quando li vediamo fuori dalla vita di tutti i giorni mi sembra quantomeno da provinciali.
Alla fine si vestiva a metà strada fra l'elegante e il non curante. Io, che in realtà ero meno trasandato di quello che lei tentava di farmi credere, uscivo in jeans camicia e giubbotto.
Naturalmente lei metteva su il broncio. Non era uno di quelli che sfoderava per questioni importanti, quando avevamo dibattuto su problemi reali, e quindi non durava molto, ma mi faceva innervosire perché ogni volta mi sorgeva il dubbio di stare insieme ad una cretina, ciò che secondo me lei non era.
Purtroppo quello che siamo meno propensi a pensare quando ci mettiamo con una donna, è la possibilità ch'ella possa anche non essere quel che crediamo di vedere noi. Quando la conobbi nulla mi attendevo da lei che non fosse ponderato e intelligente. Ma piano piano quell'illusione svanì, riconsegnadomi, come quella lavanderia poco seria a cui abbiamo dato da lavare i nostri abiti, qualcosa di rovinato, di stropicciato, i cui motivi di quelle “grinze” poco riuscivo a capire.
Ma forse è naturale. Come tutti gli individui del mondo anche lei era soggetta a cambiamenti piuttosto radicali. Le cose che avevo notato come pregi, un certo intelligente snobismo, la sua non curanza nel trattare argomenti frivoli ma che la pubblica opinione ritiene essere importanti, l'arguzia di alcuni dei suoi ragionamenti, la certezza di dover trattare gli individui sempre per la loro personalità e non avendo come parametro i suoi principìi che su certi argomenti non era ragionevole applicare, la logica che usava nel trattare con la gente, finirono presto per scadere nel più bieco dei compromessi, nell'opportunismo imperante e nell'egoismo sfrenato.
Allora non riuscivo a capire come persone che sembrano intelligenti finiscano miseramente per far prevalere il loro piccolo quotidiano anche su questioni cruciali, in quegli istanti in cui bisogne-rebbe sfoderare la propria combattività, la voglia di non arrendersi, la smania di lottare. Certo, è difficile tenersi alla larga da una certa frivolezza, da quella tentazione che ci prende di lasciarci andare, anche per far gli stupidi, non importa, e considerare alcuni momenti di scarsa rilevanza, poco importanti, e per questo farsi trasportare dal proprio istinto e finire per fare gli scemi in mezzo ai saggi e viceversa, ma a un limite dovrebbe esistere per ogni cosa!
Se alcune delle sue movenze non mi si fossero presentate come gesti consueti e non come lo stato d'animo appena descritto, sicuramente non sarei giunto a certe giuste conclusioni (così si rivela-rono negli anni), ed avrei continuato a sopportare quella ragazza per chissà quanto tempo ancora, senza prendere in considerazione il fatto che potevo anche essermi sbagliato, che lei non fosse affatto la donna della mia vita, che quella scarpina, in realtà, mi stesse stretta.
E' in questo che la mia umiltà venne in mio soccorso.
Quell'umiltà di fondo che avevo conservato e nutrito, e che mi permetteva di accettare il contraddittorio senza soffrirne troppo. Era giunta l'ora di ammettere a me stesso di essermi sbagliato, di dover ricominciare tutto da capo.
Il raggiungimento di questa consapevolezza arrivò poco prima del boom del nostro disco. Marta, sempre ansiosa di apparire interessante, non si accorgeva del fatto che l'avevo scoperta, che mi ero accorto di come celava la sua vanità, della voglia che aveva dentro di farsi notare, di non passare inosservata. Ciò ch'io non capii, e di cui ancora oggi mi rammarico, è dove quella vanità l'avrebbe portata.
Dal giorno alla notte arrivò a prendere la decisione di rinunciare a nostro figlio, a decidere di abortire. Senza consultarmi, senza guerreggiare o contrattare il prezzo di quell'azione, in modo premeditato e autonomamente, decise di non portare a termine la gravidanza. Il fatto ch'io fossi il padre di quella creatura sembrava non importarle. Come molte donne nella sua situazione, si convinse abbastanza facilmente che le questioni di parto e gestazione fossero un suo inviolabile primato, e le dessero la piena autorità di decidere da sé cosa farne di nostro figlio.
Tutto l'amore che mi aveva portato e che le avevo voluto per me finiva lì. Il giorno stesso in cui decise di abortire. Quello che m'irritava era che io non servivo più a niente. Non ero parte in causa, non avevo alcun ruolo in questo giochetto macabro, non avevo diritto d'espressione, né potere decisionale né autodeterminazione. Niente di niente. Contava solo lei e il suo volere.
II.
Ed eccomi qua, coi miei quarantanni andati a male, di nuovo con gli occhi gonfi di lacrime e la faccia rossa per lo sforzo nel ricordare quei momenti.
La memoria ci riporta i ricordi non come un film o una commedia in due atti consecutivi, ma piuttosto come un libro che si sia iniziato a leggere aprendolo a caso, o, meglio ancora, come numeri estratti ad occhi bendati da un bussolotto. Oggi fatico tantissimo a richiamare alla memoria lo stato d'animo d'allora, forse perché il dolore, quando ci penso, è ancora troppo presente e troppo bruciante, ma alcuni istanti di quella storia mi appaiono come confuse vi-sioni, come deboli nuvolette che svaniscono al primo misero soffio di vento.
Ciò che da adulti ci guasta è l'impossibilità di evocare le cose minime, che poi sono gran parte della nostra vita. E' per questa ragione che gli anni finiscono per avariarsi, perché non riuscendo a ricordare che i momenti belli, numericamente assai scarsi, ci sembra di aver passato la maggior parte del tempo a non fare nulla, anonimamente.
Quando Marta mi disse di voler abortire rimasi ferito mortalmente, come e peggio che se mi avessero dato una coltellata. Quello che non capivo era il perché. Perché voleva abortire? Non c'erano ragioni visibili. Quello che io pensavo di lei non poteva essere una ragione valida perché lei ancora non lo sapeva.
Forse ero stato io a farmi trasportare dalla foga nel voler avere fiducia nel mondo, e la mia capitolazione a quel suo pseudo corteggiamento diventò, in breve tempo, lo spunto per raggiungere nuovi desideri. In quell'oggi e in quella situazione vidi con chiarezza che il mio tentativo di coinvolgerla nel nostro rapporto era miseramente fallito. La condizione dell'innamorato, il suo voler a tutti i costi essere ricambiato, dà origine a panorami d'illusione che non si riescono a cancellare se non creando, allo stesso modo, colpe altrui. Forse Marta, ecco una felice intuizione, era solo la materializzazione del mio fallimento come innamorato, come amante, e quindi come uomo.
Ma io non potevo diventare come lei, avrei dovuto cambiare realtà, la mia realtà, per dar vita ad una persona di questo tempo, a cui piacciono gli strani ordini di cose che questo tempo tremendo ha fatto propri. Avrei dovuto diventare un consapevole vanitoso, un megalomane che tutto fa per essere guardato, come se traesse dalla vista degli occhi altrui la forza per andare avanti. Avrei dovuto di-ventare “un Marta”, o comunque molto simile a lei. Ma io sono sempre stato uno “scopofobico”! Come avrei potuto, anche volendolo, diventare come lei? E se la colpa invece era solo mia? Se in realtà non ero altro che un asociale che non si era adattato al modo di vivere del suo tempo? O se forse ero uno dei pochi uomini giusti che sono sulla terra solo perché hanno sbagliato contemporaneità? Solo perché la loro presenza è un pochino anacronistica?
Tutti questi interrogativi me li posi con la speranza di trovare una valida scusa che mi avrebbe permesso, se non di perdonare, almeno di capire il comportamento di Marta, ma faticavo ad essere comprensivo. Dentro di me, piano piano, cominciò a farsi strada l'idea secondo cui lei volesse uccidere nostro figlio per vanità. Non volevo crederci, ma la sua mancanza di deluci-dazioni mi faceva pensare che una ragione vera e propria in realtà non ci fosse.
A giorni la cercai fra i risvolti di quelle scuse che lei mi propinava come ragione valida che le avrebbe lasciato mano libera per agire; non eravamo sposati, non potevamo mantenerlo, non sapeva fino a che punto ci amavamo, non si sentiva pronta per la maternità, avrebbe senz'altro perso la sua libertà, ma fra tutti questi motivi non ne trovavo uno plausibile e scusabile per compiere quell’omicidio cinico e consapevole.
Le rispondevo che tutte quelle scuse erano problemi nostri, che il bambino non c'entrava niente, che era come se uccidessimo il nostro vicino di casa solo perché abbiamo perso il posto di lavoro, o come se invadessimo la Polonia per vivere più larghi e sentirci più liberi, ma lei non si faceva persuadere. Sovente le dicevo:
- Se non lo vuoi lascialo a me!
Un giorno le scappò di dire che non avrebbe sopportato il pancione ad Agosto, quando tutte le altre ragazze vanno al mare e si mettono in costume a prendere il sole. Forse soltanto allora capii davvero di che pasta era fatta Marta.
Non ci potevo credere. Non ci volevo credere.
Era possibile che fino a quel momento avevo considerato la mia donna, la futura madre dei miei figli, una che era disposta ad ucci-dere il suo bambino pur di mantenere la linea? Ora non avevo alcun dubbio. La prima volta che vidi Marta non mi ero affatto sbagliato. Era talmente vanitosa da far crescere dentro sé stessa quel cinismo utile che le avrebbe consentito di abortire per una cosa così banale come “tenersi in forma”, non perdere la linea.
Era solo una questione di tempi? Di modernità? Di ciò che passa al-la Tv? “Certe donne”, pensavo, “ucciderebbero davvero pur di essere guardate dagli uomini quando camminano per strada”. In che razza di società stavo vivendo? “Se questo è il rapporto”, mi dicevo, “chissà cosa sarebbe disposta a fare pur di salvarsi la vita!”
Durante la mia esistenza sovente mi era capitato di passare attraverso un turbillon di cazzate, dette e fatte, ma che comunque non mi permettevano di scusare, o addirittura trovare normale, una cosa come questa. Che irresponsabile! Che pavida!
Era dunque questa la verità? Marta voleva solo fuggire alle sue responsabilità? Era solo una vigliacca?
Commentare la paura di un individuo di cui si legge sul giornale il suo essere pavido, è come ad un esame scolastico copiare il compito del proprio compagno di banco; quando consegniamo il plagio godiamo del voto senza capirne i motivi; colui che ne capisce i motivi non si rende conto di aver votato un plagio.
Io criticavo la paura e la viltà di Marta senza saperne i motivi; lei, che probabilmente sapeva le ragioni di quel gesto, non capiva perché aveva paura.
Entrambi eravamo vittime incoscienti di una recita a soggetto, di un canovaccio convenzionale. Entrambi avevamo copiato precisi comportamenti di due opposte corporazioni, e mentre lei godeva del risultato di quella sua convenzionalità, del suo plagio, capendone i motivi, io, che i motivi non li capivo, vedevo quel risultato estremamente sproporzionato alla causa; l'autodeter-minazione della donna. E' giusto giudicare “vile” un suicida o è solo un luogo comune? Forse è vero ciò che diceva Kierkegaard, “solo chi muore sa se lo ha fatto per viltà”. Il quel caso, però, la fuga non era un suicidio, ma un duplice omicidio; il mio e quello del bambino.
Ritengo l'aborto un assassinio legalizzato quando è consumato per ragioni valide, e che può essere scusato solo con le motivazioni di una “legittima difesa”, figuratevi quando è fatto per futilità, frivolezze o vanità!
Tutto avrei potuto scusare a Marta, forse perfino il tradimento amoroso, ma non che lei uccidesse nostro figlio per appagare i pruritini del cuore, perché col pancione gli uomini non l'avrebbero più guardata né corteggiata. Mi faceva rabbia pensare che se anche avessi avuto la possibilità di portare queste prove in Tribunale, quella specie d'impiegati comunali avrebbero dato ragione a lei. Non si può obbligare una donna a partorire.
Pensai spesso a chi doveva essere stato. Sì, chi era quel “genio” che aveva dato vita ad una Legge del genere? Mortificando il valore della vita con questa cultura della morte, ogni individuo può con-siderare qualsiasi nefandezza in cui ha qualcosa da guadagnarci come naturale e giustificabile. Non è strano che il mondo sia pieno di pedofili, pedofobi, corrotti, corruttori, ladri, assassini e guerrafondai.
Pensai anche, sorridendo amaramente, al moderno ruolo degli uomini. Anima in pace ragazzi! In queste questioni siamo ormai dei comprimari, delle spalle, dei poveri guitti senza teatro né piazze, senza arte né parte, senza applausi né stipendio. Serviamo solo ad appagare le vanità femminili, a fare regali, a corteggiare e a mantenere quelle donne che, meno fortunate di altre, hanno considerato questa “emancipazione” come qualcosa di poco conveniente.
Mi sentivo perso.
L'amore è un dolore che il rapporto con la persona amata prolunga, e che ogni tanto viene anestetizzato da estasi gioiose, che sono le uniche a rinvigorire il ricordo d'esso non appena tutto finisce. Ebbene, io non avevo, come purtroppo mai avrò nel ricordo di Marta, nemmeno queste.
Marta, che in quei giorni saltava per un nonnulla, sembrava aver deciso definitivamente. Come le altre volte, quando litigavamo per motivi futili, aveva messo su il broncio. Questa volta non m'interessava farla sciogliere da sola, questa volta non m'interessava se mai si fosse sciolta, stava per diventare un'assassina, questo doveva esserle chiaro, e io, che non sono certo un prete, non l'avrei mai perdonata.
Quelli del gruppo mi vedevano giù di morale, ma non mi chiesero mai nulla. Soltanto Maurizio un giorno venne da me e, con l'aria ostentatamente corrucciata, mi disse:
- Gianni, se hai qualche problema io sono qui. Di giorno e di notte.
Lo ringraziai, ma per il momento decisi di non dirgli niente della mia situazione. Non volevo mettere in cattiva luce Marta. Se ci penso mi viene una rabbia.….…….……...... Io non volevo metterla in cattiva luce, e lei, per ricambiare, uccideva mio figlio.
Ogni tanto ripenso ai tempi in cui muovevamo i primi passi nel mercato discografico, e ogni volta mi metto a ridere da solo. Si capiva ad occhi chiusi che non eravamo pronti. Dell'arte avevamo soltanto una vaga idea, un’idea piuttosto “romantica”, direi. In realtà le cose non sarebbero andate come speravamo.
Non avremmo potuto fare ciò che volevamo, almeno, non all'inizio. Eravamo più manovali, operai, che artisti. Nessuno ci concedeva nulla, neppure facendo musica. Tutto questo quando conoscemmo Gagliardi non lo sapevamo ancora, e fu per noi la delusione più cocente.
Credo che in Italia ci sia la categoria più pavida del mondo, gli imprenditori, e, fra questi, la più vigliacca in assoluto, quella degli editori. Altrimenti non si spiegherebbero tutte le “vaccate” di dischi e di libri che vengono messi in circolazione solo perché incisi e scritti da chi ha già un nome.
Quando il Mercoledì preposto arrivò, eravamo visibilmente eccitati. Era il nostro primo approccio con un mondo lungamente desiderato, e chissà per quale sorta di motivo eravamo tacitamente convinti che fosse necessario presentarsi con un certo snobismo. Il motivo di tale comportamento era piuttosto chiaro; non volevamo cadere in mani sbagliate che, notando la nostra smania di voler entrare in quel mondo, avrebbero potuto approfittare di noi sfruttandoci. E' vero, per quanto riguardava muoversi in quell'ambiente eravamo degli sprovveduti. Così, come caute serpi, cercammo di non ostentare altro che indifferenza.
Soprattutto nei riguardi di quell'arrangiatore.
Gagliardi era la classica persona convinta di conoscere appieno l'animo umano. Durante quelle prove arrivò addirittura a dirci quale musica secondo lui era adatta alle nostre facce. Sicuro, mi rendo perfettamente conto che non si può mettere Charles Manson su un palco a monologare sulla “sfera della morale”, o il Marchese De Sade a strimpellare la chitarra cantando di castità, ma era comunque troppo!
Chissà per quale oscura ragione certi adulti sono certi che qualsiasi cosa essi dicano debba essere presa sul serio da coloro che ritengono essere alle prime armi. Intendiamoci, non voglio rinfacciare gli anni a nessuno, ma ho sempre creduto che sono le cose che si sono vissute a fare degli individui dei plausibili esperti, e non la loro età. E' anche vero che chi ha tanti anni (ma in realtà ne bastano solo pochi più degli altri) in genere ha avuto più possibilità di vivere esperienze, ma questo non è né sempre giusto né sempre degno di nota.
Conosco dei veri e propri Filosofi che vivono per strada facendo i barboni. Quando li incontro rimango sempre affascinato da quello che dicono, perché dimostrano di avere un'esperienza e una cultura che sono fuori dalla portata di certe “educande agiate”. Ma non appena me ne vado lasciandoli lì a divorare la loro precarietà, la prima domanda che mi viene in mente è; dal momento che sono così colti, perché mai vivono per strada? E la risposta che mi do somiglia più ad una scusa. Del resto ci sono persone convinte che la strada insegni a vivere, e persone che la strada ha rovinato. Di solito sono le stesse.
Appena entrò, dopo qualche chiacchiera, ci disponemmo e ini-ziammo a suonare. Suonammo pezzi di genere diverso. “Her town too” di James Taylor, “Evil Prince” di Frank Zappa, alcuni pezzi di Gabriel e Sting per finire con “Ruby, My dear” di Monk, in una versione rivista per pianoforte e chitarra che avevamo tirato su io e Maurizio. Gagliardi ci guardava celando un falso ottimismo. Poi disse:
- Bisogna lavorare di più sulla vostra personalità, su quello che potrebbe essere il vostro genere, il vostro stile. Il basso è troppo presente rispetto alla batteria. Mancano le tastiere, comple-tamente. Maurizio, dov'eri? Se ti nascondi dietro la chitarra allora è inutile essere in cinque. E tu, - disse rivolto a me - fai un giro e parte la svisa, ne fai un altro e riparte la svisa. Non va mica bene sai? Troppo lineare, scontata. Dovreste dare al pubblico qualcosa di meno immaginabile, perché, diciamoci la verità, uno che conosce soltanto Eminem o Jennifer Lopez dopo il primo giro sa già dove andrete a parare!
Quel discorso era deliziosa musica per le mie orecchie. Non desideravo di meglio che suonare pezzi un po' meno scontati e che avessero dato la possibilità al gruppo di sciorinare la tecnica e la fantasia.
Gagliardi aveva ragione, dovevamo cambiare.
Così, appena uscì dalla sala, ci mettemmo attorno ad un tavolo e cominciammo a discutere sul da farsi. Maurizio aveva tirato su un paio di bossanova con la tastiera e, tornati agli strumenti, provammo ad andargli dietro. Non mi dispiacevano affatto.
Provammo per due-tre mesi di fila, tutti i giorni. Anche gli altri, piano piano, si stavano appassionando a fare dell'altro. Lasciammo Gabriel e Sting alle loro elucubrazioni umanitarie, buttammo i Queen nel cestino della carta, e cambiammo completamente il modo di concepire certe cose. Non saremmo più scaduti nei facili sentimentalismi, per quanto ci sarebbe costato non avremmo più accontentato il nostro pubblico, quello del locale, che mettendo qualche moneta sul bancone voleva sentirci cantare monotonie datate che ci avevano stufato. Avremmo dovuto limitare le nostre apparizioni in quel locale al Venerdì o al Sabato, un giorno, non di più, giusto per mantenerci la sala prove. Il comporre ci avrebbe assorbito completamente. Se volevamo fare musica non solo per divertirci dovevamo impegnarci e ragionare ad un altro livello.
Gagliardi si fece vedere spesso, dandoci consigli e accorgimenti che ci sarebbero serviti in futuro. Non era malaccio, ma aveva sempre la presunzione di saperne più di noi. Anche se forse era vero, il suo managerismo sfiorava l'ossessione. Certo, eravamo solo dei ragazzi che andavano seguiti costantemente, ma non poteva imporci i vestiti, le auto, i nostri gusti musicali, e addirittura le ragazze e gli amici! Di tanto in tanto mi veniva la tentazione di mandarlo a quel paese.
Con Marta, quando ci vedevamo (sempre poco), cercavamo di andare d'accordo. Io ero più che mai innamorato di lei, e il dolore che la sua lontananza mi procurava lo sfruttavo per comporre, fare musica e scrivere testi. Mai capito perché quelli del gruppo incaricarono me della responsabilità di scrivere i testi per le nostre canzoni. Così, siccome Alessandro era il cantante, passavo assai più tempo con lui che con Marta.
Io scrivevo, e poi, quando portavo il risultato di notti insonni, con Alessandro provavamo la metrica. Era un lavoro che mi piaceva e mi dava soddisfazione. I testi avevano sempre qualcosa che andava rivisto, corretto. Sovente mi sorprendevo, orgoglioso, fiero di me stesso, ad autocompiacermi per ciò che avevo scritto. Alessandro mi riempiva di complimenti e, forse per questa ragione, sopportai meglio la sua vanità, il suo essere prolisso, i suoi atteggiamenti da “prima donna” e la noia che si portava sempre dietro e che era alquanto smanioso di scaricare sugli altri. Parlava già con l’importanza di un artista, sillabando le parole, facendo frequenti pause e usando termini che non aveva usato mai.
Marta non mi sembrava più la stessa. Voglio dire che, sentendosi trascurata, aveva perso quella vena polemica che aveva persuaso il mio istinto a digerirla quando la conobbi. Era diventata inappetente, sembrava stanca, lontana, ancor più disillusa. Forse quel “non essere al centro dell'attenzione” la faceva soffrire più di quanto io stesso mi accorgessi. Ma c'era anche dell'altro. Lei non sembrava convinta del lavoro che facevamo. Diceva che le ricordavamo quando era piccola e con alcune sue amichette volevano mettere su un'orchestrina.
Quando parlava in quel modo credevo che in fondo dicesse quelle cose per invidia, per gelosia. Marta, infatti, come più tardi ebbi modo di rendermi completamente conto, era una di quelle ragazze che vogliono l'attenzione su sé stesse ma senza darlo troppo a vedere.
Sempre pronta ad affermare che nulla la interessasse di meno della considerazione che gli altri potevano avere di lei, si notava ad occhi chiusi che bluffava spudoratamente. Come molte ragazze che sono convenzionalmente belle, in verità non ambiva che essere l'argomento preferito dei ragazzi. Quando non la si considerava tendeva a chiudersi e a mostrare quel tipo di vanità furba che tenta di mettere addosso agli individui la frenesia di sapere a cosa stesse pensando. Doveva sentirsi unica, sicuro. Unica come me, come tutti.
Se glielo avessi chiesto, presumibilmente, sarebbe salita volentieri sul palco a cantare, anche se aveva la voce da cornacchia. Lei non cantava, gracchiava.
Quando, dopo aver finito di fare l'amore, la sentivo cantare sotto la doccia, spesso pensavo che ci fosse qualche perdita nella conduttura idraulica. Ogni volta, non appena aveva finito di lavarsi e usciva dal bagno, le chiedevo se aveva tirato lo sciacquone.
- Perché? Non ho mica evacuato! - rispondeva sgomenta.
- Come no! - insistevo io - Hai cantato per mezzora!
Lei, allora, un po’ se la prendeva, anche se io cercavo di dimostrarle subito che stavo scherzando.
Per carità! L'ultima cosa che volevo era aprire un contenzioso con lei su come si canta o su chi ha la voce più bella in Italia e all'estero. Credeva di capirsene. In realtà andava dietro al flusso migratorio dei quotidiani specializzati, anche loro servi sciocchi che agognano abbassare il capo davanti ai loro padroni (che sovente nemmeno gli chiedono di farlo), e che tentano di spacciare ridicoli strimpellatori per veri e propri artisti.
Impazzisco dalle risate quando guardo quelle Tv specializzate in Musica che vendono “pentatoniche” per alta tecnica musicale. Scale che un bambino di otto anni riesce ad eseguire dopo averle osservate due volte. La comica è che scusano ogni cosa con “le emozioni”, tanto che le contrizioni ch'esse causano negli animi degli ascoltatori diventano immediatamente bravura.
Anche un bambino si emoziona leggendo fumetti, ma non per que-sto si può dire che Topolino abbia lo stesso spessore culturale di “Delitto e Castigo”!
Sono convinto che oggi sia più che mai necessario fare precise differenze, altrimenti tutto è Arte, e se tutto è Arte niente è Arte. Dovremmo riconsiderare il significato del termine “artista”.
La Tv, per un buon novanta per cento un catalizzatore d'inutilità, ricettacolo d'idioti, ha influenzato gran parte della società convincendoci che ogni cosa è una questione di gusti. Il modello televisivo è diventato un parametro buono per tutte le stagioni e per ogni continente. Per esempio.
Molti dicono che non ci sono più bravi scrittori, ma poi senti che il loro massimo di libro è un giallo che scopiazza il cinema o i telefilm televisivi. Se non si scrivono più romanzi non è tanto perché non ci sono più scrittori in grado di farli, ma quanto perché non ci sono più lettori in grado di leggerli.
In realtà se si legge poco la colpa è proprio degli editori e dei critici letterari, perché un libro bello fa venir voglia di leggere, mentre uno brutto la fa passare. Le recensioni dei libri editi sono sempre belle, e così vai in libreria ad acquistare e puntualmente ti ritrovi fra le mani un “pacco”. Oggi l’unica ragione per entrare in una libreria e recarsi al banco delle “nuove uscite”, sono Aldo Busi, Ian McEwan, e forse la Petrignani. La Letteratura corre dietro alla Tv senza averne i tempi, e il risultato è molto più basso delle reali possibilità, perché l’immagine inibisce la fantasia.
Questo discorso tanto più vale per la musica.
Oggi credo che Marta non sapesse mentire, almeno, non perfettamente. Mi diceva di non essersela presa, ma per tutto il giorno cercava di evitare i miei baci e le mie carezze, mettendo su un “muso da prima elementare”. Quando io le ripetevo che avevo scherzato, lei, sorridente, mi assicurava di non essersi sentita “toccata”. In verità lo era stata. A quel punto non sapevo più che fare e subivo le sue ripicche senza colpo ferire, come un santo consumato o un futuro martire.
Non mi piacevano queste situazioni, e l'unica arma che avevo per difendermi dal mondo, innanzi tutto da Marta, il “mio” mondo, era quella di buttarmi sulla musica. Questo avvenne sempre più fre-quentemente, tanto che se oggi posso dire di essere diventato un discreto chitarrista, lo devo probabilmente anche a quella situazione.
Talvolta ero tentato di dirle quanto poco le si addicesse quel broncio, ma non lo feci mai. Lei avrebbe sicuramente negato di avere un broncio. L'unica cosa che riuscivo a fare era quella di guardarla mentre suonavo, quando veniva a sentirci, o quella di pensare a lei fra un accordo e l'altro quando, con una scusa volutamente stupida, restava a casa o si costringeva a fare dell'altro e ad andare in un posto qualsiasi solo per non venire con me.
Era il suo modo di farmela pagare.
Dopo quelle poco edificanti scenette, entravo in una sorta di Limbo, speranzoso che lei mi perdonasse quella sua stupidità. Comprendevo che le mie colpe erano in realtà le sue, ma, come un cagnolino affettuoso che scodinzola dopo esser stato preso a calci dal suo padrone, la mia priorità era che tutto si appianasse alla svelta.
Non riuscivo a capire dove voleva arrivare, ma l'amore che le portavo mi precludeva qualsiasi reazione, e allora non mi restava che subire. Certo, vi direte, quando è troppo è troppo! Ma la sofferenza che provavo, e che lei pareva agognare propinarmi, spesso mi serviva per cercare stupide e inutili scuse alla mia incolpevole esistenza.
Meritavo quella vita? E chi lo sa! Forse sì. Ma non come molti credono. Il Destino non c'entrava un fico secco. La mia voglia di soffrire era assiduamente ricercata da me come certi piazzisti cer-cano nuovi clienti. L'ho sempre saputo. Chi ci chiamava “artisti” non sapeva realmente chi si trovava di fronte.
Quando con Marta si litigava ero sempre io a cercare pretesti cre-tini per fare la pace. Lei, allora, come se facesse solidarietà a paesi del terzo mondo, mi guardava con la testa reclinata e l'espressione compassionevole, contenta di elargire un po' di carità, come quelle nazioni ricche che regalano milioni di scarpe da tennis al Bangladesh. Si sa, esistono individui che hanno ricevuto così poco dalla vita, e sono talmente abituati a prendere calci in bocca, che se per una volta beccano solo uno schiaffo credono sia un atto di stima. Io, in quel tempo, ero uno di questi. Quando lei mi perdonava una sua mancanza, un suo capriccio, ero felice come un bimbo di quattro anni nel lettone di mamma e papà.
Ci sarebbe voluto davvero poco per fermarmi un momento e capire che ero schiavo di lei, del mio amore per lei, che mi stavo vendendo, e neanche troppo bene, ad una donna che non era sicura di volermi comprare e continuava a tirare sul prezzo, ma, probabilmente perché avevo questa certezza, ciò che evitavo di fare era proprio far affiorare nel mio cervello tale consapevolezza.
Cristo come l’amavo! Oggi mi è difficile ritrovarlo, quell’amore, e assai frequentemente mi chiedo quali sono le ragioni che spingono ad amare. Non è stravagante, nel mondo affollato che ci circonda, avere nella testa un’unica persona? Non avere presente che quell’individuo? Nel cuore un solo desiderio? Nella bocca un solo sapore? Nelle mani irrimediabilmente quel tatto, quel corpo? E le corde vocali! Che leggero era il suo nome a pronunciarlo! Certo, stavo vivendo per le sue braccia, qualche volte sinceramente strette alla mia vita, per i suoi baci, eredità che mi spronava a ricordarla quando ero lontano da lei, per le sue carezze, per i suoi occhi, sguardo che illudeva come i suoi gesti, per le sue vesti, per le sue parole, rapito, catturato una volta per tutte dal suo alito di vita e dalla sua esistenza. Un amore compiuto, così compiuto da non saper ricono-scere alba e tramonto, bianco e nero, vita e morte, terra e cielo, acqua e fuoco. Un’indelebile illusione che mi strappava la vita in ogni momento, in ogni situazione, in ogni nome.
Considerando, fu per questa situazione con Marta che mi buttai a capofitto sulla musica. Ero terrorizzato dall'idea che la nostra storia sarebbe potuta cambiare, e speravo, tenendomi lontano da lei quando sentivo che era in vena di far ripicche, di continuare a mantenere quello status quo. Lo so, non era una grassa consolazione, ma quella storia mi serviva come punto di riferimento per sapere dove andare quando avevo finito di far “l'Artista”. E poi perché, naturalmente, ero innamorato di lei. Così m'illudevo di riuscire ad amalgamare le uniche due cose che la vita mi aveva dato; il mio amore per Marta e il mio amore per la musica.
III.
Gagliardi ci aveva promesso un disco nel giro di tre o quattro mesi. Questo significava impegnarsi per comporre e per migliorare i pezzi che avevamo già. Qualche rara volta ero convinto che la cosa si potesse fare, ma quasi mai era così. Non potevamo basarci su quello che non avevamo; la sicurezza.
Qualcuno di noi, Alessandro ed Enzo in testa, era convinto di poter riuscire a sfondare. Io e Maurizio eravamo abbastanza increduli, e vivevamo alla giornata.
C'impegnavamo, ma ci sembrava sempre poco. Eravamo pieni di dubbi, soprattutto sulla nostra musica. Come dovevamo presentarci al pubblico? Non lo capivamo, non lo sapevamo. Così tirammo su due gruppi di pezzi, uno più tecnico e l'altro più commerciale, di facile ascolto.
Quando li risentivo mi veniva il mal di stomaco. “Siamo rimasti delle bagasce da poco prezzo”, mi dicevo. Pensare a noi come ad “artisti” mi sembrava un'iperbole. O meglio, una catacresi. Il nostro gruppo accostato alla musica e all'arte. Una locuzione inserita in un contesto non adatto a lei, un vocabolo pronunciato fuori luogo, non nella sua comune accezione. Ogni volta mi veniva l'atroce dubbio che con la musica avessi poco da spartire. La nostra Vanità stava alla musica come la Letteratura alla Tv, e parlare di libri in televisione è come riempire d'acqua una scatola di cartone.
Ero pienamente assorbito dal lavoro che dovevo fare. Il giorno lo dedicavo alla sala, a suonare con gli altri provando i nuovi pezzi, e la notte a scrivere i testi per quelle canzoni. Gli altri erano ben felici che fossi io a scriverli. Non perché li scrivessi eccessivamente bene, ma per l'onere che mi ero assunto. Avevo buttato giù della roba che non mi sembrava cattiva, anche se ero scettico sulla sua funzionalità. Una canzone parlava di ecologia (che tristezza!), e un'altra della situazione famigliare di Alessandro. I suoi genitori aveva-no divorziato. Ne scrissi una che sbandierava la mia disillusione su tutto. Gli altri erano contenti di quella roba, tranne Maurizio, che mi disse:
- Sono cose deliranti. Ma dove le hai prese?
Io feci una smorfia e tirai avanti. Dedicai un pezzo anche a Marta. Lo intitolai “Una donna”, e in pratica raccontava di che cosa aspiravo in fatto di personalità femminile e di sentimenti. Chissà, forse avevo l'intenzione di dirle ciò per cui mi mancava il coraggio quando mi trovavo davanti la sua faccia.
“...…............considerando, non c'è molto da dire”.
Così intitolammo quello che doveva essere il nostro primo album. Era una frase che Giacomo aveva rubato ad un Vigile Urbano una mattina. Questo Vigile gli aveva fatto la contravvenzione perché lui, non avendo trovato parcheggio, aveva messo l'automobile in doppia fila. Mentre riempiva la contravvenzione, Giacomo gli parlava cercando di fargli cambiare idea. Imperterrito, l'Urbano, aveva continuato a compilare il foglio che attesta quanto ingiusto e pieno di automobili sia il mondo, e alla fine, viste le insistenze di Giacomo, con una sufficienza vanitosa, disse:
- Guardi la situazione. Considerando mi pare non ci sia molto da dire.
In quei giorni così convulsi mi sentivo attorcigliato. Era uno strano senso d'impotenza, mi sentivo contratto, ansioso, soprattutto la notte. Non stavo molto bene, ma facevo di tutto per non mollare.
Marta non mi aiutò per niente. Più probabilmente era lei che aveva bisogno d'essere aiutata. Da qualche tempo, come già detto, la vedevo diversa, lontana, distratta e fin troppo incoerente, proprio ciò che aveva sempre sostenuto di non essere.
In quella decina di mesi Marta era cambiata.
Ostentava solitudine e vittimismo. Era vero, aveva quasi perso quell’albagia di fondo che quando era in forma la rendeva antipatica, ma questa nuova ipocondriaca condizione da “fraticello del 1300”, per chi come me la conosceva bene, l'aveva trasformata in un personaggio ridicolmente retorico. Come quelle donnette dell'antichità che vedevano Gesù in ogni albero e in quasi tutti i temporali, pareva essere pervasa da quel misticismo che da fastidio a chi, come me, è realista. Era poco credibile.
A distanza di anni capii quel suo comportamento.
Quando la considerazione degli altri nei tuoi confronti comincia a scemare, sei portato a credere che il mondo voglia metterti da parte. E allora sei proprio tu, anticipando e mistificando più del necessario, a volerti sentire più solo di quello che effettivamente sei, proprio come faceva Marta quando, per colpa del mio lavoro, non potevo calcolarla più di tanto. Vorresti anticipare (probabilmente per mettere alla prova il tuo cuore e il tuo cervello) ciò che temi l'umanità voglia propinarti, e allora ti convinci, falsamente, che in verità sei ancora più solo di quello che ti sembra.
Si sa, sprecata l'emozione del primo impatto, consumato il pathos, tutto diventa possibile e più sopportabile. La stessa ragione che si è avuta per la messa in scena del “Lago della Duchessa”.
Non mi sono mai sentito così “umano” come quando, in quel periodo, dovevo sempre stare attento a porgere a Marta quel poco di solidarietà di cui ero capace. Ma nel far questo ero troppo goffo. Avevo terrore delle sue reazioni. Allungavo una mano con l'intenzione di carezzarle un braccio come un bambino allo zoo infila la mano nella gabbia delle scimmie per offrire una banana. Non ci voleva molto a capire che non ero affatto portato a fare l'umanista. Nemmeno nei suoi confronti.
Marta, quando non era troppo assorta nel contemplare la sua inappetenza, o creduta tale, da me ma anche dagli altri, diceva di amar-mi di un amore nuovo. Io sapevo che il suo era soltanto egoismo, ma volevo “accocolarmi” in quell'eufemistico amore che lei mi porgeva come un mendicante porge la mano ai passanti; anche quello era un chiedere, e io lo sapevo benissimo.
Fu allora che capii di quale sorta di vanità Marta era padrona. Lei, che ostentava anticonformismo, altro non era che una vanitosa della peggior specie, quella falsamente intellettuale, portata, quasi istintivamente, a sventolare una saccenza compassata che vuole costringere gli individui a darci per “colti” in modo scontato. Dava l'impressione, a chi poco la conosceva, di non darsi troppa preoccupazione per ciò che gli altri avessero pensato di lei, del suo modo di vestire, del suo scarno vocabolario, di come flirtava, di ciò che pensava, ma, se la si studiava bene, agognava con tutte le sue forze ammaliare. Ammaliare non visivamente, o non solo, ma anche implicitamente. Amava fare la misteriosa e insinuare nella testa della gente la curiosità di chiedersi come doveva essere fatta.
Una vanitosa per principio.
E' incredibile, ma avevo sperato, fino a quel momento, di essermi sbagliato quando, quella prima volta che la vidi, diedi di lei il giudizio di “furba vanitosa” che mi era parso di vedere. Non volevo ammetterlo (soprattutto a me stesso), ma c'erano svariate possibilità che ci avessi preso.
Così passavo il tempo a cercare di non pensare a ciò che il mio cervello, e le situazioni tutte, m'imponevano di credere, e cioè, di trovarmi davanti alla stessa persona di quella sera in quel ristorante, il giorno del mio compleanno.
Siamo convinti che quel che pensiamo, spesso facendo dietrologia, sia sempre esagerato rispetto alla realtà. Soprattutto noi italiani, abituati ai misteri delle stragi di Stato, siamo fatti così. Sovente però accade che la dietrologia con la quale c'impacciamo i movimenti fisici e mentali, rimanga indietro rispetto alla realtà vera.
Questo succede per le stragi di Stato, ma anche per le considerazioni, amorose o di altro genere, che facciamo sulle persone che conosciamo. Così, a distanza di anni, veniamo a scoprire che l'ap-partamento nel quale fu tenuto prigioniero l'onorevole Aldo Moro era di proprietà dei Servizi Segreti, e che, facendo la perizia sonora al filmato di Zapruder che riprende l'attentato a Kennedy, si sente che i colpi sparati non erano tre ma addirittura dodici.
E' sempre peggio di ciò che possiamo arrivare ad immaginare.
Allora speravo che Marta non fosse così, ma lei pareva far di tutto per smentirmi. Io, per non essere costretto ad ammettere d'averci proprio azzeccato, continuavo a sostituire i miei istanti, quelli in cui più spesso mi sembrava di aver ragione, con altri spensierati, giulivi, giocondi, che non lasciassero il tempo a pensate premeditazioni. Ma si sa, “stupido è chi lo stupido fa”, e io, in quei frangenti, mi sentivo proprio un emerito deficiente. Il guaio era che ero cosciente di farlo apposta.
Talvolta paragonavo la mia situazione con Marta ai “diritti umani” più volte sbandierati dalle Nazioni Unite quando gli americani sono in procinto di far la guerra a qualcuno.
Si parla sempre di “diritti fondamentali” senza riuscire né a spiegarli né a specificarli. Perché accade questo? I diritti che c'imponiamo cambiano secondo cultura, gusti e priorità, sia morali che fisiche. Gli occidentali sono convinti che il Mondo sia solo il posto dove vivono loro, e non riuscendo a reprimere il vizio d'indossare abiti coloniali, cadono frequentemente nella tentazione di omolo-gare gli altri popoli al loro stesso modo di vivere. Questo succede col supposto “Villaggio Globale”, ma anche coi “diritti” che vo-gliamo imporre a popoli che non hanno la nostra stessa cultura. E' così che finiamo per perderci. E' come cuocere una quaglia in un lago. Le differenze sono tali e di una così enorme quantità che chi si avventura in quel labirinto sovente fa la fine di Icaro.
Marta, sempre implicitamente, sbandierava la sua sofferenza, ma in concreto era solo un meschino tentativo di attirare l'attenzione sul suo misero quotidiano. L'incosciente, però, ero solo io. Mi costrin-gevo a quel rapporto in cui ero sempre io a dare e lei a prendere. Perché lo facevo?
Ero innamorato. Innamorato di quel genere di amore che tutto perdona, che tutto copre, che tutto spera, più adatto ad una congregazione cristiana del primo secolo che ad uno squinternato rapporto d'amore del ventunesimo.
C'era, comunque, la musica a tirarmi su. L'unica cosa che pensavo assiduamente in quel periodo era come fare per avere la sala prove tutti i giorni e ad un prezzo ragionevole, accessibile a cinque disoccupati quali noi eravamo. Accadeva che suonavamo di frequente anche fuori dalla sala, in spiaggia o a casa di qualcuno di noi, ma questo avveniva quando eravamo ottimisti e ci facevamo prendere dal delirio di poter riuscire ad agguantare la fama, perché di solito eravamo quanto di più noioso potesse trovarsi sulla piazza.
I pezzi dell'album erano quasi pronti, ne mancavano giusto un paio, che comunque avevamo già, erano solo d'aggiustare un pochino. Ci fissammo un limite massimo e decidemmo d'incidere tutto il materiale pronto su nastro. Quindi l'avremmo dato al Gagliardi.
L’emozione era palpabile, il nervosismo anche. Soltanto io non ero eccitato, gli altri erano ormai diventati dei contenitori, degli scatoloni, dei bidoni di ottimismo, perfino Maurizio. L'unico mio ottimismo si risolveva in tre parole:
- Staremo a vedere.
SINDROME D'AMORE
I.
Durante i mesi in cui eravamo presi dal registrare il nostro disco non mi accorsi che in Marta qualcosa stava cambiando. Il nostro rapporto era diventato come una di quelle macchine da lavoro obsolete; appena qualcosa si rompeva era impossibile metterla a posto. Non per mancanza d'individuazione dei nostri sbagli o per qualche sciocco egoismo, era molto peggio.
Ciascuno di noi due si chiudeva in un silenzio materiale che poi era difficilissimo frantumare. Questo silenzio nasceva e cresceva per la nostra assoluta mancanza di vigore nell'affrontare i possibili contrasti, e i problemi, che all'inizio potevano essere risolvibili, piano piano si esacerbavano. Sia io che Marta volevamo avere ragione senza dibattere minimamente le questioni. Dopo qualche giorno finiva che uno di noi (quasi sempre ero io) si arrendeva. Questo avveniva, naturalmente, senza ammettere niente, ma a Marta, quelle poche volte che si costringeva a darmi ragione, e a me non importava far chiarezza sugli eventuali incomprensioni, ma solo sentirci vincitori.
La sua vanità era più mitigata, adesso, e seguiva solitamente il suo umore. Quando era contenta, felice, mi riempiva di coccole, mi vezzeggiava, e ripeteva che mi amava. Il problema era che quella buona vena la faceva cadere nella tentazione di sfoggiarsi, di farsi ammirare. Quindi, proprio da poveretto, frequentemente mi sorprendevo a sperare nel suo broncio, nelle sue arrabbiature, perché quando era inquieta si dimenticava, forse, dell’esistenza degli altri uomini. Ecco, non era improbabile che la sua irrequietezza fosse l’unica condizione morale che aveva la potenza di cancellare, per qualche istante, la sua vanità, il suo esibizionismo.
Tutte queste situazioni io le vivevo con l’animo del condannato.
Avevo il terrore, una paura fottuta, delle sue reazioni. Tale fobia sconfinò presto in alcuni ridicoli, anche se perfettamente comprensibili, comportamenti.
Mi accorsi che la mia condizione d’onomatopeista stava peggiorando sempre più. Così presi il vizio di viver le giornate con gesti e situazioni palliative. A volte guardavo la vetrina di un negozio nel quale Marta frequentemente si fermava, e, illudendomi di riprendere da essa ciò ch’essa un dì catturò, verosimilmente l’immagine di lei, passavo alcune mezzorette a scrutarla come fa un basista preparando un colpo in una Banca.
Molto spesso mi accadeva di annusare i suoi vestiti, frutto, dopo aver fatto l’amore, di sue dimenticanze, o di cercare nei miei il suo profumo, come se quel contagio fosse anch’esso una dimenticanza che mi offriva l’occasione di annullare, fra noi, la momentanea distanza. Fissavo le altre ragazze tentando di scorgere in loro una qualche somiglianza d’espressioni facciali o di gesti cadenzati che permettessero alla mia memoria un più facile richiamo di lei, delle sue smorfie e del suo modo di voltare la testa altrove. Mi ritrovavo a pensare: “Ecco, i suoi capelli”, vedendo i capelli di un’altra, oppure: “Quella gonna ce l’ha anche lei”, sperando che colei che l’indossava fosse una sua cara amica, qualcosa e qualcuno che potesse riaccostarmi, sebbene soltanto nella fantasia, alla sua vita, e, tramite questo riavvicinamento, a vivere più intensamente la mia.
Parlavo con la sua inflessione, usavo vocaboli suoi, gesti che non mi appartenevano e pensieri che non molto tempo prima avrei ritenuto stupidi, ma che quell’oggi mi riempivano della sua presenza. Una sorta di “effetto placebo” che mi aiutava non solo a sopportare la sua lontananza, ma addirittura a goderne.
Prendevo la sua personalità per mano e la plasmavo, cosa che Marta non mi permetteva di fare. Ne ricucivo gli strappi, facevo carezzevoli orli, appuntavo ghirlande meravigliose di baci e abbracci profumati, abbacando, speranzoso, che l’abito appena imbastito un giorno potesse diventare reale, della mia taglia.
Cadevo sempre più spesso in questo meccanismo, perché il mio cuore lo viveva con tranquillità, tranquillità che al suo cospetto mi mancava. Com’è naturale, data l’assenza fisica, da parte sua non c’erano reazioni, in quelle mie fantasie, e di conseguenza il mio rapporto con lei era senza rischio alcuno. Soltanto lontano da Marta il mio amore viveva compiuto e senza timori.
Col gruppo si era tutti presi a voler registrare i nostri pezzi su nastro, e tutte le altre questioni passavano in secondo piano. Io ero sempre poco convinto delle nostre possibilità, gli altri invece credevano nel loro talento. Gagliardi era un maestro nel “montare” le persone. Non voglio dire che avesse sempre torto in ciò che faceva e diceva, ma la sua eccessiva sicurezza, che spesso sconfinava nella supponenza a tal punto che lui arrivava perfino a negarci delle spiegazioni, mi dava ai nervi.
Non molto tempo dopo l'inizio dei nostri rapporti capii di trovarmi di fronte ad un mistificatore senza scrupoli. Sicuro, non gli dissi niente perché, stando ai fatti, era anche l'unico che credeva in noi, nelle nostre possibilità, ma seguitava a non piacermi. Gli altri del gruppo invece erano affascinati dalla sua figura e, sempre smaniosi di mostrargli arrendevolezza e acquiescenza, facevano a gara per leccargli il culo. Io, che non sono mai stato uno portato ai facili guadagni o a mercanteggiare certi favoritismi, mi tenevo in disparte.
E' anche vero che Gagliardi non mi era piaciuto, e questo da subito.
Spesso mi chiedo perché appena abbiamo la possibilità di sapere qualcosa in più della persona che or ora abbiamo conosciuto, crediamo che è proprio in ciò che non sapevamo (e che, siamo convinti, lui volutamente ci nascondeva) il suo vero animo. A molti capita di considerare una persona, l'essere di una persona, soltanto per quanto di negativo ha fatto. Le cose positive non contano, crediamo sempre che siano casualità o, ancor peggio, d'essere in grado di poterle fare anche noi.
Di Gagliardi seppi che era un manipolatore d'individui, un aguzzino succhia sangue e un personaggio poco chiaro. A questo punto tutto ciò che di buono aveva fatto, scoperto gruppi e cantanti nuovi e di successo, promosso serate di vera solidarietà (!), aver portato alla celebrità, col suo managerismo, parecchi artisti, passava in secondo piano. Mi ero convinto d'aver davanti soltanto il manipolatore d'individui e l'aguzzino. Non so spiegarmi per quale motivo il bravo manager e l'ansioso umanista erano scomparsi.
Ma, andando avanti, anch'io mi stavo pian piano convincendo che tutto dipendeva davvero da noi. Mi ero forse fatto raggirare come gli altri? Mi accorsi che sempre più spesso mi perdevo ad immaginarmi famoso e ricercato. Mi stavo illudendo, come i miei compagni, che potevamo farcela, dicendomi che in fondo anche chi adesso era famoso prima di diventarlo era stato, come noi, un perfetto sconosciuto. Perché non poteva capitarci la stessa cosa? Per un breve periodo arrivai al punto di credermi un artista. Quell'esaltazione non durò molto tempo, è vero, ma anch'io l'avevo avuta. Come se avessi commesso un omicidio, speravo che nessuno si fos-se accorto di niente.
Chissà per quale tortuosa via siamo arrivati a definire “artisti” tutti coloro che si occupano di qualcosa d'affine all'Arte e non, come sarebbe ragionevole, chi Artista lo è davvero. Oggi non serve esser capaci di recitare per diventare attori, basta soltanto lavorare in un film. Così vediamo modelle e ninfette televisive che vengono assunte da produttori furbi e registi incapaci che hanno solo la malizia di sfruttare la loro popolarità, ma che davanti ad una cinepresa fanno venire il voltastomaco. Il guaio è che poi, dopo aver “girato” uno di quei films italiani di tradizione natalizia, vengono considerate davvero delle attrici. Come se non fosse già abbastanza esagerato parlare di quelle pellicole come se fossero films, uno quando lo fa è costretto anche ad innalzare quei cani che ci lavorano ad artisti veri.
Quando ripenso alle considerazioni che facevo allora, mi ritrovo a sorridere ingenuamente di me stesso, della mia strana e centellinata vanità, di quel futile compiacimento da cinquantenne che per la strada si accorge di essere guardato da una donna.
Un individuo che si autodefinisce “artista” non riconoscerebbe un artista vero nemmeno se gli cascasse sulla testa. L'artista che fa considerazioni sulla sua arte, su ciò che ha creato, è come un organo in mezzo ad altri organi in un medesimo corpo, i quali, non avendo alcuna percezione di sé stessi, non sanno dell'esistenza di altri organi né della loro in quanto organi. Un artista vero non ha percezione dei suoi lavori. Poverino, lui non lo sa di essere artista! In quanto appassionato ed esperto può giudicare e considerare solo i lavori altrui, le creazioni di altri artisti, ma mai la sua, tanto che quando butta giù la bozza di una opera, per correggerla e cercare di migliorarla, ha bisogno di allontanarsi da lei per qualche tempo, quello che serve per perdere confidenza con la sua creazione, in modo che confutandola abbia la distanza necessaria per sviluppare uno spirito critico e quindi migliorarla. Un disco, o un libro, sono come l’imbottigliamento di un vino; per dire se è buono bisogna lasciarlo invecchiare. Chi si autodefinisce “artista” non sa proprio che sia l'arte. La vicinanza appiattisce tutto, così che la nostra capacità di giudizio ne risente e noi perdiamo il giusto arbitrio che ci consentirebbe di fare una valutazione onesta, obiettiva, e quindi un’analisi esatta che ci aiuta a capire pecche e virtù, cosa tenere e cosa scartare.
Giudicarsi dal di dentro non è facile per nessuno, a prescindere che si sia artisti oppure no, e Alessandro, per esempio, che in quanto a musica sapeva distinguere un'armonizzazione jazz da una di altro genere, un quattro quarti da un sincopato, un andante da un allegro, spacciandosi per artista voleva sì convincere gli altri, ma soprattutto voleva persuadere sé stesso di esserlo davvero.
L'artista non è capace di giudicare la sua opera più di quanto un qualunque essere umano sia in grado di giudicar sé stesso in fatto di bellezza fisica. Gli altri del gruppo questo non lo capivano, infatti, tutti quanti, si credevano degli Adone.
Quello fu uno strano periodo. Mi spiavo e scoprivo di avere anch'io quella vanità furba che avevo scorto in Marta. Allora subito me la rimproveravo, e, soffocandola, mi sentivo a pieno titolo parte del mondo, di quel conformismo da cui avevo sempre cercato di stare alla larga. Così passavo le giornate ad autocompiacermi e a rimproverarmi. Soffocavo la mia vanità senza ucciderla del tutto. Quando vedevo che stava per morire allora allentavo la presa e mi facevo cullare per un attimo dal suo dolce tepore che, immediatamente, mi conquistava lasciandomi inerte e inebetito. Non appena mi riprendevo tornavo a soffocarla.
Il moderno universo musicale, con le sue vanità, coi suoi falsi approcci all'umanesimo, alle solidarietà fatte per forza e per denaro, all'arte che ammicca o a quella viscerale, pare, se visto da vicino, come una di quelle prostitute che dopo aver battuto i marciapiedi per anni, ora si sentono in fase calante e decidono di ritirarsi, di andare in pensione. Arrivano a propinarsi un illusorio ragionamento secondo cui “anche se non sono affatto male è arrivato il momento di smettere”. Si concedono, però, l'ultima strombazzata, for-se ad una festa di compleanno, o ad un pranzo di matrimonio, quando si tolgono lo sfizio di fare ciò che avevano sognato da sempre; l'amore in piedi col Capocuoco, magari in cucina, dove da un momento all'altro può entrare qualcuno.
Il mondo della musica accende e spegne fiaccole d'arte nel giro di pochi anni. Quando quello che è sempre stato considerato un artista si rende conto di non riuscire più a vendere dischi, o di non essere cercato da giornali e Tv, o di non avere più niente da dire e, di conseguenza, di non riuscire a creare più niente, allora si attacca alle code di qualche personaggio di cultura.
Che si comportavano in questa maniera, in quegli anni, ce n'erano parecchi. Generalmente si attaccavano alla coda del frac di Luciano Pavarotti, in quel tempo considerato l'uomo di cultura per eccellenza. Lui non se ne curava troppo. Portava i vari falliti in giro per il continente come alla mattina, poco prima di andare al lavoro, si porta il cane a pisciare.
Noi del gruppo chiamavamo questi “eventi” (com'erano considerati dal loro ameno pubblico, da sprovveduti giornalisti e da quelle Tv che avevano la necessità di spacciarli come tali agli agenti pubblicitari che volevano acquistare uno spazio dentro quelle “pagliacciate di spettacoli”) “Le Pavarottate”. Gli “artisti” che vi partecipavano e cantavano e suonavano con lui, erano coloro che facevano parte della “Corte dei Miracoli”. I loro concerti erano “sfilate per la fame nel mondo”. Quando vedevamo qualcuno comportarsi da ipocrita, celiando, dicevamo che era un candidato al prossimo premio “Pavarotti and friends”.
Te li vedevi, vanitosi, consci d’esser riusciti a portare a termine il percorso che avevano sognato fin da piccoli, rispondere con sufficienza a chi li intervistava, fare autografi senza neppure guardare in faccia i loro fans, e alla Tv salutare con poca importanza il pubblico a casa, certi di essere superiori decine di spanne a loro. E poi la solidarietà.
C'è una sottile e ipocrita voglia di crudeltà in coloro che spacciano “pubblicità a proprio favore” per solidarietà. Evidentemente ci hanno preso proprio per coglioni. Il falso altruismo che quegli “spettacoli” ributtanti emanano, è una sorta di territorio neutrale, un porto franco dove si “mollano” chewin gum e tonnellate di caffè da regalare ai poveracci scaricandosele sulle tasse e avendo un sicuro “ritorno pubblicitario”. Ed è pubblicità, questa, che non ha valore quantificabile, tanto vale e tanto costa.
Nel mondo ci sono artisti che hanno costruito la loro carriera facendo solidarietà. Pensiamo un po’ ad alcuni dischi contro la guerra o la fame nel mondo che vengono spacciati dai loro autori come “veicoli esenti da speculazioni e guadagni”. Che vergogna. Non c'è guadagno migliore per un artista di quello che lo presenta al mondo intero come uno “spassionato filantropo”. Pensate un po’ a quanto avrebbero dovuto spendere in pubblicità per presentarsi, ed essere inferentemente considerati, come “artisti umanitari”. Non c'è prezzo che si possa pagare per la propria reputazione, e questo ragionamento ha sia andata che ritorno. Nel mondo dell'arte di reputazioni ci si campa. Non è un caso che i fatti personali, la vita privata dei personaggi ritenuti di spicco, sono sempre eventi da prime pagine di giornali scandalistici e non, e mi fanno ridere quelle star che si arrabbiano quando i giornalisti vanno a mettere il naso nei loro fatti privati. Evidentemente ritengono che i soli fatti che li riguardano e che debbano essere divulgati siano quelli in cui hanno qualcosa da guadagnarci, come quando fanno finta di fare solidarietà. Chissà perché rendere pubblico il fatto che loro siano personaggi con una forte umanità non li infastidisca.
Cari miei, se accettate di farvi belli con quelle notizie, dovete accettare anche che vi si faccia brutti con altre meno lusinghiere, altrimenti rendetevi agnostici, impersonali, e occupatevi solo della vostra arte, senza cercare sotterfugi che vi facciano guadagnare di più. Ragazzi, di Gesù ce n'è stato uno solo, per questo siete poco credibili.
Per tali motivi reputavamo questi “artisti” alla stessa strenua delle meretrici. La vera solidarietà non si può fare che restando nell'anonimato, perché al macellaio non costa nulla regalare un pezzo di carne ad un barbone. Magari del giorno prima, come sono certe “canzoni umanitarie”; un giro di Do, tre facce famose, un bel video, e giù coi contenuti umani! Ma perché gli artisti non s'infilano le mani in tasca e tirano fuori un po’ di moneta sonante? Se è solo una questione di solidarietà come dicono, in questa maniera rinuncerebbero davvero a qualcosa che gli appartiene per una giusta causa, no? La verità è che si potrebbe fare la stessa operazione senza dire che è per solidarietà, ma in quel caso mancherebbe il ritorno pubblicitario.
Sono sicuro che facciano più solidarietà trenta secondi di lacrime sincere che cadono sul viso di un individuo chiuso nella propria stanza, piuttosto che tutti i soldi che possono dare le rock star o i divi cinematografici e televisivi. Come disse Cristo, “a suonar la trombetta dinanzi a sé si ha appieno la propria ricompensa”.
Ridevamo spesso di queste cose, giusto per non piangerci, ma credo che molti di noi agognassero finire nel “calderone Pavarottiano” o nel giro della solidarietà catodica.
La persona che meno di tutti credeva nelle nostre possibilità era proprio Marta. Non ho mai capito se la sua era invidia o ciò che lei riteneva consapevolezza dei nostri mezzi, sta di fatto che non perdeva occasione per tirarmi giù il morale o cercare di disilludermi. Non so perché. Probabilmente per la nostra confidenza. E' più semplice alzare la voce con un parente o con un amico che con uno sconosciuto, perché in questo caso si è ignari della capacità e qualità di reazione.
Lei, come quell'abbronzatura che si prende involontariamente, lavorando o facendo qualsiasi altra cosa, pareva portasse in sé una sorta d'invidia condizionata.
Ma non era proprio colpa sua. E' comico come molto spesso siano proprio le persone che conosci meglio a non avere fiducia in te e in quello che fai. Senza alcun dubbio questo avviene perché devono avere un'alta considerazione del giudizio che hanno precedentemente dato su di te. Gli sembra strano di quanto puoi rivelarti più di quello che ti avevano valutato, stimato. Presumibilmente ognuno di noi (e io ne sono un chiaro esempio) è convinto di non sbagliarsi mai, e dover cambiare idea o giudizio, e quindi approccio con chi si crede di conoscere perfettamente, non fa piacere a nessuno.
Nel Vangelo abbiamo l'esempio di Cristo, che quando tornò nel suo paese natio con la nomea di profeta nessuno gli credette. Penso che quando fece riferimento all'impossibilità d'essere profeta in patria, intendesse sottolineare proprio quest'aspetto.
Si sa, siamo talmente presuntuosi da avere la certezza di conoscere soltanto persone mediocri, o, al massimo, alla nostra stessa altezza. Ma quando un nostro conoscente si rivela essere meno mediocre di ciò che avevamo pattuito con noi stessi, allora è lì che può nascere l'invidia, la gelosia, la derisione, addirittura l'odio.
Marta aveva sempre conservato e nutrito la consapevolezza che, se mai ci avesse provato, poteva riuscire a fare quello che facevo io. Si è sempre considerata al mio stesso livello, se non migliore di me, e nessuno avrebbe potuto farle cambiare idea.
Quel che facevo erano sempre sciocchezze, ciò che dicevo, per quanto originale potesse essere, non era certo distante da quel che poteva pensare o dire lei, i miei amici erano tutti scemi, i miei gusti noiosamente scontati, le mie donne passate delle ninfette, la nostra musica una stronzata. Era talmente sazia di sé che si vomitava di continuo.
Spesso mi chiedevo perché stava con me.
Inutile dire che lei, delle cose succitate, non faceva nulla. Non lavorava che saltuariamente, non aveva terminato gli studi, non aveva hobbies e neanche tante amiche. Aveva continuato a farsi mantenere dai suoi genitori, e sovente pareva dire che ciò che le davano glielo dovessero. Ma, a sentire Marta, non aveva incertezze né sul suo futuro, né su quello del mondo, e neppure sul mio.
Qualche volta, quando avevamo litigato, le scappava di dire che ero un fallito. In realtà era lei ad essere la rappresentazione fisica dell'insuccesso.
Continuava a viversi addosso senza pensare che chi la manteneva, i suoi genitori, viveva di una misera pensione. Trascinava le sue giornate senza far nulla, aspettando la sera per andare in giro ad atteggiarsi o per vedersi con me. Le sue movenze vantavano sapienza e saggezza, ma la sua conoscenza, benché non fosse da “anacoluta”, non era di altissimo livello, e anche quel poco che sapeva era il chiaro risultato di anni passati a non fare nulla.
L'unica differenza che c'era fra me e Marta, era che io non mi repu-tavo di un livello assai maggiore degli altri, perfino di lei, e che non facevo niente per nascondere questo fatto. La consapevolezza delle mie meschinità la mandava su tutte le furie, tanto che a volte dovevo preoccuparmi di tranquillizzarla dicendo:
- Non hai capito. Guarda che parlavo di me.
Lei, che era cosciente del fatto che tutti ci sapessero fidanzati, mi rimproverava queste ammissioni di nullità, ed era portata a farmene una colpa. Io mi sentivo innocuo, e tutto ciò che potevo rispondere a lei che mi guardava cercando di celare l'ira, era di non prendersela più di tanto per le pochezze altrui, fossero le mie o di qualche sua amica o del mondo. L'unica cosa a cui non c'è rimedio sono le altrui insofferenze.
Fu così che scoprii una Marta ambiziosa, che non curava, è vero, la materialità, ma che non disdegnava neanche poter vantare le eventuali qualità di quello che riteneva essere il suo ragazzo, cioè io.
Ancora non capivo di quale genere di amore soffrisse Marta. Ero più che certo dei miei sentimenti verso di lei, anzi, sovente ero succubo di loro poiché non potevo reagire, quando lei mi attaccava, per paura che tutto finisse. Marta, che se n'era accorta, un po’ con questa realtà ci giocava, assai frequentemente facendomi passare per un poveretto senza rimedio, fottuto a vita. Io ero diventato uno squallido cerchiobottista. Davo un colpo a Marta, il cerchio, per non dover litigare di continuo, e uno alla botte, me stesso, quando ero da solo, per darmi ragione, perché forse, come scrisse Andrè Gide, questo “mi consolava di non avere altro”.
Sono fermamente convinto che Marta fosse una di quelle ragazze che una volta esser riuscite a conquistarci credono che quella “cattura” valga una volta per tutte. Lei dava per scontato il nostro rapporto. Poco ci teneva a dimostrarmi il suo amore, e sicuramente si guardava bene dal farlo davanti ad altri uomini, categoricità che le avrebbe precluso il loro l'interesse e, in tale modo, la possibilità di appagare la sua vanità.
Questo non darmi troppe sicurezze che mi avrebbero permesso di guadagnare terreno nei suoi confronti, ho il dubbio fosse una tattica studiata a tavolino. Marta rientrava nella categoria di donne che riescono a tenere il loro uomo per le palle soltanto grazie alle inequivocabili ammissioni d'amore che lui le ha fatto. Era sicura che l'amavo, e usava il mio amore come un'arma subdola.
Raramente si faceva sfuggire un “Ti amo”. Era la sua forza, questo centellinare ammissioni. Io, in quell'oggi, rimpiangevo il fatto di essermi così esposto, ma ormai non potevo più tornare indietro. Tutto questo suo giocare l'avevo capito fin dal principio, ma avevo ritenuto che se mi fossi sciolto io per primo, forse si sarebbe addolcita. Che errore! Uomini, dite “ti amo” alle vostre donne solo salendo i gradini della chiesa, tutt'al più il giorno che le lasciate.
Talvolta mi chiedevo se questo suo modo di amare non fosse una specie di sindrome, una sindrome d'amore. La speranza di piacere, di essere amata, di essere considerata, la portava a ricercare la “visibilità” in maniera esasperata. Oggi penso che non era poi tanto strano quell'amore spiato, confabulato, sussurrato per non farsi sentire, annacquato. Ciò che allora non potevo sapere era dove la sua vanità poteva portarla, ma da lì a qualche tempo me ne accorsi a mie spese.
II.
Marco Gagliardi era certo della venerazione che gli portavamo e a cui alcuni dei miei compagni lo sottoponevano ogni volta che ve-niva a trovarci in sala prove, e che lui se ne compiacesse saltava agli occhi.
Erano soprattutto Alessandro e Giacomo a stargli addosso, a corteggiarlo come si può corteggiare un boia la vigilia della propria esecuzione. Io me ne stavo lontano. Le lusinghe non sono mai ri-uscito a digerirle, sia che avessi dovuto esserne il mittente, sia quelle volte che mi era capitato di esserne il destinatario.
Gagliardi dissimulava sicurezza, ma non era di quelle sicurezze che non tengono conto degli altri perché si basano su ciò che esse stesse hanno, ma di quell'altro tipo che fa leva sulle debolezze altrui, sulle carenze e sulle ambizioni. A lui doveva apparire piuttosto chiaro che noi eravamo dei ragazzotti che non sapevano nulla di mercato discografico, e che quindi, quasi a nostra insaputa, eravamo assai proclivi alla simonia o a cadere nelle braccia delle facili promesse.
Chissà, forse io e Maurizio avevamo sbagliato fin dalla sera in cui lo conoscemmo, quando, ingenui, dicemmo che i nostri compagni tutto facevamo per vanità, così lui, che lo aveva constatato, adesso se ne approfittava.
Il giorno che venne a prendere in consegna il nostro nastro, tutti noi, compreso me, eravamo eccitatissimi. Quell'esaltazione era il frutto dell'illusione di saperci ricercati e, anche se non morbosamente desiderati, importanti per qualcuno. Questo, per il momento, pareva bastarci.
Gagliardi fece tutto il possibile per metterci a nostro agio in casa nostra. Sembravamo una di quelle famiglie povere alle quali è toccata la sorte di essere visitati dal Papa.
Ogni giorno che passava mi sorprendeva a fare comparazioni fra il mio amore per Marta e la mia vita di musicista. Mi chiedevo sempre più spesso se stare con Marta non fosse una maniera per appagare quel rimasuglio di vanità che era rimasta nel mio corpo dopo averla combattuta, come se fosse il resto di un'armata vinta dopo una guerra, la cui prigionia è solo qualcosa che rallenta le operazioni, le tattiche del Generale sul campo di battaglia. Avevo lottato sperando di poter vincere il compiacimento provato a stare sul pal-co, davanti alla faccia degli spettatori, ma forse quel che avevo creduto una facile vittoria non era che una trasposizione, una sostituzione, uno spostamento della mia vanità dagli occhi del pubblico a quelli di Marta.
In quei giorni così febbrili di attesa io avevo completamente trascurato Marta, e lei ne soffriva. Fondamentalmente era una donna sola, che cercava di nascondere la sua solitudine dicendo che del mondo se ne fregava. Ma aveva bisogno di uscire lei, uscire con me, farsi vedere in giro, guardare ed essere guardata, frequentare feste futili e futili amicizie, andare al cinema, nei locali, per negozi, al mare….
A certa gente basta “andare”. Credono che la mobilità riesca a mascherare tutto, perfino la loro pochezza. Così ci si finge viaggiatori, scopritori, consideratori, pensatori che non possono stare fermi perché devono appagare le esigenti richieste del proprio cervello. Magari andando in discoteca la sera, o al ristorante, o a cena a casa di amici, bevendo, fumando e vomitando enfasi e crucialità su discorsi sentiti la sera prima in qualche squallido talk show progressista (quella demagogia umanitaria di cui una parte politica vuole appropriarsi), e ripetuti arrogandosene la paternità, stando bene attenti che in giro non ci sia qualcuno, ogni sera puntualmente rilevato dall'Auditel, spettatore fedele di quello stesso programma. Io, che in quel periodo non avevo molta voglia di mostrarmi al mondo, rispondevo quasi sempre di voler stare a casa. Lei allora diceva:
- Come fai a scrivere se non vedi mai nessuno? Se non conosci la gente? Se non la frequenti?
- Guarda che la gente la conosco già, - rispondevo io - e non mi fa una grande impressione. Conosco abbastanza di loro da preferire di stare a casa, lontano da tutto e da tutti.
La “disillusione iconoclasta” di Marta era già svanita.
Talvolta il suo amor proprio e la sua vanità la portavano ad uscire da sola, ma non sapeva dove andare e un paio d'ore dopo era già di ritorno. Non ammetteva nulla, ma probabilmente senza di me si sentiva fuori posto dappertutto. Non ch'io fossi uno che sapeva vivere o che la facesse particolarmente divertire, ma perché, da vani-tosa, l'unico modo che aveva di far passare il tempo era quello di compiacersi.
Un sistema che aveva preso ad usare sempre più spesso per appagare la sua vanità, era quello di vedere nei miei occhi quella gelosia infantile che lei amava causarmi facendo la stupida con qualche semi sconosciuto o con uno dei miei compagni del gruppo. Per far questo non le serviva tanto, giusto qualche occhiata prolungata, o due paroline a doppio senso dette per scherzare. Il Dubbio si era talmente impossessato di me che a Marta bastava davvero poco per farmi ingelosire.
Ogni tanto Maurizio, quando non era troppo “fatto”, mi chiedeva dove trovavo la forza per non mandarla al diavolo. Domanda a cui non sapevo rispondere se non in modo evasivo e per nulla convin-cente. Qualche volta ammettevo che ne ero innamorato, quand'ero in forma, ma questa scusa non sembrava risolvere la questione una volta per tutte. Riuscivo soltanto a riciclare eternamente la domanda e a cambiare discorso. Maurizio, proprio lui, mi guardava come se fossi uno del Terzo Mondo.
Loro non erano come me, loro riuscivano a non innamorarsi delle loro ragazze, riuscivano a tenerle a distanza. Chissà, forse proprio perché erano vanitosi, e cercando di nutrire la loro vanità rendevano le loro storie d'amore poco importanti.
Gagliardi doveva portare i nastri al Produttore, un tipo per il quale la musica era solo business. Noi dovevamo aspettare. Era riuscito a persuaderci che potevamo aver fiducia, e noi eravamo eccitati come una diciottenne al ballo delle debuttanti.
Dal giorno in cui consegnammo il nastro al Gagliardi fino a che non ci diede risposta, continuammo a vederci e a suonare nel locale, anche se eravamo pagati da fame. Quei pochi soldi ci servivano per mandare avanti la baracca restando lontani da quel tipo di vita che assorbe gli individui omologandoli. Tutto il gruppo era sicuro di non voler fare la vita della normale umanità, affogati dentro la quotidianità del lavoro secolare, mischiati ad un via vai di vite che aspettano la Domenica per dormire qualche ora in più, la fine del mese per intascare l'agognato e sempre insufficiente stipendio, e il Sabato per consumare uno squallido e scontato rapporto sessuale con la propria partner. Non la consideravamo vita per noi.
Eravamo certi che la vita dell'artista fosse un'altra cosa. In giro per concerti, adorati da folle di fans in delirio, continuare a fare musica divertendosi, conquistare ragazze col semplice schiocco delle dita (ah! come davvero tutta la ricerca disperata della “dèa-cagna” si risolva in questo!) ed essere vitali. Inutile dire che ci accorgemmo anche troppo presto che le cose non stavano messe proprio in quella maniera.
Dopo tre settimane Gagliardi ci venne a trovare in sala. Appena varcò la soglia di quel confuso e abborracciato puzzle, lo tenemmo sotto scacco con gli occhi trattenendo il fiato. Dopo averci sotto-posto ad un discorso di circostanza che sicuramente doveva essersi preparato prima, prese respiro e guardandoci negli occhi disse:
- Ebbene, ragazzi. Il Produttore ha deciso di metterci i soldi. Dovrete accettare qualche cambiamento, ma è il minimo. Domani mattina passate da me per il contratto. Alle undici in punto. Vi farò sentire il vostro disco, il risultato finale.
Appena Gagliardi uscì esultammo come hooligans inglesi e decidemmo di andare a festeggiare. Andammo tutti a casa a prepararci. Prenotammo al Ristorante in cui vidi Marta per la prima volta. Portammo le rispettive fidanzate e invitammo qualche amico.
Quando raccontai tutto a Marta lei mi sembrò felice, felice per me. Stranamente non mi fece nessuna raccomandazione né critiche e non ebbe da ridire su niente. Si preparò, come le fidanzate degli altri del gruppo, e uscì con me tenendomi il braccio.
Quel giorno rividi la Marta di qualche tempo prima, quando, per la seconda volta, l'avevo conosciuta. Simpatica, affabile, intelligente, per nulla vanitosa. Passammo la serata a ridere e a scherzare. Pareva d'accordo con tutti, e tutti, a loro insaputa, erano d'accordo con lei. Non aveva voglia di litigare e si comportava cameratamente. Di nuovo mi chiesi se non mi fossi sbagliato nel giudicarla.
Chissà se quello era davvero lo specchio fedele dell’anima sua. Certamente era quello da me preferito, quello nel quale adoravo rimirarmi.
Quella serata finì, come ci accadeva molto spesso quando anda-vamo a mangiare fuori tutti insieme, in sbevazzamenti e comportamenti molesti. Alcuni di noi s'atteggiavano già a star mondiali della musica, nonostante ancora non avessimo fatto neppure il primo passo per essere conosciuti e apprezzati.
Quel che ancora non eravamo si rivelò completamente la mattina dopo, quando, baldanzosi ma diffidenti come cuccioli lontano dalla mamma, entrammo, alle undici in punto, nell'Ufficio del signor Gagliardi. Era in piedi e, piegato sulla poltrona nella quale, accanto al Produttore Lopresti, era seduto un signore alto, che non rideva mai, impomatato come un mafioso americano degli anni quaranta, e vestito con un abito completamente nero, da noleggiatore di sedie di fine ottocento, parlava come un'ex muto miracolato da poche ore.
Salutammo interrompendo quella logorroica cascata di parole. Dopo aver scoperto l'ABC del managerismo discografico, scherzando e ridendo, ci apprestammo a firmare un pezzo di carta che confermava quanto poco spazio ci sia per i sentimentalismi artistici. Si chiamava “Contratto”, e nel corso degli anni ne avremmo firmati a decine.
Gagliardi fece portare da bere e brindammo a quello che doveva essere un nuovo rapporto di lavoro. Dopodiché Lopresti e l'altro signore se ne andarono.
Soltanto allora Gagliardi ci portò in una sala attigua a sentire il risultato finale, il master del nostro disco. Tutto ci saremmo aspettati da uno come lui, ma non ciò che in verità ci fece.
Quando ascoltammo quel nastro stentammo a riconoscerlo. Gagliardi lo aveva completamente cambiato. Aveva rimixato con ar-chi e violini tutto il materiale che gli avevamo dato. Lui diceva che così avrebbe funzionato, avrebbe avuto successo, avrebbe venduto.
Gli altri, ecumenicamente acquiescenti, risposero che andava bene ugualmente. Solo io e Maurizio ci sentimmo derubati di ciò che sentivamo come nostra eredità, nostra creazione, come nostro figlio. Lui si girò verso la finestra e, appoggiato al davanzale, prese a guardare fuori nero di rabbia. Io, fissando il Gagliardi che cercava di fuggire il mio sguardo, dopo pochi minuti aprii la porta e me ne andai.
Girovagai per qualche ora, entrando in diversi bar e bevendo per calmare la rabbia. Poi andai sul lungo mare, scesi in spiaggia e mi adagiai sulla sabbia a pensare.
Ci aveva fregato. Aveva fatto del nostro disco il suo disco, e del nostro modo di concepire la musica nient'altro che spazzatura da gettare via. Ero incazzato col mondo intero. Deluso, amareggiato, distrutto e seriamente intenzionato ad abbandonare tutto quanto, Gagliardi, gruppo, locale e forse anche la musica. Ci era successa la stessa cosa che accadde ai Genesis col loro primo disco, allorché Jonathan King riempì “From Genesis to Rivelation” di arrangia-menti fatti con archi e violini, togliendo a quel disco la sua genuinità. Noi eravamo stati privati della nostra personalità. Marco Gagliardi, questa faccia da “mandilla”, in pratica ci aveva strappato il volto.
Ma soltanto io e Maurizio sembravamo dispiacercene. Per gli altri tre questo fatto non aveva molta importanza. Non si erano ben resi conto che da compositori erano diventati, senza esser stati avvisati, dei semplici esecutori, interpreti. O forse era anche peggio, forse se ne erano accorti benissimo, ma, vanitosi, potevano assumersi la re-sponsabilità d'aver inciso qualsiasi cosa, d'essere accusati di stupro o di omicidio, se il diretto risultato fosse stato il successo.
Dopo un breve giro di parole si erano fatti convincere dal Gagliardi che, per prima cosa, l'importante era farsi conoscere, l'appagamento artistico poteva venire dopo, più tardi, col tempo. E loro avevano annuito come scolaretti rimbrottati dall'insegnante.
Con le scarpe piene di sabbia pensai che Marta avrebbe saputo inevitabilmente tutto, e di conseguenza mi avrebbe giudicato un imbecille, l'ultimo degli sprovveduti. Questo m'infastidiva parecchio, ma era pressoché impossibile nasconderle quello che era successo. Avrebbe comunque saputo. E' strano, ma ricordo che non m'interessava di come mi avrebbe giudicato come uomo, ma ciò che avrebbe pensato di me quale artista. Anche se non ero ancora completamente entrato nell'ottica di considerarmi uno affine all'arte, quel che più mi premeva era non essere reputato una bagascia da poco prezzo, uno che si vende per cercare il successo, per essere riconosciuto quando camminava per strada e per avere stuoli di fans alle calcagna.
Ma chissà, forse anche quella era vanità. Sapevo che non mi sarebbe dispiaciuto essere considerato per la musica che facevo. Purtroppo, però, mi rendevo anche conto che quasi mai è così.
I fans giudicano gli artisti di cui sono gli accoliti non per la loro musica, ma per come si vestono, perché sono conosciuti, perché sono carini, perché sono contro la guerra, contro le armi, contro la fame nel mondo, contro l'Aids, contro la caccia alle balene, per la salvaguardia del panda, del canguro australiano, per la ricerca con-tro il cancro e perché sono sempre in televisione o sui giornali, insomma, delle “politicamente corrette” facce di merda. Niente accenno all'arte, alla loro musica.
Anche i nostri fans, quei pochi che fino ad allora avevamo, ci apprezzavano perché in città eravamo conosciuti e non per il motivo per cui lo eravamo. Per loro potevi essere famoso solo perché eri un terrorista, un assassino, un serial killer o un bombarolo, poco importava. Anche il nostro pubblico riteneva che fosse indispensabile uscire dall'anonimato, perché è la strada più semplice e veloce per poter bruciare vanità. Io non ne potevo più d'esser ritenuto uno da conoscere per potersi vantare.
Avevo la mezza idea di abbandonare tutto. Quel genere di vita era ad un passo dal deludermi compiutamente.
III.
Quando una qualsiasi cosa che avevi desiderato e sperato ti accadesse ti si ripresenta, una volta raggiunta, come cosa trascurabilissima, sentirsi la delusione addosso è più che scontato. Chissà perché quasi tutte le persone credono che nel mondo dell'arte, sia essa musicale o letteraria o di altri generi, siano necessarie, per entrarci e rimanerci, particolari qualità morali. Nulla è più falso. Ci vorrebbe troppa comprensione per trasformare in un paradiso di virtù un mondo che come tutti gli altri mondi è soggetto a gelosie, invidie, banalità e futili ragionamenti. Gli imbrogli, i plagi e le contraffazioni proliferano nel mondo dell'arte come in qualsiasi altra disciplina della vita, e tanto più ne impregnano l'universo musicale, anche se per chiamare arte un certo tipo di musica bisogna essere degli inguaribili ottimisti.
La mattina del contratto non riuscii a restare davanti a quella commedia, ai ragazzi che accettavano tutto, alla faccia rassegnata di Maurizio, al mobilio di quell'ufficio, distaccato, formale, da “Generali”. Uscii con la speranza di scovare un po’ di contatto, di fisicità, e riuscii a trovarle in spiaggia, davanti alle onde calme, placide.
Il mare di Genova non è come gli altri mari, è diverso, pare abbia tempi che non esistono in nessun altro posto. A Genova il mare parla. Racconta di amori finiti male, di amicizie perdute, dei bei tempi lontani, andati ormai. E poi riesce a trasmetterti una dolcezza misteriosa, che forse è il lato segreto di questa città.
Venire a Genova è un po’ come leggere un libro; i personaggi sono discreti, lasciano vivere e soffrire, non ti rubano le tue sconfitte. Le strade non sono altro che nuovi capitoli ansiosi d'essere scoperti, non si lasciano capire alla prima occhiata. Genova esige attenzione, impegno, per essere capita. Genova è una storia d'amore, non un giallo. Non vi sono colpi di scena, a Genova. La sua bellezza è tutta nell'animo, nel carattere, in un viaggio introspettivo eterno e affascinante, nei fremiti, nelle contrizioni con cui l'autore, Dio, l'ha ri-vestita. Una città che sembra passare del tutto, e invece poi ritorna. Una città che ci cambia, che ci coccola, che ci nutre, che ci fa cre-scere, che ci custodisce intatti e ci modella, che ci fa sembrare più belli e intelligenti, brutti e ignoranti, che da noi impara e che a noi insegna. Genova è un archivio del mondo, è la visione della vita nella sua interezza tramite il recupero del Passato, che a Genova non si esaurisce. I suoi personaggi vivono in simbiosi con lei, e nonostante restino sempre gli stessi, uguali, Genova li maneggia, li mescola, li fonde, li separa nuovamente, li traveste, li diversifica, li racconta cattivi e poi buoni, nobili e puerili, stupendi e ancora orrendi. Li stravolge presentandoli in diversi ruoli, e attraverso le sue strade li fa piangere e poi ridere, litigare e contraddire, amare e odiare, morire e rivivere essendo ricordati.
Siamo noi quei personaggi. Noi che non ci conosciamo seppur fratelli, noi che non ci frequentiamo seppur compagni, noi, abitanti di questa città e prigionieri di uno stesso Destino.
Genova è un mistero difficile da scoprire, è un segreto che non si può svelare. Non ha “Stele di Rosetta”, Genova. O la odi o la ami, o la conquisti o ne sei conquistato. Puoi viverla senza scoprirla, ma non puoi scoprirla senza viverla. Genova non è megalomane, non è vanitosa, non è esibizionista. E' gelosa di sé stessa, non fa mai parlare di sé. Genova “imbarca”, non si fa “imbarcare”. E' un burbero professore, questa città. Un professore smanioso di farsi amare dai suoi alunni. Genova è un antico romanzo, scritto una volta per tutte da chi si era allontanato dal mondo. Un’opera proustiana fatta di scatole cinesi, un'enorme madeleine inzuppata nel Mediterraneo il cui gesto nasconde moltissime cose e nessuna.
Genova è Swann ma anche Guermantes, è la bellezza filiale di Gilberte e quella ambigua di Albertine. Ha le pareti foderate di sughero per proteggersi dai clamori esterni ed è disposta a litigare col mondo, ma solo per poterci fare poi la pace. Ogni tanto si perde, Genova, ma dopo un po’ si ritrova.
Genova è mia madre che mi consola delle ingiustizie subìte.
In quella spiaggia mi son ritrovato a rimpiangere i tempi beati dell'ingenua adolescenza, quando tutto era vero, magico, e bastava la colonna sonora di una particolare canzone che ti piaceva per farti sentire il centro del mondo. Ti scoprivi, allora, coi lucciconi agli occhi, cullato da quella musica che dava briciole di paradiso che nessun altro, fosse stato misero o potente, capace o inetto, poteva darti.
Ricordai come avevo considerato un tempo sincopato che unito ad una particolare armonizzazione mi aveva portato ad impazzire di gioia. I Genesis di Peter Gabriel e Steve Hackett. Era quella, l'unica arte che conoscevo. Come consideravo arte il saper scrivere testi che uniti alla musica facessero sognare il cambiamento, la fratellanza, il martirio per i propri ideali, l'amore e non la guerra. Ivano Fossati e Fabrizio De Andrè (che mi piaceva paragonare a Caproni, mio poeta preferito), cantori ineguagliabili della mia Genova, non semplici musicanti, ma artisti della Letteratura contemporanea.
Quell'oggi mi chiedevo dove tutto questo fosse andato a finire. Era possibile che non fosse mai esistito? No, mi dicevo. Quello che avevo sentito nel profondo del cuore, i brividi che il tal pezzo mi aveva provocato, le assurde e inspiegabili nostalgie, non potevano essere scomparsi. Ero consapevole che quei turbamenti di spirito, quelle contrizioni del mio animo, non fossero qualcosa di sprecato, da qualche parte dovevano trovarsi, magari persi nelle irrequietezze comuni, in quelle utopie di adolescente, che non erano morte, tutt'altro. O sul fondale profondo delle mie lacrime, in un'ideologia lontana, ma non persa per sempre. Ne ero certo, quei sentimenti non aspettavano altro che di essere ritrovati. Ero sicuro di non aver sprecato niente di me stesso, del mio amore per la musica, tuttavia ero stanco e disilluso.
Quando subiamo una delusione cocente siamo portati a reagire in due modi diversi, opposti; o ci abbandoniamo e sentiamo di dover desiderare la morte, o, in quella che crediamo una reazione, ci vien su dal di dentro una specie di voglia di rivalsa, di vendetta contro chi, consideriamo, ci ha tradito. Io, che non sono mai stato un lottatore, mi sentivo trascinato verso l'abbandono. Non avevo voglia di reagire e non sapevo neppure contro chi farlo. Non ho mai ambito ad avere così tanti nemici come quella mattina, in quella spiaggia. Tornando a casa li ricercai accuratamente, sguscianti negli autobus schifosi, fermi al semaforo maledetti, nelle disgrazie planetarie di cui le prime pagine dei giornali grondavano, o nelle scontatissime elezioni politiche che con la loro dominante prevaricazione avevano violentato la città ricoprendone di manifesti i muri. Volevo prendermela con qualcuno per rinvigorirmi e trovare quella forza che mi avrebbe consentito la reazione. E invece niente. Per il mon-do pareva non esistessi.
Chissà per quale oscura ragione più che l'amore è l'odio ad aver bisogno delle facce, altrimenti la forza per battere il nemico ci mancherebbe, e ogni sforzo sarebbe vano, e ogni battaglia irrimediabilmente persa.
Se ci capita di essere vittime di un furto, il fastidio che proviamo può essere alleviato soltanto conoscendo, sapendo e vedendo da vicino la faccia di colui che lo ha commesso. Tuttavia i gesti anonimi ci fanno soffrire solo se si rendono colpevoli di torti, mai di amicizie. Se una lettera anonima ci parla d'amore ci lusinga, e la notte dormiamo. Ma se ci minaccia di morte ha la capacità di toglierci il sonno! Eppure l'anonimato dovrebbe essere in ogni caso una vigliaccata. Chi ci ama privandoci della possibilità di vedere il suo viso non è consigliabile come marito per nostra figlia o come socio in affari, perché il male che quell'anonimo c'infligge è quello di esporci a possibili delusioni. Forse era per tali ragioni che i popoli antichi si costruivano degli idoli e delle immagini da adorare. L'odio ha bisogno di nemici visibili esattamente come l'Amore necessita, come punto di riferimento e di appagamento, dei tocchi e quindi della conoscenza.
Allora capii che non c'era rimedio. Fu così che per un paio di giorni caddi nell'abbandono. Ebbi giusto la forza di alzarmi dalla sabbia e far ritorno a casa.
Incredibilmente fu proprio Marta a spronarmi e farmi riprendere. Le telefonai e le chiesi se poteva venire da me. Rispose di sì. Dopodiché accesi lo stereo e infilai Mendelsshon, la sessanta-quattro. Il secondo movimento m'inumidì gli occhi restituendomi un volto umano e consolandomi dell'ingiustizia subita. Dopo una mezzora Marta arrivò. Le raccontai tutto, e lei parve dispiacersi per me. Mi confortò come una mamma conforta il suo bambino che giocando in piazzetta ha perso il pallone, o, ancor peggio, gli è stato bucato dai morsi di un cane. Quella notte facemmo l'amore. Lo facemmo come una delle prime volte, quando l'ansia di scoprirsi era tanta.
Lei sembrava contenta di questo suo nuovo ruolo, quello della missionaria, della crocerossina. Piano piano mi curò le ferite, mi alleggerì di quel dolore al cuore che hanno certi deboli soldati al fronte, quando si vedono circondati dalla morte e si mettono a piangere. Mi regalò parole che nutrirono il mio vocabolario dell'anima, e baci che, come unguenti miracolosi, alleviarono il mio dolore e la mia delusione. Le sue carezze richiusero per qualche giorno il luogo del cuore dove i rancori, come serpi velenose, si vanno a nascondere per entrare in letargo e tornare ad uscire per colpire qualche tempo dopo. Il mio amore per lei fece il resto, e un paio di giorni dopo ero rinfrancato e pronto a ricominciare.
Oggi mi chiedo spesso perché è così strano che si riesca a tirar fuori della dolcezza anche dalle pietre. Non è da poco tempo che mi sono accorto di come qualsiasi persona, per quanto indurita possa essere, sia comunque in grado di tirar fuori della dolcezza quando ce n'è bisogno. Che sia per sé stessa o per gli altri.
Marta, che era quanto di meno sentimentale avessi mai conosciuto, quella sera si rivelò un contenitore di umanità e dolcezza, tanto che mi fece sorgere il dubbio che fosse malata. Aveva sbalzi di umore e di comportamento da far credere che soffrisse di qualche complesso strano. Passava dalla parvenza di un egoismo più sfrenato ad una umanità eloquente e compassionevole, da Madre Teresa di Calcutta, nel giro di poche decine di minuti. L'unica cosa che dal suo viso raramente spariva era l'eterna vanità.
Quando due giorni dopo uscii di casa per mischiarmi al mondo, avevo riguadagnato me stesso. Come prima nulla poteva più scalfirmi. Avevo solo acquistato dell'esperienza in più da mettere nella cascina della disillusione, qualcosa che mi fece prendere coscienza di quanto ancora non fossi completamente deluso dal mondo e dai suoi abitanti, da amici e sconosciuti, ma anche da me stesso.
Ognuno di noi vuole convincersi che il mondo sia meno carogna di quello che è. Si chiama “fiducia verso il prossimo”.
Spesso avevo paura di questo sentore, dell'ottimismo e della fiducia negli altri che ogni tanto mi prendeva. Così mi ero imposto di credere all'idea secondo la quale l'umanità esista soltanto in funzione propria. Mi piaceva pensarla in questo modo, e spesso mi spiavo per sorprendermi a fidarmi degli altri. C’è da dire che in questa veste da guardone di me stesso non godevo più di tanto, perché che mi cogliessi in fallo accadeva davvero di rado, e non perché la mia fiducia negli altri era eccessivamente scarsa, ma perché anch'io, volente o nolente, faccio parte di quest'umanità, e chiedere al proprio cervello di non fidarsi di sé stesso è quantomeno grottesco. Potevo chiedergli di non fidarsi del mio corpo (sua creatura perché sua somatizzazione, che come ogni dispensatore di percezioni cerebrali accumula in sé molti bisogni di fisiche reciprocità), ma non di sé stesso.
La sicurezza che avevo in passato, quella d'indovinare a prima vista il tipo di persona che avevo davanti, se n'era andata altrove la-sciandomi solo e sperduto. Era bastato entrare più profondamente in quel mondo, fare conoscenze, per convincermi di non avere sempre ragione quando puntavo il dito verso una persona e dicevo:
“Quello è fatto così”.
Ci vuole davvero poco per farsi persuadere non solo dal proprio cervello, ma anche da persone e situazioni. Non parlo tanto del Ga-gliardi, anzi, lì ci avevo preso, ma dei miei compagni. Uno passa la vita in casa di persone comuni per accorgersi, neanche dopo tanto tempo, di aver a che fare con dei serial killers.
Gagliardi ci aveva convinto che potevamo sfondare, ma non con la nostra musica, bensì con la sua. E noi ci eravamo arresi. Ripen-sandoci adesso fu davvero facile per lui guadagnarci alla sua causa. Ma la colpa fu anche nostra.
L'umanità è convinta di andare avanti perché l'individuo conserva e nutre l'ambizione del “sistemarsi”. Siamo proclivi a pensare che i nostri desideri siano la ragione primaria per protrarre la nostra esi-stenza, la forza irresistibile della speranza di appagarli. Non è mai così. Quello che ci succede, spesso e volentieri, è determinato da una concatenazione più o meno casuale di cose piccole, che quasi mai chiedono il permesso per entrare nella vita degli individui. Sovente siamo noi ad adattare i nostri desideri alle condizioni che la vita ci mette davanti e che il caso ci procura, e soltanto raramente abbiamo voce in capitolo. Solo verso i sessantanni capiamo che la Vita è una malattia che si trasmette per via sessuale, e che la Morte è il successo di quella cura che c'impongono le ferree regole della società.
Naturalmente è pericolosissimo frustrare la convinzione che siamo proprio noi, di volta in volta, a scegliere, altrimenti si rischierebbe di cadere nell'irresponsabilità generale, e molto di quel poco che siamo riusciti a costruire andrebbe perso. Ma ciò che ci fa chiedere se siamo davvero noi, anche nel pensare, o nell'agire istintivamente, o nella troppa emotività, a dirigere appieno la nostra vita, sono quelle situazioni che ci creiamo per un gesto ingenuo, per la voglia di farci coinvolgere, per l'avventatezza che mettiamo nel desiderare la felicità.
Alcuni sofisti usano il termine “epicureo” per sottolineare il comportamento ingenuo di certi individui in certe situazioni. Ma, dopo essere passati attraverso quelle disgrazie che non ci siamo cercati volutamente, spesso sono proprio quelle nostre quasi involontarie azioni a farci raggiungere consapevolezze determinanti.
Comunque i miei amici del gruppo non furono gli unici a farmi ricredere sull'infallibilità dei miei giudizi. Anche Marta, per quanto poco si somigliassero, mi fece ripensare a certe mie avventatezze applicando a persone conosciute da poco stupidi luoghi comuni.
Avevo sempre creduto che lei fosse una specie di malata convenzionale. Soffriva di vanità acuta, e anche se questa è una malattia che affligge molti individui, io non mi facevo consolare “dal mal comune mezzo gaudio”. Soltanto sporadicamente Marta si lasciava andare a compromettenti verità di appartenenza alla normalità, ma anche qui vedevo che quando lo faceva era come se perdesse qualcosa, dei pezzi che poi non riusciva più a trovare. Un po' come quando si viene messi di fronte al contraddittorio ed essendosi inequivocabilmente compromessi con precedenti affermazioni o precedenti comportamenti, si finisce per sentirsi incastrati.
Marta, che capiva di non avere vie di scampo e di doversi in un certo senso castrare, metteva su un muso che poi manteneva per giorni interi.
Questo suo comportamento mi lasciava basito, e sovente mi domandavo se non avessi a che fare con una bambina di dodicianni o giù di lì. Anche perché la corazza che metteva per respingere i miei approcci di pace si faceva sempre più dura d'abbattere. Marta, ecco, si stava indurendo. Verso tanti, verso tutti, ma soprattutto verso di me.
In quei giorni non avevo ancora abbandonato del tutto l'idea di lasciare il gruppo e la musica. La tentazione era forte. Mi dicevo che l'omologazione non è una colpa grave, che molti vivono omologati ed hanno l'aria di non preoccuparsene affatto. La vita del musicista un po' mi aveva stufato. Era troppo irregolare, e non c'è nulla di originale o di particolarmente emozionante nel tornare a casa tutti i giorni alle cinque del mattino con la consapevolezza di non aver risolto nulla, a parte l'aver intascato le misere centomila lire, e nel disco non ci credevo più di tanto, mi era diventata indifferente la sua sorte, anche perché non lo sentivo più mio.
Quando ci pensavo mi dicevo:
- Se questa è da considerarsi arte...........................
Tutto era cambiato nei miei parametri d'approccio.
Verso la musica, verso i miei amici, verso Gagliardi, verso il locale e ancora più verso Marta. Non avevo ancora capito a cosa si do-vesse il suo improvviso mutamento, ma presto la situazione, e lei stessa, me lo avrebbero rivelato.
IV.
Subito dopo la delusione dell'incontro col Gagliardi mi sentivo giù di morale. Avevo ripreso a suonare con gli altri, sia nel locale che in sala prove, ma non avevo la stessa convinzione di prima. Loro passavano il tempo come al solito, a farsi mistificare compiaciuti e, tanto più adesso che avevano “inciso” un disco, a spacciarsi quali artisti. Io continuavo a non vedere nulla d'interessante in quella vita, ma il gruppo non sembrava essere d'accordo con me.
Perfino Maurizio cominciava a godere di quelle mistificazioni, e un giorno arrivò al punto di dirmi:
- Sai, ogni tanto si possono incontrare persone veramente interessanti perfino in questo locale. Conosci qualcuno da anni, continui a vederlo tutti i giorni, finché uno di questi lo conosci un po' più in profondità e capisci quanto può essere interessante.
Anche lui stava cadendo vittima delle lusinghe.
- Interessanti? - risposi io - Certo, come guardare un frizer che si sbrina. Mauri, noi non abbiamo alcun dovere nei confronti di nes-suno. Non si deve cercare di trovare interessanti le persone con le quali passiamo il nostro tempo, ma dovremmo cercare di passare il nostro tempo con persone che sono interessanti, e se permetti c'è una bella differenza! Non siamo obbligati ad ingoiare individui che non ci sono mai piaciuti solo perché questi continuano a venire nel locale per sentirci suonare.
- E cos'è? - disse lui dopo avermi attentamente ascoltato - Un sillogismo da Settimana Enigmistica?
No, era molto peggio. Avevo deciso di riconsiderare tutti i miei rapporti. Amicizia, amore, affari............………….
Non volevo lasciare più nulla al caso, e soprattutto non volevo la-sciare al caso il mio rapporto con Marta. Perché ci eravamo messi insieme? Ricordai che non mi era particolarmente piaciuta la prima volta che la vidi. Avevo subìto tutto fin dal primo momento? Mi sembrava di sì. Subìto come si subisce la pubblicità alla Tv. E lei, mi amava veramente? Non so quanto questo fosse importante per me. Avevo raggiunto un livello di disillusione tale, anche nel rapporto con Marta, che mi sembrava di essere entrato in quell'età in cui non si bada più di tanto alla reciprocità.
Quando pensavo a Marta come alla mia donna, mi chiedevo quanto lo avessi voluto. Intendo dire, quanto “ho voluto essere il suo uomo”. Fra i nostri due primi incontri, la prima volta al Ristorante e la seconda nel locale, non ricordavo neppure che esistesse. Non l'avevo cercata se non dopo aver constatato che non le dispiacevo.
Rivista alla distanza la nostra relazione somigliava a uno di quegli amori dell'Italia d'inizio novecento, quando una donna e un uomo si mettevano insieme e si sposavano solo perché i loro padri si erano messi d'accordo dieci, venti anni prima. Ecco, pareva che il nostro rapporto fosse stato concordato da qualcuno in chissà quale luogo e in chissà quale tempo. E io mi ero arreso.
Ma in quel rapporto ero davvero io? E l'amore che volevo a Marta era autentico? Le volevo davvero bene?
Oggi, talvolta, mi colgo a pensare che forse tutto nacque per la smania d'innamorarmi. Quando ero meno disilluso ambivo a conquistare il cuore della donna di cui mi ero innamorato, ma crescendo mi son trovato sempre più spesso ad innamorarmi di una qualsiasi donna che sapevo innamorata di me. Non so se era perché non dovevo faticare per conquistarla o per prolungare l'appagamento di quella vanità (sapersi interessanti per qualcuno) in maniera fisica, ma mi rendevo conto di essere un vinto, in amore, un vinto conclamato e terminale. Anche nella relazione con Marta mancavo di quel desiderio, di quell'ardore iniziale che ci porta a corteggiare anziché ad essere corteggiati.
In amore ogni tanto capita di scoprirci meno moderni di quel che avevamo sempre creduto. Io non mi vergognavo di essere corteggiato dalle donne, ma sapevo anche d'essere uomo e di dover tenere fede ad una parte che il copione delle tradizioni orali e letterarie mi avevano assegnato tramite una convenzione sussurrata.
Non so se in questo si possa parlare a pieno titolo di maschilismo, non credo, tuttavia sono anche conscio che un uomo che non prende l'iniziativa con una donna possa talvolta essere considerato un “mollaccione”. Non capisco perché tutto ciò avvenga ma è così.
Forse anche questo è retaggio. Ricordo che mio padre diceva sempre: “Se hai una lite con una donna e questa ti dice che sei un maschilista, è perché hai ragione”.
Io, che da sempre avevo ritenuto i corporativismi soltanto una tana nella quale si nascondono i vigliacchi, mi ero lasciato trasportare dagli eventi fino ad essere compiutamente complice del mio asservimento verso le donne.
Marta aveva voluto che andassi al suo tavolo. Aveva cominciato a parlarmi prendendosi quella confidenza che nessuno le aveva dato. Aveva bevuto con me e con me si era lasciata andare. Probabilmente fu ancora lei a manovrare perché avessimo un rapporto sessuale. Io non avevo saputo far di meglio che subire la sua aggressività di “donna emancipata del Terzo Millennio”, il suo fare sbarazzino, le sue uscite compromettenti. Quanto c'entravo io in questo squinternato amore?
Quando la rivedo in quel ristorante, con la sua bizzarra camminata, col suo sentirsi offesa, con la sua sicurezza da bella donna, col suo fare mellifluo e fastidiosamente compiacente, allora mi convinco che forse non era per me ma per qualcun altro. Ma se così fosse, quanto meritiamo di tutto quel che ci accade se in realtà ogni cosa è già stata predisposta da qualcuno che quasi mai siamo noi? E perché non chiedersi ancora quanto c'entriamo nel determinare le situazioni, la natura, la nostra stessa vita? E le mie scelte, porco Giuda!, dov'erano andate a finire? Era solo una questione di progresso, di modernismo, di libertà?
Non credo che fosse così semplice. Le domande erano più serie. “D'amor si muore”, altro che emancipazione e “risveglio delle coscienze”!
Quando Marta mi disse di essere incinta, di aspettare un figlio da me, la mia infelicità non svanì subito, si acquattò come si acquattano certi felini pronti a saltare addosso alla loro preda. Ora che avevo deciso di riconsiderare tutto il mio amore per lei, il nostro rapporto, Marta mi metteva al corrente di ciò che era la nostra storia d'amore. Mi sembrava un ricatto, una minaccia. La minaccia di chi si sente sotto giudizio e, con la miccia accesa della bomba che tiene in mano, urla: “Muoia Sansone con tutti i Filistei!”
Avevo la possibilità di mantenere un figlio? Fino a quel momento sicuramente no. Ma questo fatto non mi spaventava più di tanto, mi spaventava di più dover stare con lei perché adesso c'era un figlio. Naturalmente per me il figlio c'era. Non avevo nessuna intenzione di rinunciare a quella creatura.
Lei buttò lì quell'affermazione con la pesantezza dei suoi occhi profondi, di quello sguardo che non perdeva occasione per promettere rimproveri. Nel farmi quell'annuncio la sua voce tremava, pareva aver trovato la strada del palato bloccata, e la frase esplicativa uscì dalla sua bocca come un singhiozzo. Io rimasi inebetito per qualche secondo, smarrito e confuso come in un sogno, e non seppi rispondere altro che “Allora?”. Marta parve non voler sentire altro. Voltò le spalle e iniziò a salire i gradini del portone di casa sua. Lentamente. Pareva volermi lasciare il tempo per decidere qualcosa. Io, che non ebbi la forza né le parole per fermarla, la lasciai andare via come quel viaggiante, assiduo consumatore d'autobus di linea, che sentendosi senza ombra di dubbio alcuna in anticipo all'appunta-mento, lascia passare il suo numero senza salirci sopra.
“Le persone si uniscono per autobus che non si prendono alla stessa ora”, mi dico, citando Cèline a me stesso, ogni volta che, guardando mia moglie, le immagini offuscate di quella storia mi tornano alla mente.
Soltanto una volta a casa riuscii a capire a cosa stavo per andare incontro. Allora ritrovai la felicità che un padre dovrebbe avere quando la sua donna gli dice di essere incinta di lui. La paternità è un mutamento non solo dello Stato di Famiglia ma anche, e forse più, della propria natura d'uomo.
Ero smanioso, ansioso di dire a Marta ciò che provavo. Le telefonai alle undici di sera, urlandole tutta la mia felicità. Lei si mise a ridere e senza dire una parola riattaccò il telefono. Era proprio vero, la mia donna aspettava un figlio da me.
Cominciai a pensare che avrei dovuto trovarmi un lavoro serio, ma era cosa da nulla. Avrei continuato a suonare per hobby, per divertimento. C'era da mantenere un figlio adesso, le priorità erano cambiate. “Addio sogni di gloria musicali”, mi dissi senza per altro rammari-carmene troppo.
LA PRIMA VOLTA CHE VIDI MARTA
I.
Una cosa ricordo con chiarezza, che sempre più spesso rimanevo interdetto dallo strano andamento della mia vita. Passavo continuamente dalla delusione più cocente alla felicità piena e senza freni che mi faceva rivalutare ogni volta le cose che mi accadevano. Il fatto che Marta aspettasse un figlio da me mi aveva costretto a riconsiderare tutta la vita vissuta fino a quel momento ed a convincermi d'aver perso troppo tempo. Tuttavia i rancori erano passati, perfino verso il Gagliardi.
Che comica la vita. Sei ad un passo dal dichiarare guerra al tuo nemico, e improvvisamente tutto cambia. E allora i tuoi rancori, le tue rabbie e le tue delusioni, si diluiscono a tal punto nella nuova situazione e nella necessità di dovercisi adattare, che se ti capita d'incontrare il Diavolo in persona non è raro confonderlo col Postino.
Quando gli altri mi chiesero cos'avessi intenzione di fare, se volevo restare o andarmene, io mi presi un paio di settimane per decidere, durante le quali avrei comunque continuato a suonare con loro.
Ormai suonavamo soprattutto in sala prove, nel locale non ci vedevano che una volta al mese. Gli assegni di Lopresti ci stavano man-tenendo in vita, e non avevamo più bisogno di andare in quel posto a suonare. Quando lo facevamo era solo per appagare fisiche vanità, non certo per intascare soldini che ormai non avevano più alcun senso. Il disco era uscito e, cosi diceva Gagliardi, stava andando abbastanza bene. Ero combattuto se trovarmi un lavoro secolare o provare ancora col gruppo.
Gagliardi e Lopresti avevano fatto un grosso sforzo finanziario investendo parecchi soldi per il nostro lancio, ma erano sicuri che saremmo riusciti a sfondare e che loro sarebbero rientrati nelle spese. Dicevano che la critica era favorevole e che, per questo motivo, le speranze di piazzarlo bene erano ottime.
La critica, sia quella musicale che quella letteraria, mi ha sempre fatto sorridere. Chi ha il ruolo di recensire un libro o un disco deve sentirsi una sorta di Giudice Supremo, e difficilmente sarà obiettivo. Perché leggendo un libro egli vede la possibilità di migliorarsi migliorandolo, e ogni volta cade nella tentazione di correggerlo, di mutilare frasi o di aggiungerne di nuove, finendo per cambiare l'opera o addirittura per scriverne un'altra, perdendo il filo condut-tore di ciò che sta leggendo e non poter fare altro che recensirlo negativamente. Del resto anche “La strada di Swann”, il primo volume de “Alla ricerca del tempo perduto” di Proust, fu stroncato, tanto ch'egli lo pubblicò a sue spese. Ma oggi sappiamo che non v'è libro che valga venti righe di quell'opera.
Ricordo che quando sapevo che il Gagliardi doveva venire a darci delle direttive e dei consigli, mi prendeva il mal di stomaco. Le sue idee in fatto di look mi spaventavano. Non volevo farmi snaturare da lui. Era una cosa che non avevo mai permesso a nessuno, né ai miei genitori, né ai miei insegnanti, né alle mie ragazze, perché mai avrei dovuto permetterlo ad uno stronzo qualunque?
Gagliardi venne e ci disse, secondo lui, com'era meglio “conciarsi”. Il majestatis sovente è un escamotage per imporre il proprio volere. Voleva che cambiassimo modo di vestire e il taglio dei capelli, che ci presentassimo come i “ragazzi della porta accanto”. Alcuni di noi, a dir la verità, lo erano già. Io mi dicevo che se il nostro aspetto fisico fino a quel momento non aveva minimamente influito su tutti quelli che venivano a sentirci e che si presentavano diversa-mente da come ci voleva Gagliardi, perché mai avrebbe dovuto iniziare a farlo ora?
Ritengo che non esiste nulla di meno importante delle questioni d'abbigliamento. Per quanto bene un individuo possa presentarsi, alla fine sarà sempre quello che dice, ciò che pensa e quello che fa ad interessare le persone che gli stanno intorno. A me non importava vendermi anche sotto questo punto di vista, ma Gagliardi diceva che era necessario, e gli altri parevano volergli dare ragione.
Non appena cominciammo a provare il nostro nuovo look io mi feci ritornare la voglia d'andarmene. Ma durò giusto un paio di giorni, perché subito iniziammo a prenderlo come un gioco. Quando qualcuno di noi arrivava in sala con qualcosa di diverso, che fosse nell'abbigliamento, nella camminata o nel taglio dei capelli, i giudizi, e insieme gli sfottò, si sprecavano. Quando Gagliardi ci vide la prima volta conciati in quel modo (alcuni di noi sembravano degli spaventa passeri, altri dei tossicomani all'ultimo stadio, altri ancora dei pagliacci), inorridì. Disse che ci dovevamo conciare sì come “i ragazzi della porta accanto”, ma nel senso d'inquilini e non di chi è entrato per rubare.
Capimmo subito che ci voleva addobbati in giacca e cravatta.
Io, da quelle affermazioni, mi sentii sollevato. Anche se non ero completamente d’accordo con lui, ero però sicuro di non piacermi. Non ero d'accordo con lui per due ragioni essenziali; ho conosciuto disgraziati, barboni, tossici e poveracci che per quanto malconci potevano essere conservavano un interesse di cui ritengo siano privi certi manichini di stilisti. Secondo; Gagliardi continuava a non piacermi.
Quello che ci aveva fatto infagottando di archi e violini il nostro lavoro, ogni tanto tornava a tormentarmi le viscere facendomi stare male. Ero certo d'esser stato derubato da lui. Il perché lo capii col tempo. Gagliardi voleva farci diventare una sua creazione, voleva toglierci la nostra personalità, la nostra genuinità, in modo che, una volta portato a termine il suo disegno artistico-criminoso, noi non potessimo più fare a meno di lui. Non lo sopportavo. Sebbene aves-se fatto tanto per noi, o così fingeva che fosse, mi rendevo conto che molto aveva lavorato per sé stesso, per la sua gloria.
Ciò che più mi faceva innervosire era che da lui gli altri accettavano tutto. Molto plausibilmente non erano sicuri del loro talento, ed aver trovato una persona che li esentasse proprio dal tipo di lavoro che non erano capaci di fare, cioè vendersi, li rincuorava. Per fortuna, col successo, avemmo presto la possibilità di scendere a patti con lui e liberarci così dal suo tirannico dominio.
Non appena Marta seppe che il nostro discografico ci voleva vestiti da manichini, ne fu contenta. Mi aveva conosciuto con quelli che amava definire “cenci”, ma che erano i vestiti che portano tutti i giovani della terra, e sapermi più elegante non la infastidiva affatto, anzi.
- Sarà la volta buona che qualcuno ti rende presentabile. – diceva.
Il suo modo di vestire, anche se molto elegante, era abbastanza spezzettato. Lei amava abbinare vestiti e comportamento alla gente che si doveva vedere la sera. Se uscivamo coi suoi o coi miei genitori, vestiva semplicemente, con abiti interi o gonne lunghe e camicette o maglioncini, e faceva la ragazza seria, che non dà confidenza al primo che capita. Se veniva al locale si copriva di jeans dalla testa ai piedi, e faceva “l'attraente compassata”. Se andavamo a mangiare fuori coi nostri amici si comportava da amicona, da simpatica e cara compagna (anche se non disdegnava lanciare occhiate, lasciando, in quel modo e ai miei amici, le porte aperte a qualsiasi soluzione e possibilità) pronta a fare qualsiasi cosa per aiutare i propri “amici”, e si combinava elegantemente, in abito da sera, costringendomi alla cravatta, cosa che odio, e al travestimento. Non la odio per una forma di falso anticonformismo, ma perché mi fa sentire legato, impacciato nei movimenti, e come se avessi un burbero maestro dietro sempre pronto a riprendermi dandomi delle bacchettate sulle dita. La costrizione dell'essere compiti mi ha sempre mandato “fuori giri”.
Spesso, in camera sua, guardandola mentre si vestiva, le dicevo che non c'era motivo di conciarsi in quella maniera, che vedevamo la solita gente che già ci conosceva per tipi scombinati, ma lei non voleva sentir ragioni.
- Cosa li ho comprati a fare questi, - diceva indicando nel suo armadio quanto di più elegante possedesse - se non me li fai mai usare? Per farli mangiare dalle tarme e appestarli con la naftalina?
- Fa’ un po’ come vuoi. - rispondevo io stanco di far la guerra con lei - Tieni presente che non c'è nulla di meno elegante di chi si veste elegantemente soltanto una volta al mese, per le grandi occasioni. I nostri amici ci conoscono come divoratori di jeans e magliette, e vestirsi diversamente quando li vediamo fuori dalla vita di tutti i giorni mi sembra quantomeno da provinciali.
Alla fine si vestiva a metà strada fra l'elegante e il non curante. Io, che in realtà ero meno trasandato di quello che lei tentava di farmi credere, uscivo in jeans camicia e giubbotto.
Naturalmente lei metteva su il broncio. Non era uno di quelli che sfoderava per questioni importanti, quando avevamo dibattuto su problemi reali, e quindi non durava molto, ma mi faceva innervosire perché ogni volta mi sorgeva il dubbio di stare insieme ad una cretina, ciò che secondo me lei non era.
Purtroppo quello che siamo meno propensi a pensare quando ci mettiamo con una donna, è la possibilità ch'ella possa anche non essere quel che crediamo di vedere noi. Quando la conobbi nulla mi attendevo da lei che non fosse ponderato e intelligente. Ma piano piano quell'illusione svanì, riconsegnadomi, come quella lavanderia poco seria a cui abbiamo dato da lavare i nostri abiti, qualcosa di rovinato, di stropicciato, i cui motivi di quelle “grinze” poco riuscivo a capire.
Ma forse è naturale. Come tutti gli individui del mondo anche lei era soggetta a cambiamenti piuttosto radicali. Le cose che avevo notato come pregi, un certo intelligente snobismo, la sua non curanza nel trattare argomenti frivoli ma che la pubblica opinione ritiene essere importanti, l'arguzia di alcuni dei suoi ragionamenti, la certezza di dover trattare gli individui sempre per la loro personalità e non avendo come parametro i suoi principìi che su certi argomenti non era ragionevole applicare, la logica che usava nel trattare con la gente, finirono presto per scadere nel più bieco dei compromessi, nell'opportunismo imperante e nell'egoismo sfrenato.
Allora non riuscivo a capire come persone che sembrano intelligenti finiscano miseramente per far prevalere il loro piccolo quotidiano anche su questioni cruciali, in quegli istanti in cui bisogne-rebbe sfoderare la propria combattività, la voglia di non arrendersi, la smania di lottare. Certo, è difficile tenersi alla larga da una certa frivolezza, da quella tentazione che ci prende di lasciarci andare, anche per far gli stupidi, non importa, e considerare alcuni momenti di scarsa rilevanza, poco importanti, e per questo farsi trasportare dal proprio istinto e finire per fare gli scemi in mezzo ai saggi e viceversa, ma a un limite dovrebbe esistere per ogni cosa!
Se alcune delle sue movenze non mi si fossero presentate come gesti consueti e non come lo stato d'animo appena descritto, sicuramente non sarei giunto a certe giuste conclusioni (così si rivela-rono negli anni), ed avrei continuato a sopportare quella ragazza per chissà quanto tempo ancora, senza prendere in considerazione il fatto che potevo anche essermi sbagliato, che lei non fosse affatto la donna della mia vita, che quella scarpina, in realtà, mi stesse stretta.
E' in questo che la mia umiltà venne in mio soccorso.
Quell'umiltà di fondo che avevo conservato e nutrito, e che mi permetteva di accettare il contraddittorio senza soffrirne troppo. Era giunta l'ora di ammettere a me stesso di essermi sbagliato, di dover ricominciare tutto da capo.
Il raggiungimento di questa consapevolezza arrivò poco prima del boom del nostro disco. Marta, sempre ansiosa di apparire interessante, non si accorgeva del fatto che l'avevo scoperta, che mi ero accorto di come celava la sua vanità, della voglia che aveva dentro di farsi notare, di non passare inosservata. Ciò ch'io non capii, e di cui ancora oggi mi rammarico, è dove quella vanità l'avrebbe portata.
Dal giorno alla notte arrivò a prendere la decisione di rinunciare a nostro figlio, a decidere di abortire. Senza consultarmi, senza guerreggiare o contrattare il prezzo di quell'azione, in modo premeditato e autonomamente, decise di non portare a termine la gravidanza. Il fatto ch'io fossi il padre di quella creatura sembrava non importarle. Come molte donne nella sua situazione, si convinse abbastanza facilmente che le questioni di parto e gestazione fossero un suo inviolabile primato, e le dessero la piena autorità di decidere da sé cosa farne di nostro figlio.
Tutto l'amore che mi aveva portato e che le avevo voluto per me finiva lì. Il giorno stesso in cui decise di abortire. Quello che m'irritava era che io non servivo più a niente. Non ero parte in causa, non avevo alcun ruolo in questo giochetto macabro, non avevo diritto d'espressione, né potere decisionale né autodeterminazione. Niente di niente. Contava solo lei e il suo volere.
II.
Ed eccomi qua, coi miei quarantanni andati a male, di nuovo con gli occhi gonfi di lacrime e la faccia rossa per lo sforzo nel ricordare quei momenti.
La memoria ci riporta i ricordi non come un film o una commedia in due atti consecutivi, ma piuttosto come un libro che si sia iniziato a leggere aprendolo a caso, o, meglio ancora, come numeri estratti ad occhi bendati da un bussolotto. Oggi fatico tantissimo a richiamare alla memoria lo stato d'animo d'allora, forse perché il dolore, quando ci penso, è ancora troppo presente e troppo bruciante, ma alcuni istanti di quella storia mi appaiono come confuse vi-sioni, come deboli nuvolette che svaniscono al primo misero soffio di vento.
Ciò che da adulti ci guasta è l'impossibilità di evocare le cose minime, che poi sono gran parte della nostra vita. E' per questa ragione che gli anni finiscono per avariarsi, perché non riuscendo a ricordare che i momenti belli, numericamente assai scarsi, ci sembra di aver passato la maggior parte del tempo a non fare nulla, anonimamente.
Quando Marta mi disse di voler abortire rimasi ferito mortalmente, come e peggio che se mi avessero dato una coltellata. Quello che non capivo era il perché. Perché voleva abortire? Non c'erano ragioni visibili. Quello che io pensavo di lei non poteva essere una ragione valida perché lei ancora non lo sapeva.
Forse ero stato io a farmi trasportare dalla foga nel voler avere fiducia nel mondo, e la mia capitolazione a quel suo pseudo corteggiamento diventò, in breve tempo, lo spunto per raggiungere nuovi desideri. In quell'oggi e in quella situazione vidi con chiarezza che il mio tentativo di coinvolgerla nel nostro rapporto era miseramente fallito. La condizione dell'innamorato, il suo voler a tutti i costi essere ricambiato, dà origine a panorami d'illusione che non si riescono a cancellare se non creando, allo stesso modo, colpe altrui. Forse Marta, ecco una felice intuizione, era solo la materializzazione del mio fallimento come innamorato, come amante, e quindi come uomo.
Ma io non potevo diventare come lei, avrei dovuto cambiare realtà, la mia realtà, per dar vita ad una persona di questo tempo, a cui piacciono gli strani ordini di cose che questo tempo tremendo ha fatto propri. Avrei dovuto diventare un consapevole vanitoso, un megalomane che tutto fa per essere guardato, come se traesse dalla vista degli occhi altrui la forza per andare avanti. Avrei dovuto di-ventare “un Marta”, o comunque molto simile a lei. Ma io sono sempre stato uno “scopofobico”! Come avrei potuto, anche volendolo, diventare come lei? E se la colpa invece era solo mia? Se in realtà non ero altro che un asociale che non si era adattato al modo di vivere del suo tempo? O se forse ero uno dei pochi uomini giusti che sono sulla terra solo perché hanno sbagliato contemporaneità? Solo perché la loro presenza è un pochino anacronistica?
Tutti questi interrogativi me li posi con la speranza di trovare una valida scusa che mi avrebbe permesso, se non di perdonare, almeno di capire il comportamento di Marta, ma faticavo ad essere comprensivo. Dentro di me, piano piano, cominciò a farsi strada l'idea secondo cui lei volesse uccidere nostro figlio per vanità. Non volevo crederci, ma la sua mancanza di deluci-dazioni mi faceva pensare che una ragione vera e propria in realtà non ci fosse.
A giorni la cercai fra i risvolti di quelle scuse che lei mi propinava come ragione valida che le avrebbe lasciato mano libera per agire; non eravamo sposati, non potevamo mantenerlo, non sapeva fino a che punto ci amavamo, non si sentiva pronta per la maternità, avrebbe senz'altro perso la sua libertà, ma fra tutti questi motivi non ne trovavo uno plausibile e scusabile per compiere quell’omicidio cinico e consapevole.
Le rispondevo che tutte quelle scuse erano problemi nostri, che il bambino non c'entrava niente, che era come se uccidessimo il nostro vicino di casa solo perché abbiamo perso il posto di lavoro, o come se invadessimo la Polonia per vivere più larghi e sentirci più liberi, ma lei non si faceva persuadere. Sovente le dicevo:
- Se non lo vuoi lascialo a me!
Un giorno le scappò di dire che non avrebbe sopportato il pancione ad Agosto, quando tutte le altre ragazze vanno al mare e si mettono in costume a prendere il sole. Forse soltanto allora capii davvero di che pasta era fatta Marta.
Non ci potevo credere. Non ci volevo credere.
Era possibile che fino a quel momento avevo considerato la mia donna, la futura madre dei miei figli, una che era disposta ad ucci-dere il suo bambino pur di mantenere la linea? Ora non avevo alcun dubbio. La prima volta che vidi Marta non mi ero affatto sbagliato. Era talmente vanitosa da far crescere dentro sé stessa quel cinismo utile che le avrebbe consentito di abortire per una cosa così banale come “tenersi in forma”, non perdere la linea.
Era solo una questione di tempi? Di modernità? Di ciò che passa al-la Tv? “Certe donne”, pensavo, “ucciderebbero davvero pur di essere guardate dagli uomini quando camminano per strada”. In che razza di società stavo vivendo? “Se questo è il rapporto”, mi dicevo, “chissà cosa sarebbe disposta a fare pur di salvarsi la vita!”
Durante la mia esistenza sovente mi era capitato di passare attraverso un turbillon di cazzate, dette e fatte, ma che comunque non mi permettevano di scusare, o addirittura trovare normale, una cosa come questa. Che irresponsabile! Che pavida!
Era dunque questa la verità? Marta voleva solo fuggire alle sue responsabilità? Era solo una vigliacca?
Commentare la paura di un individuo di cui si legge sul giornale il suo essere pavido, è come ad un esame scolastico copiare il compito del proprio compagno di banco; quando consegniamo il plagio godiamo del voto senza capirne i motivi; colui che ne capisce i motivi non si rende conto di aver votato un plagio.
Io criticavo la paura e la viltà di Marta senza saperne i motivi; lei, che probabilmente sapeva le ragioni di quel gesto, non capiva perché aveva paura.
Entrambi eravamo vittime incoscienti di una recita a soggetto, di un canovaccio convenzionale. Entrambi avevamo copiato precisi comportamenti di due opposte corporazioni, e mentre lei godeva del risultato di quella sua convenzionalità, del suo plagio, capendone i motivi, io, che i motivi non li capivo, vedevo quel risultato estremamente sproporzionato alla causa; l'autodeter-minazione della donna. E' giusto giudicare “vile” un suicida o è solo un luogo comune? Forse è vero ciò che diceva Kierkegaard, “solo chi muore sa se lo ha fatto per viltà”. Il quel caso, però, la fuga non era un suicidio, ma un duplice omicidio; il mio e quello del bambino.
Ritengo l'aborto un assassinio legalizzato quando è consumato per ragioni valide, e che può essere scusato solo con le motivazioni di una “legittima difesa”, figuratevi quando è fatto per futilità, frivolezze o vanità!
Tutto avrei potuto scusare a Marta, forse perfino il tradimento amoroso, ma non che lei uccidesse nostro figlio per appagare i pruritini del cuore, perché col pancione gli uomini non l'avrebbero più guardata né corteggiata. Mi faceva rabbia pensare che se anche avessi avuto la possibilità di portare queste prove in Tribunale, quella specie d'impiegati comunali avrebbero dato ragione a lei. Non si può obbligare una donna a partorire.
Pensai spesso a chi doveva essere stato. Sì, chi era quel “genio” che aveva dato vita ad una Legge del genere? Mortificando il valore della vita con questa cultura della morte, ogni individuo può con-siderare qualsiasi nefandezza in cui ha qualcosa da guadagnarci come naturale e giustificabile. Non è strano che il mondo sia pieno di pedofili, pedofobi, corrotti, corruttori, ladri, assassini e guerrafondai.
Pensai anche, sorridendo amaramente, al moderno ruolo degli uomini. Anima in pace ragazzi! In queste questioni siamo ormai dei comprimari, delle spalle, dei poveri guitti senza teatro né piazze, senza arte né parte, senza applausi né stipendio. Serviamo solo ad appagare le vanità femminili, a fare regali, a corteggiare e a mantenere quelle donne che, meno fortunate di altre, hanno considerato questa “emancipazione” come qualcosa di poco conveniente.
Mi sentivo perso.
L'amore è un dolore che il rapporto con la persona amata prolunga, e che ogni tanto viene anestetizzato da estasi gioiose, che sono le uniche a rinvigorire il ricordo d'esso non appena tutto finisce. Ebbene, io non avevo, come purtroppo mai avrò nel ricordo di Marta, nemmeno queste.
Marta, che in quei giorni saltava per un nonnulla, sembrava aver deciso definitivamente. Come le altre volte, quando litigavamo per motivi futili, aveva messo su il broncio. Questa volta non m'interessava farla sciogliere da sola, questa volta non m'interessava se mai si fosse sciolta, stava per diventare un'assassina, questo doveva esserle chiaro, e io, che non sono certo un prete, non l'avrei mai perdonata.
Quelli del gruppo mi vedevano giù di morale, ma non mi chiesero mai nulla. Soltanto Maurizio un giorno venne da me e, con l'aria ostentatamente corrucciata, mi disse:
- Gianni, se hai qualche problema io sono qui. Di giorno e di notte.
Lo ringraziai, ma per il momento decisi di non dirgli niente della mia situazione. Non volevo mettere in cattiva luce Marta. Se ci penso mi viene una rabbia.….…….……...... Io non volevo metterla in cattiva luce, e lei, per ricambiare, uccideva mio figlio.
Nemmeno il Conte Ugolino…….…………..
Loro erano euforici. Dicevano che il Gagliardi stava facendo un buon lavoro, una buona promozione. Aveva fatto un contratto con più di duecento radio in tutta Europa. Loro dovevano mandare il nostro disco, alcuni pezzi, almeno cinque volte al giorno e in diverse fasce orarie. Il compenso non era molto alto, ma si sa, le radio non hanno altri introiti che non siano pubblicitari, e anche lì godono poco. Così firmarono, e alla radio, per qualche mese, non si sentivano altro che i nostri pezzi. Del resto ciò che le radio devono fare è mandare musica.....…….....…........
A prima vista quel che più affascinava era il titolo che gli avevamo dato, almeno, così disse il Gagliardi, dandoci, finalmente, un qualche merito che non fosse implicito.
Nel giro di poche settimane ci trovammo primi in Italia e nei primi dieci nelle classifiche di molti paesi europei. Non ci sembrava vero. Anche se io non ero affatto felice in quel periodo, era però assai chiaro che le cose, e noi stessi, stavano cambiando. Ben presto altre priorità sarebbero sopraggiunte prendendo il posto delle precedenti.
Gagliardi cominciò a trattare per i primi contratti. Concerti, inter-viste, serate televisive e radiofoniche. Biografie e curiosità fecero il giro della nazione e del continente su giornali e riviste specializza-te. Tutto questo accadde nel giro di qualche settimana, e finalmente capii come si costruiscono “i geni della musica moderna”. Anche se precedentemente il nostro disco era già conosciuto, quel boom ci cambiò drasticamente la vita.
Mentre gli altri non stavano nella pelle aspettando i risultati di tale successo (notorietà, quattrini, ragazze, insomma, tutti i “favori” elargiti dalla “dèa-cagna”), io ero lontano, distaccato da quella situazione, quasi indifferente.
Erano passati trenta giorni da quando Marta mi aveva detto di voler abortire, ma ancora non l'aveva fatto. Io speravo che questa fosse un'indecisione e tornai a fare pressioni su di lei. Che fossimo famosi era piuttosto chiaro, ma Marta era troppo semplice e ignorante per quantificare in moneta sonante ciò che significava “aver successo”.
Per qualche giorno fui tentato di persuaderla con l'attrattiva del be-nessere, ma poi ci ripensai. Volevo salvare solo il nostro bambino, non la nostra relazione, che, da quando avevo scorto in lei quel vanitoso cinismo, era chiaramente naufragata.
Chissà, forse se si fosse resa conto che la mia vita stava cambiando avrebbe anche rinunciato ad abortire, ma non sono mai stato una cima a far calcoli di sorta. Calcoli che, qualche giorno dopo, capii non sarebbero valsi a salvare la vita di mio figlio.
III.
Ciascuno di noi, quando spera qualcosa, somiglia al naufrago che brama gridar “Terra!” Ma non appena egli ci mette piede subito si fa vincere dalla voglia di “ritornar per mare”.
Quando mi chiedevo se il sacrificio, da parte di Marta, del nostro bambino non fosse in realtà un segno del Destino per far sì ch'io lasciassi quella ragazza, subito mi venivano in mente quelle risibili ed eterne domande tipo: “cosa c'è dietro l'angolo?” o: “è meglio entrare o uscire?” Ma bisogna entrare per uscire, e l'angolo non è altro che lo spazio compreso fra due rette uscenti da un punto.
Volevo salvare il bambino perché rappresentava il nostro amore? Me lo chiedevo spesso, e qualche volta ero anche tentato di rispondermi di sì. Forse avevo solo voglia che tutto rimanesse com'era, che lei continuasse a star con me e a farmi soffrire perché in fondo era questo che volevo, e quel bambino non era che il mezzo per poterlo attuare. Sì, perché in realtà l'amavo. Ma a pensarci bene, però, anche se questo fosse stato vero, io non lo mettevo mai in relazione col bambino. Le avevo chiesto spesso cosa c'era che non andava, sperando in una risposta definitiva, e abbastanza esaustiva, da permettermi di trovare una ragione adeguata che facesse crollare il castello di scuse dentro il quale lei si nascondeva, ma Marta continuava a mentirmi o a stare zitta, facendomi disperare.
Forse era vero ciò di cui la mia coscienza, in segreto, mi accusava. “Si è moralisti quando si è infelici”, scrisse Proust, ma non riusciamo mai a capire l'importanza che certi pregi o certi difetti hanno, di come possono influire attivamente sulla nostra vita e su quella di chi ci sta intorno. Gli orgogli, le ipocrisie, le vanità, le presunzioni e le ambizioni talvolta possono essere considerati da alcuni individui, troppo presi nella contemplazione delle proprie opportunità, dei veri e propri punti fermi. Questi finiscono per confondersi e per ritenere tali difetti come valori veri, come principìi.
Non è da poco tempo che mi sono accorto di quanto la vanità sia, prima di tutto, l'esteriorità di quella presunzione che ci fa credere di avere qualcosa da mostrare, che essa sia presunta virtù fisica o supposto pregio intellettuale. Come mi sono accorto che un certo sano orgoglio ci può permettere di tener fede a noi stessi anche nelle situazioni più scomode, evitandoci meschine figure da “voltagabbana”. E che molte volte è il motivo del nostro pentimento a farci ricadere nella più becera ipocrisia, poiché esso scaturisce in noi quando abbiamo paura dell'estremo giudizio o quando siamo impossibilitati nel continuare a fare il male. Così come l'ambizione può portarci a trascurare chi vogliamo bene o addirittura i nostri principìi.
Può anche darsi che fosse vero il fatto, di cui Marta m'imputava, che io non sopportavo di essere messo a confronto con altri uomini. Ma non è, come non era, un mio particolare vezzo mettermi a fare paragoni e differenze. Siccome io non lo facevo, perché mai avrebbe dovuto farlo lei?
La verità era che Marta si sentiva immune da critiche. La sua vanità scaturiva proprio da questa sua presunzione, da questa specie di stupida albagia, supponenza, che poi lei allargava a tutti i campi e le discipline della vita; arte, lavoro, rapporti personali, amore. Una vanità a tutto tondo, che lei non sapeva mettere da parte un attimo, e che anche quando ci provava spesso se la ritrovava in braccio come un piccolo cagnolino fedele che ha capito qual è l'unica persona che lo può nutrire.
Non era neanche in grado di dare giudizi sugli altri senza tirarsi in ballo. Se per esempio le chiedevo come le sembrava Enzo al basso, lei diceva che non le piaceva granché perché una volta le aveva risposto spocchiosamente. Non portava rancori, ma non sapeva disgiungere un comportamento o una personalità dalle qualità dell'individuo stesso.
Aveva quella vanità, portata sempre dalla presunzione, secondo la quale lei potesse occuparsi criticamente dei difetti altrui senza essere vittima di facili reciprocità. E vi assicuro che nel suo caso sarebbero state davvero facili, perché anche lei, come tutti, era proprietaria di diversi difetti che non riusciva a mascherare. E non parlo solo di quelli fisici.
L’albagia di cui il suo cuore grondava, la “puzzetta sotto il naso”, la supponenza fastidiosa della quale aveva pregni perfino i vestiti, lei le scaricava sugli altri insinuando sufficientemente che il suo modo di essere suscitasse invidia. In realtà era saccente senza averne le possibilità. Marta s'intendeva solo di cose futili, per nulla importanti e trascurabilissime. Era, come scrisse De Maupassant, “un’enciclopedia completa rilegata in pelle d'asino”.
Quando un ragazzo la guardava provocandole quel genere di auto compiacimento proprio delle persone vanitose, lei, cercando di prolungare quel piacere, si comportava in modo da far sì che questo continuasse a fissarla per tutta la sera. Sbattendo gli occhi, facendosi sorprendere a fissarlo, alzandosi per passargli davanti, ridendo forte, parlando ad alta voce gettandogli fugaci, ma in realtà ostentate, occhiate, eccetera. Il lato comico era la sua assoluta certezza che gli altri non s'accorgessero di niente, e che quando io glielo rinfacciavo (dicendole: “Quando hai intenzione di finirla avvisami”) lei mi dava del “visionario”. In realtà se n'erano accorti tutti, e, conscio che chi era seduto con noi al tavolo mi sapesse il suo uomo, l'unico a farci la figura dell'imbecille ero io.
Ma queste “movenze vanitose” erano le più palesi, perché altre ce n'erano, e queste sì facevano parte di quella vanità fastidiosa, quella che vuole ammaliare con la “saggezza del silenzio”. I bronci, innanzitutto. Molto spesso erano solo “addobbi” per far sì che chi le stava vicino finisse per chiederle cosa aveva. O il suo modo di essere compassata, che, era evidente, scadeva nel più becero esibizionismo intellettuale, e costringeva, per la verità solo chi la conosceva scarsamente, a domandarle cosa stava pensando. Che Marta col suo silenzio autoimposto volesse spacciarsi come quella che non si perde in stupide chiacchiere, era piuttosto palese, e questa sua supposta saggezza, dalla quale chi la frequentava non poteva esimersi dal subire, la rendeva assai più antipatica di quanto in realtà non fosse.
Soltanto io ero in grado di vedere queste sfaccettature perché soltanto io la conoscevo bene. Si sa, ci sono svariati tipi di vanità, e ognuno di questi riporta e si rifà alla personalità di chi la sfoggia. C'è la vanità iconastica, fisica, fatta per mostrare la faccia, il corpo, l'immagine, e quell'altra più silenziosa, che implicitamente vorrebbe attirare l'attenzione col mistero, mettendo addosso agli altri la foga di capire come siamo fatti. Dopotutto non è detto che la prima sia la più stupida.
C'è quella saccente, che si autoincensa come un emerito premio Nobel, che si compiace a rimirarsi nello specchio della sua sapienza, e quell'altra che si spaccia per conoscitiva perché ha viaggiato, visto e conosciuto, anche se molto spesso non si capisce se in tutte quelle partenze abbia goduto davvero o se le abbia messe in moto solo per sfoggiarsi raccontandole una volta essere tornata. Non so distinguere quale delle due sia la più fastidiosa.
Con Marta mi succedeva spesso di essere spettatore, assai disincantato, della sua vanità. La vedevo parlare, parlare, ammiccando, muovendo le mani come un disgraziato che per la prima volta in vita sua si trova al centro dell'attenzione, ma ciò che usciva dalla sua bocca io lo avevo sentito centinaia di volte. Era rimasta lì, ferma, immobile, uguale uguale a quando la conobbi. Diceva sempre le stesse cose, e in questo mi ricordava quei risibili personaggi che ogni tanto s'incontrano nelle discoteche, o anche nel locale dove suonavamo, i quali, sapendo di essere solo belli, non sanno far altro che frequentare posti rumorosi, dove non ci si sente a due centimetri di distanza, per evitare di mettersi in discussione.
Sanno di non capirsene di nulla, di essere vacui e interessanti come gli ospiti di un cronicario che ti torturano con la genesi, l'ontologia e l'apologia delle loro malattie, ed evitano di fare discorsi seri e impegnativi proprio perché chi hanno di fronte capirebbe subito di quale pasta sono fatti. Riescono a dire in due minuti tutto quel poco di cui s'interessano, e poi non gli rimane che star zitti oppure ripetersi.
Già allora la pensavo così, e sovente mi sono sorpreso a rimproverarmi, con amarezza, di uscire con Marta perché in fondo anche lei era fatta come quei tizi, e in quel modo la mia conquista perdeva di valore. Certo, chi di pochezza ferisce di pochezza perisce, e la sua pochezza mi feriva profondamente, soprattutto quando lei la sfoderava nei confronti di altri ragazzi, ma a perirne ero ancora io.
Quando partecipavo a quei tavolini di discussioni, sovente me ne andavo con la certezza di aver trascorso una serata inutile e senza scopo. Gli unici discorsi che si facevano, a parte la musica, riguardavano sempre storie d'amore; amori finiti male, un principio di flirt, un po’ di sesso, un mezzo approccio, una occhiata lasciata a metà e altre amenità del genere. Sembrava di essere al “Grande Fratello”, una soap opera recitata male, senza un copione e senza la guida di un regista. In pratica, niente di più ributtante. Sì, proprio così era. Talvolta, ascoltando i discorsi che Marta, i miei compagni e le loro fidanzate facevano, mi pareva di essere entrato di soppiatto dentro una di quelle telenovelas brasiliane, dove attori pagati male recitano da sembrare vittime di candid camera, cioè grottescamente seri, ma così grottescamente da non convincere nessuno.
I pettegolezzi sono tentazioni che solo la Filosofia può mitigare, e asserire che le nauseabonde logorroicità della “compagnia” potessero celare qualcosa di filosofico, è come credere che i balletti visti alla Tv abbiano a che fare con l'Arte.
Ricordo che alcune volte Alessandro ed Enzo litigavano per stabi-lire se la ragazza del tavolino in prima fila, quello di fronte e a pochi metri dal palco, stava guardando uno di loro (e se sì chi) o ascoltando la musica persa nello sguardo e nell'anima. Quando queste sceneggiate accadevano io mi vergognavo al posto loro. E' que-sta l'unica solidarietà che io conosca, arrossire per le miserie altrui.
Quando glielo rinfacciavo loro rispondevano sempre: “Senti chi parla”, sottintendendo che anch'io fossi come loro. Marta allora ne approfittava e, inserendosi, aggiungeva:
- Hai visto? Tutti abbiamo i nostri.
E' difficilissimo ammettere i propri difetti. Non per orgoglio o per qualcos'altro, ma proprio perché è arduo vederli, riconoscerli, accorgersi della loro presenza, altrimenti faremmo di tutto per sba-razzarcene, e infine non li avremmo. Succede ogni volta che quel che gli altri riescono a scorgere in noi non li riteniamo mai i nostri veri difetti. “Io orgoglioso?”, diciamo, “E' qui che ti sbagli! Difetti ne ho anch'io, ma l'orgoglio proprio...…….....……….....”, e invece, magari, è proprio l'orgoglio il nostro più evidente difetto, perché siamo tutti un po' orgogliosi quando si tratta di ammettere che gli altri ci hanno scoperto, che è proprio quello che vedono loro il no-stro difetto più marchiano. Del resto le cose più intime del nostro animo è solo dagli altri che possiamo saperle.
Io non mi sono mai ritenuto un vanitoso, almeno, non troppo. E' vero, qualche volta anch'io lo sono stato, ma la mia vanità non era di quelle fastidiose, frutto della presunzione, ma di quelle altre, risultato di un'irrefrenabile desiderio di piacere. Notavo una ragazza che mi piaceva, e per far colpo su di lei finivo per sfoggiarmi. Certo, anche questa può far male alla vista, ma è più ragionevole della vanità che sfoggiava Marta, perché aveva un obiettivo preciso, per-sonale, non era un principio né fine a sé stessa.
Probabilmente il mio difetto più grande è proprio l'eccessivo orgoglio. L'orgoglio, se preso in piccole dosi, può essere addirittura un pregio, una virtù, ma quando scade nella testardaggine, nel voler avere ragione a tutti i costi, allora diventa fastidioso, noioso, una degenerazione della dignità, e molte volte ti crea il vuoto attorno. La storia con Marta forse mi ha fatto capire di poterne fare a meno, di poter, in certi istanti, rinunciarci senza sentirmi troppo indifeso, volubile.
A volte ho creduto, per pochi momenti, che questo orgoglio, di cui sono abbastanza infagottato, mi rendesse vanitoso alla maniera di Marta. Non so perché, ma certe situazioni possono aiutarmi a spiegarlo.
Talvolta mi trovavo a litigare con Marta perché lei, come al solito, era caduta nel suo vizio di farsi guardare. Io, orgoglioso, cercavo di non farle vedere che me l'ero presa, e allora sfoggiavo la sua stessa vanità per convincerla che se volevo anch'io ero capace di farmi guardare dalle altre donne, che il suo non era un primato. Così diventavo un presuntuoso.
In verità mi piaceva cadere in contraddizione con me stesso. Nessuno si accorgeva di niente (o almeno così mi sembrava) e per un atti-mo provavo quello stesso compiacimento che in quel locale attanagliava un po’ tutti. Quando però tornavo a casa, da solo, nel buio amico della mia camera, ritrovavo me stesso e la determinazione per rimproverarmi quella mia debolezza, e per non ricascarci mi promettevo durezze che il giorno dopo ero ben lontano da volermi infliggere.
Ogni tanto tentavo di dar la colpa di quel mio cedimento a Marta, ma mi accorgevo subito di essere in errore. “Se tutti noi dovessimo far così”, mi dicevo, “nessuno sarà più capace di prendersi le proprie responsabilità”.
Un altro mio difetto era la gelosia. Non ero un Otello, ma qualcosa in questo campo la sapevo. Anche se ero portato, come tutti i gelosi che sono anche orgogliosi, a non far trasparire nulla. Non volevo compromettermi con inutili scenate di gelosia che sarebbero servite solo a prolungare il compiacimento di Marta e ad appagarle compiutamente la sua vanità.
Sorprendentemente, allora, mi scoprivo forte, e riuscivo a nascondere quella gelosia che conquista il cuore degli uomini stupidi. Infatti, anche se a volte serve per mantenere saldo il rapporto, ho sempre creduto che non ci sia difetto più futile della gelosia. Se la nostra donna ci vuol tradire non sarà certo una scenata di gelosia a farla desistere dai suoi propositi. Ciò che di una donna non siamo in grado di cancellare completamente, è la sua convinzione di poterci fare fessi e di riuscire poi a nascondercelo. Questo lo avevo sempre saputo, e Marta rafforzò questa mia convinzione.
La cosa di cui mi convinsi in quel periodo è che i nostri difetti, le nostre meschinità, le nostre pochezze, non possono far diventare una persona il simbolo dell'odio o del male, tutt'al più possono attirare solo facili maldicenze, che presto se ne vanno via così come sono venute, senza successo e senza salario. I nostri piccoli esseri sarebbero diventati, da lì a poco, uno dei gruppi più famosi d'Europa, e questo nonostante le vanità, le gelosie, le presunzioni e l'orgoglio. Nulla ci avrebbe più fermati. Saremmo stati amati da milioni d'individui, di corpi.
Anche se non mi sentivo in grado di festeggiare per questo, quel poco di felicità mi fu portata via pochi giorni dopo dalla persona che più avevo amato; la mia Marta.
IV.
La vanità, sebbene sia sempre esistita, soltanto ultimamente, col nuovo punto di vista sulla bellezza, sulla ricchezza e sulla posi-zione sociale, è diventata pericolosa. Come nel caso della Tecnologia nella Musica o nell'Informazione, anche la vanità ha risentito delle scoperte scientifiche, e, prima fra queste, della Tv e dell'Arte che vi si spaccia.
Non è vero che oggi esistono artisti maggiori e artisti inferiori e non arti maggiori e arti inferiori, e la colpa è della Tecnologia. Mi è capitato spesso di paragonare l'arte musicale alla Letteratura, e mi è venuta fuori la stessa differenza che ci può essere fra l'informazione giornalistica e quella televisiva.
Come per l'informazione giornalistica anche per la Letteratura ci vuole una predisposizione attiva, sia che la si faccia sia che la si goda. Mentre per fare Letteratura bisogna scrivere e per goderne bisogna leggere, e queste sono entrambe azioni attive, per far musica bisogna sì suonarla, ed anche questa è azione attiva, ma per ascoltarla basta essere passivi. La musica, sentendola, la si può anche subire, esattamente come l'informazione televisiva. E' per que-sto motivo che la Letteratura oggi è arte superiore alla musica.
Questo avviene per un fatto puramente naturale, fisico, anatomico. Dando per scontato che tutto viene assorbito, e trattenuto oppure scartato, anche dal cuore, mentre per sentire la musica basta attivare un recettore del cervello, nella parte dei sensi specificatamente l'udito, per leggere devi sincronizzare e assemblare più parti; leggendo si guarda, si diventa narratori per sé stessi, quindi ci si parla, ci si ascolta e ci si capisce. Inoltre la lettura favorisce la capacità d'astrazione, ci fa pensare, cosa che la musica non fa se non in modo onirico. Si sogna, con la musica, e si ricorda. Ma queste due cose si possono fare anche leggendo un libro. Le due arti potevano essere uguali quando ancora non avevamo subìto l'avvento della Tecnologia, ma oggi la Letteratura è arte superiore, perché non la si subisce mai.
Più mi guardavo dentro e più mi riconoscevo “non musicista”. Sebbene la mia passione per la musica non fosse scemata, anzi, aveva probabilmente più vigore di quando ero piccolo, si muoveva però verso quella passività di cui parlo sopra, l'amore nel sentire e non nel suonare. Chissà, forse mi consideravo a tal punto di scarso valore tecnico, che ero portato a lasciare agli altri, ritenuti da me “veri musicisti”, il saper creare emozioni, il saper inventare. Mi sta-vo innamorando talmente tanto della Letteratura che ormai provavo piacere solo a scrivere i testi delle nostre canzoni, a suonarle meno.
Ciononostante il successo discografico arrivò. Di soppiatto, è vero, quasi senza che ce ne accorgessimo, ma quanto bastava per far sì che le nostre anime cominciassero a cambiare. Ricordo che provai perfino imbarazzo per quello stato di presunta onnipotenza che ti viene subito dopo aver sentito pronunciare il tuo nome al telegiornale o ad essere indicato per strada. Io, come molti, pensavo che ad aver successo ci si sentisse un po' come alla festa per il proprio compleanno, quando tutti gli invitati ti fanno dei regali che sovente non pensi neanche di meritare.
La gente (ma anch'io ero così) immagina che chi ha successo facendo arte non ne sia degno. Tale convinzione è radicata perché tutti pensano che chi è diventato miliardario suonando, o scrivendo o dipingendo, non abbia lavorato un'ora in vita sua.
Questo pregiudizio viene fuori dalla mentalità che solo chi suda si è guadagnato da vivere, perché il lavoro che ha svolto è qualcosa di serio, che serve, e non una cosa di cui si può fare a meno, come invece è lo svago, ciò per cui vive l'arte. Del resto se una città è assediata da tutte le parti quello che interessa è se c'è l'acqua potabile o se il panettiere aprirà e avrà del pane da vendere, e non se “L'Autodidatta” de “La Nausea” di Sartre è da considerare un intellettuale oppure no.
In poco tempo ci trovammo, nella più piena incoscienza, conosciuti in gran parte del mondo. Io non sapevo darmi una risposta al nostro successo. Era davvero un merito nostro? Che il merito fosse tutto del Gagliardi non ci volevo credere. Doveva esserci un apprezzamento di fondo, per ciò che avevamo fatto, da parte di chi ora comprava i nostri dischi e veniva a vedere i nostri concerti. Non era possibile che fossimo soltanto il risultato di un lavoro di marketing.
Ora molto mi premeva sapere. Saremmo stati anche noi soggetti a strani mutamenti? Avremmo seguito nei cambiamenti il nostro nuovo ruolo sociale? Forse era presto per saperlo, ma già mi sembrava che qualcuno di noi stesse cambiando. Forse neanche per colpa sua, è vero, ma più ci si presta ad essere conquistati più lo si è. Ero nervoso. Come sarebbe cambiata la mia vita? Sarei diventato come una di quelle rock star tutte auto di lusso, abiti costosi e faccia di merda? E Marta, ora che avevo la possibilità di mantenere sia lei che il bambino, avrebbe perseverato nel suo folle progetto di abortire? Avevo ceduto accennandole qualcosa, ma non mi sembrava di averle fatto una grande impressione.
Tutti questi pensieri, esacerbati sicuramente dal mio nervosismo, mi tenevano sveglio la notte, tanto che quando, il giorno dopo, mi vedevo con gli altri per suonare, spesso mi addormentavo con la chitarra in braccio, come una balia al suo ventesimo allattamento giornaliero.
Un giorno arrivò una telefonata in sala. Era Marta e diceva di volermi parlare, dirmi qualcosa di urgente. Era una settimana circa che non la vedevo, e speravo dovesse comunicarmi la sua rinuncia all'aborto. Ora che ero famoso aveva ancora meno scuse d'accampare.
Mi diede appuntamento sul lungo mare una mezzora dopo. Io, che non avevo la patente e quindi neppure mezzi di locomozione, non mi spiegavo perché le avevo risposto che mi andava bene. Maurizio aveva l'automobile, e mi feci accompagnare da lui. Facemmo tutto il percorso in silenzio. Avevo deciso di confidarmi con lui qualche giorno prima. Era l'unico che sapeva tutto, e forse non disse nulla proprio per questa ragione, per non influenzarmi sull'eventuali decisioni da prendere. Sapeva che Marta era un osso duro, e che difficilmente avrebbe rinunciato a quella che lei chiamava “la mia libertà di scelta”.
Durante quel breve viaggio pensai che l'aborto, da un punto di vista giuridico, è più abominevole della pena di morte, perché se nella sedia elettrica ci si fa accomodare qualcuno di cui quasi sempre si è certi abbia commesso dei reati, nell'aborto ad essere ucciso è in ogni caso un innocente. Quando scendiamo in piazza a far le “veglie” a favore di un condannato texano, do-vremmo pensarci.
Facemmo un paio di curve, e dopo l'ultima me la trovai davanti. Era più di una settimana che non ci vedevamo e, nonostante tutto, lei mi piaceva ancora, ero innamorato. Gli scienziati, i Sociologi, hanno un bel parlare di disordini ossessivi e compulsivi, di serotonina e altre simili astrattezze. La verità è che se l'amore fosse solo un procedimento, una reazione chimica, le coppie, una volta esauritasi questa, non troverebbero tante difficoltà a sfasciarsi. In realtà ci vuole più coraggio per separarsi che per mettersi insieme.
Quando, a distanza di tempo, ripensiamo a come è nato il nostro amore, ci rendiamo conto che tutto è stato casuale, che è stato un gesto tanto involontario quanto ingenuo. Ci siamo fatti coinvolgere quasi inconsapevolmente, e quando il rapporto sta andando a rotoli capiamo che spezzarlo, romperlo definitivamente senza soffrirne, è impossibile. L'amore vero, sincero, fra due persone è pura osmosi. Siamo noi quell'Amore.
Marta, il mio Amore, era vestita normalmente, con una gonna di quelle larghe e una camicetta con un giubbotto sopra. Pareva dovesse andar via da un momento all'altro. Infatti ricordai che si con-ciava in quel modo quando scendeva da casa sua per accompagnarmi a prendere l'autobus. L'unica differenza stava nelle scarpe; invece che le pantofole aveva un paio di sandaletti.
Appena vide l'automobile di Maurizio prese a fissare l'asfalto, a testa china, con le braccia conserte come un insegnante che veglia sugli alunni mentre fanno un compito perché non copino dal compagno di banco.
Scesi dall'auto e dissi a Maurizio che poteva tornare in sala, io me la sarei cavata da solo. Lui fece una smorfia e disse:
- E' una parola! Qui non c'è posto per fare manovra!
Malgrado tutto ero speranzoso. Non credevo che lei avesse il coraggio di fare quel gesto. Per confutare le convinzioni altrui non basta tutta la scolarizzazione del mondo, perché i nostri principìi sono qualcosa di talmente monolitico ai nostri occhi, che chi la pensa diversamente da noi è, per il nostro punto di vista, una sorta di marziano. Tali sicurezze fanno a pugni con la tolleranza, e quando il monolite va in frantumi non è raro smarrire ogni parametro morale e sentirsi persi.
Ciò che è successo alla società.
Mi avvicinai a lei che mi salutò svogliatamente. Poi, fissandola, dissi: “Allora?”
- Sai bene dove sono stata in quest'ultima settimana. – rispose Marta guardando in terra - Sono andata ad abortire.
Fu la Morte. Una morte fisica, completa. Che vigliacca! In quell'istante mi sentii come uno che non viene accettato dalla società per un qualche motivo che la collettività reputa essere una grave pecca. Ciò che mi fece più male fu il sorriso ebete che Marta portava stampato sul viso quando pronunciò quelle parole.
Quello stesso dolore, quella sofferenza, fu presto tramutata da me in pietà. Pietà verso di lei, che, presumibilmente, non si rendeva neanche conto di quel che aveva fatto. Non che non si rendesse conto nel senso stretto del termine, ma che non capisse quanto fosse grave quel suo dar retta a certe convenzioni, a quelle libertà, a quelle emancipazioni che in certi casi sono la fine di tutto. La con-vinzione che aveva nel credere d'aver fatto l'unica cosa possibile me la rendeva priva di vitalità, di voglia di lottare, una bimbetta qualsiasi, senza meriti e senza colpe. L'unica vera colpa era il suo conformismo.
Poverina. Dev'essere bruttissimo non avere più speranze e ridurre la propria vita ad un egoistica rincorsa verso il benessere futile che ti può procurare la vanità.
La fissai per un lungo istante, poi le dissi:
- Che cazzo ridi troia! Hai ammazzato mio figlio!
Dopodiché scappai via. Chiamai Maurizio, che era ancora alle prese con l'automobile tentando di fare manovra per tornare indietro, in sala. Lo raggiunsi, salii in macchina e gli dissi di correre a più non posso, non m'importava dove sarebbe andato, volevo solo allontanarmi da quel posto.
Lo ricordo come se fosse oggi, quel momento. C'era su “Offramp”, di Pat Metheny, e, mentre “Au lait” mi strappava il cuore, io pian-gevo disperatamente. Piangevo perché quello era l'unico sfogo che mi avrebbe permesso di rimanere in libertà, di non finire in galera. O forse peggio.
Quella notte non dormii molto. Sdraiato sul letto ripensavo a Marta e al bambino. Piangendo. Piansi per gran parte della notte. A cosa mi sarebbe servito adesso tutto il successo del mondo? Neanche la musica poteva rincuorarmi dell'ingiustizia subita. Era tutto finito. Il sogno era finito. Presi le foto e iniziai a fissarle. Ci abbracciavamo. Ci baciavamo. Ridiamo, qui. In quest'altra siamo noi due, con gli altri del gruppo in lontananza. Pensai a come era stata cinica, a come mi aveva preso per il culo. Altro che studentessa in Legge all'ultimo esame!
Con la testa appoggiata al cuscino bianco del mio letto evocai il pomeriggio, ma quella scena era una vecchia fotografia che ormai aveva stufato tutti. Ogni cosa era finita. Male. La riguardavo, in quelle foto, e ripensavo di lei ciò che il mio istinto mi aveva imposto di credere quella sera, quando la vidi nel ristorante il giorno del mio compleanno. Un'eterna “Trofimova”.
E' proprio una sporca Tombola, questo mondo. Girare, girare, chiudere gli occhi e soffrire, non curarsi degli altri, voltarsi e scappare, fuggire, lontano dal dolore, amare ma così, a casaccio, aspirare ai sentimenti, nobili, sì, nobili, e poi andare con le prostitute, pagarle, usarle, sublimare rapporti, desiderare, amare ma senza tener conto di chi ci ricambia, fregarsene, delle immagini, sì, inseguirle, bramarle, richiamarle alla memoria, ma senza volerle far proprie, evocarle, nei ricordi, remoti, vicini, e poi adorarle ma tenendole a distanza, per non cadere loro vittime, per non farci ferire.
Asciugo gli occhi. Il Presente. Il Passato. Mi sale un'immagine. Sembra lontana, offuscata, un flash back dai contorni sbiaditi. Mi sforzo e li metto a fuoco. Eccola lì. La vedo, mischiata agli scogli sottostanti, passeggiare sulla schiuma bianca del mare, alzare la testa verso il cielo, bella, candida, vanitosa. E di nuovo. Lei. Marta. Marta che mi fissa dal tavolino del locale. Marta che allunga le braccia per essere stretta forte, come se chiedesse a suo padre di prenderla in braccio. La immagino. Piccola, in un girello, senza denti. E ancora il locale. Sguardi vicini, buoni, speranzosi. Ma è solo un lontano passato, un Tempo che non esiste più, che non posso arrestare. Una caduta di foglie d'Autunno che il vento porta via, che non mi sarà più restituita. E' lo sguardo fuggente di uno sconosciuto, quel passato tremendo, doloroso e stupendo al tempo stesso, che dopo aver distrattamente osservato subito si dimentica.
Perché mentivano tutte queste maledette, queste donne?
Forse il giorno del contratto, a casa mia, fu solo una ultima interpretazione, ma ora il sipario si era chiuso. Sì, chiuso. Definitivamente.
La mia sofferenza era piena, tonda, senza speranza.
Certo, mi sentivo così male non solo per la sorte che era toccata al bambino, ma anche perché l'amavo ancora. Quel pomeriggio era stato una sorta di Armaghedon, la fine di un ciclo, la perdita completa di quel rimasuglio d'ingenuità che il ricordo della mia giovinezza teneva imprigionata nel mio cuore, un momento orrendo, una fine doppia, che si srotola nei suoi titoli di coda, perché nell'uccidere nostro figlio Marta faceva tramontare ogni mia possibilità di riconsiderare i fatti e restare con lei.
Quel giorno persi definitivamente la mia adolescenza.
“Solo ora posso dire di non essermi sbagliato”, mi suggerivo.
Spesso è più conveniente dare ascolto al proprio istinto, alle prime sensazioni, senza stare a farci convincere dai casi, dalle situazioni e dal nostro cervello, che possono spacciarci la Morte come qualcosa di normale, banale perfino.
Non riuscii mai a perdonarmi quella leggerezza.
Ancora oggi, sebbene il dolore è ormai flebile per il tempo trascorso, non ci riesco. Sembra quasi che la principale goduria degli uomini sia farsi catturare dalle mani delle donne ciniche. Non ne voglio fare una questione di sessi (anche perché spiegare un certo discorso di categorie e corporativismi sarebbe, oltre che prolisso, noioso e generalizzante, ciò che non vorrei sembrare), ma la comprimarietà degli uomini in questi casi mi pare quantomai evidente. Ma allora, chi pagherà per queste morti? O bisogna far pagare solo i reati, i crimini commessi contro l'umanità visibile? Se così fosse i rischi non sono risibili. Potremmo iniziare ad interessarci solo a quelle miserie (guerre, morti di fame, malattie, eccetera) che vediamo alla Tv, finendo per provare pietà solo verso quelli per cui “altri” vogliono che proviamo pietà, e, viceversa, facendo passare tutte le altre efferatezze come genocidi di seconda classe, non imputabili a nessuno. Eppure la loro ferocia non è inferiore al sterminio dei pellerossa, all'inquinamento, alle stragi di Milosevic e Saddam Hussein, o a quelle di Mayak.
Sembra incredibile, ma tutto questo succede in nome della libertà e della democrazia.
Per un bimbo mai nato
Perdonaci. Perdonaci il timore di essere papà, di essere mamme, di essere nonne. Perdonaci il “ciucciotto” che non hai succhiato, le mammelle che non ti hanno svezzato. Perdonaci le tutine di spugna, le calzine azzurre, le scarpette. Perdonaci le dita che non hai impugnato, i bavaglini, le pappe che non hai sputato, il seggiolone, il girello. Perdonaci per i passi che non hai potuto fare, per la pioggia che non ti ha bagnato, per le carezze mancate del vento, delle nostre mani, per non aver mai visto il mare. Perdonaci per i baci che non ti abbiamo dato, per la forza delle braccia che non ti hanno stretto. Perdonaci la scarlattina che non hai preso, il morbillo, gli orecchioni. Perdonaci l'aria che non ha gonfiato i tuoi polmoni, il gelo dei ferri chirurgici che ti hanno violentato, il biancore della sala medica che non hai potuto vedere. Perdonaci per i colori sottratti ai tuoi occhi; per il rosso, per il verde, per il blu. Perdonaci per i tuoi dentini che non sono cresciuti, per il “battimanine” che non hai mai fatto. Perdonaci per i giocattoli che non ti abbiamo regalato, per quel primo giorno di scuola in cui non hai potuto piangere. Per le matite, le gomme, gli astucci, i quaderni, gli album da disegno sui quali non hai potuto liberare la tua fantasia. Perdonaci per i libri che non hai letto, per le parole che non hai imparato, per le cartelle pesanti che non hanno provato la tua schiena. Perdonaci per le partite di Calcio che non hai mai giocato, per i gol che non hai segnato. Perdonaci, se non sei potuto cadere dalla tua bicicletta. Perdonaci le cattive compagnie che non ti hanno sviato, gli amici per i quali non hai pianto. Perdonaci la Tv, la realtà virtuale, la realtà. Perdona “L'uomo Nero” che non è mai entrato nella tua stanza. Perdona il tepore delle coperte, il fruscio delle lenzuola, la neve che non ha bussato ai vetri della tua finestra. Perdonaci per l'ingenuità di cui non hai goduto, per le ragazze che non hai amato, baciato, desiderato. Perdonaci il sesso che non hai mai fatto, la paura che non hai provato. Perdonaci l'uomo che non sei diventato. Perdonaci se ti abbiamo privato del diritto di soffrire, di scegliere, di perdere, di morire. Perdonaci il nostro poco coraggio, la paura delle chiacchiere della gente, la vergogna di non essere sposati, di non poterti mantenere. Perdonaci tutto. Perdonaci il bianco e perdonaci il nero, perdonaci il freddo e perdonaci il caldo. Perdonaci per i tramonti mai visti, per le albe mai vissute. Perdona le nuvole, e perdonaci il Sole. Perdonaci le notti, le Lune, le stelle. Perdonaci le ore, i minuti, i secondi. Perdonaci il sacco di plastica nel quale ti sei addormentato, e perdona chi, davanti alla tua piccola bara, non ti ha battezzato. Perdonaci il nostro dolore ipocrita, la nostra emancipazione, la nostra libertà. Perdonaci per i nostri fallimenti, per le battaglie che non abbiamo fatto. Perdonaci il denaro e la nostra frivolezza. Perdonaci la testa all’insù. Perdonaci il potere, il dominio dell'uomo sull'uomo. Perdonaci i conformismi, le convenzioni. Perdonaci, se non siamo capaci di guardare in basso. Perdonaci le nostre felicità, i nostri egoismi, gli opportunismi, i finti altruismi. Perdonaci di essere vili, di essere uomini, di essere vivi. Perdonaci le nostre età adulte, la nostra concretezza, il nostro realismo. Perdonaci la nostra incapacità di sognare. Perdonaci la fiducia nel progresso, nel moderno. Perdonaci, se siamo così futili da bramare il successo. Perdonaci le schiavitù che ci siamo inventati. Perdonaci la politica, la storia, la scuola. Perdonaci per non aver imparato mai niente dalle nostre miserie. Perdonaci il passato per non aver perdonato, e perdonaci anche il presente, perché non perdoniamo. Perdonaci le volte che siamo stati cattivi, e perdonaci anche le volte che non lo siamo stati. Perdonaci la 194, il suo formalismo, la sua freddezza. Perdonaci se non sappiamo più piangere. Perdonaci la nostra faccia. Perdonaci l'ambizione. Perdonaci la Scienza. Perdonaci la Vita e perdonaci la Morte. Perdonaci un Dio ormai dimenticato. Perdonaci il problema che per noi sei stato. Perdonaci i tuoi anni, mai arrivati, mai vissuti, mai passati. Perdonaci i nostri aborti, ormai da tutte le parti. Perdonaci il cinismo, la vanità, l'alienazione. Perdona le mie lacrime su questo pezzo di carta. Perdonaci la nostra mancanza di speranza, e spera tu per noi, che da tempo non ne siamo più capaci. Perdonaci i sorrisi. Perdonaci la poca voglia di lottare, la smania di arrenderci, le nostre sconfitte. Perdona tua madre, che non se l'è sentita di regalarsi un sogno, e perdona tuo padre, che non ha saputo renderlo reale. Perdona il mondo, che senza te ha perso un'occasione, e perdona i suoi abitanti, che perdendo te hanno perso un mondo. Perdona chi crede che la tua morte sia libertà, ma anche chi, pur non credendolo, non l'ha saputa evitare. Perdona tutti i “perdono” del mondo, per i quali verrai presto dimenticato. E infine perdona la Legge, bambino mai nato, nel nome della quale non sei stato perdonato.
Loro erano euforici. Dicevano che il Gagliardi stava facendo un buon lavoro, una buona promozione. Aveva fatto un contratto con più di duecento radio in tutta Europa. Loro dovevano mandare il nostro disco, alcuni pezzi, almeno cinque volte al giorno e in diverse fasce orarie. Il compenso non era molto alto, ma si sa, le radio non hanno altri introiti che non siano pubblicitari, e anche lì godono poco. Così firmarono, e alla radio, per qualche mese, non si sentivano altro che i nostri pezzi. Del resto ciò che le radio devono fare è mandare musica.....…….....…........
A prima vista quel che più affascinava era il titolo che gli avevamo dato, almeno, così disse il Gagliardi, dandoci, finalmente, un qualche merito che non fosse implicito.
Nel giro di poche settimane ci trovammo primi in Italia e nei primi dieci nelle classifiche di molti paesi europei. Non ci sembrava vero. Anche se io non ero affatto felice in quel periodo, era però assai chiaro che le cose, e noi stessi, stavano cambiando. Ben presto altre priorità sarebbero sopraggiunte prendendo il posto delle precedenti.
Gagliardi cominciò a trattare per i primi contratti. Concerti, inter-viste, serate televisive e radiofoniche. Biografie e curiosità fecero il giro della nazione e del continente su giornali e riviste specializza-te. Tutto questo accadde nel giro di qualche settimana, e finalmente capii come si costruiscono “i geni della musica moderna”. Anche se precedentemente il nostro disco era già conosciuto, quel boom ci cambiò drasticamente la vita.
Mentre gli altri non stavano nella pelle aspettando i risultati di tale successo (notorietà, quattrini, ragazze, insomma, tutti i “favori” elargiti dalla “dèa-cagna”), io ero lontano, distaccato da quella situazione, quasi indifferente.
Erano passati trenta giorni da quando Marta mi aveva detto di voler abortire, ma ancora non l'aveva fatto. Io speravo che questa fosse un'indecisione e tornai a fare pressioni su di lei. Che fossimo famosi era piuttosto chiaro, ma Marta era troppo semplice e ignorante per quantificare in moneta sonante ciò che significava “aver successo”.
Per qualche giorno fui tentato di persuaderla con l'attrattiva del be-nessere, ma poi ci ripensai. Volevo salvare solo il nostro bambino, non la nostra relazione, che, da quando avevo scorto in lei quel vanitoso cinismo, era chiaramente naufragata.
Chissà, forse se si fosse resa conto che la mia vita stava cambiando avrebbe anche rinunciato ad abortire, ma non sono mai stato una cima a far calcoli di sorta. Calcoli che, qualche giorno dopo, capii non sarebbero valsi a salvare la vita di mio figlio.
III.
Ciascuno di noi, quando spera qualcosa, somiglia al naufrago che brama gridar “Terra!” Ma non appena egli ci mette piede subito si fa vincere dalla voglia di “ritornar per mare”.
Quando mi chiedevo se il sacrificio, da parte di Marta, del nostro bambino non fosse in realtà un segno del Destino per far sì ch'io lasciassi quella ragazza, subito mi venivano in mente quelle risibili ed eterne domande tipo: “cosa c'è dietro l'angolo?” o: “è meglio entrare o uscire?” Ma bisogna entrare per uscire, e l'angolo non è altro che lo spazio compreso fra due rette uscenti da un punto.
Volevo salvare il bambino perché rappresentava il nostro amore? Me lo chiedevo spesso, e qualche volta ero anche tentato di rispondermi di sì. Forse avevo solo voglia che tutto rimanesse com'era, che lei continuasse a star con me e a farmi soffrire perché in fondo era questo che volevo, e quel bambino non era che il mezzo per poterlo attuare. Sì, perché in realtà l'amavo. Ma a pensarci bene, però, anche se questo fosse stato vero, io non lo mettevo mai in relazione col bambino. Le avevo chiesto spesso cosa c'era che non andava, sperando in una risposta definitiva, e abbastanza esaustiva, da permettermi di trovare una ragione adeguata che facesse crollare il castello di scuse dentro il quale lei si nascondeva, ma Marta continuava a mentirmi o a stare zitta, facendomi disperare.
Forse era vero ciò di cui la mia coscienza, in segreto, mi accusava. “Si è moralisti quando si è infelici”, scrisse Proust, ma non riusciamo mai a capire l'importanza che certi pregi o certi difetti hanno, di come possono influire attivamente sulla nostra vita e su quella di chi ci sta intorno. Gli orgogli, le ipocrisie, le vanità, le presunzioni e le ambizioni talvolta possono essere considerati da alcuni individui, troppo presi nella contemplazione delle proprie opportunità, dei veri e propri punti fermi. Questi finiscono per confondersi e per ritenere tali difetti come valori veri, come principìi.
Non è da poco tempo che mi sono accorto di quanto la vanità sia, prima di tutto, l'esteriorità di quella presunzione che ci fa credere di avere qualcosa da mostrare, che essa sia presunta virtù fisica o supposto pregio intellettuale. Come mi sono accorto che un certo sano orgoglio ci può permettere di tener fede a noi stessi anche nelle situazioni più scomode, evitandoci meschine figure da “voltagabbana”. E che molte volte è il motivo del nostro pentimento a farci ricadere nella più becera ipocrisia, poiché esso scaturisce in noi quando abbiamo paura dell'estremo giudizio o quando siamo impossibilitati nel continuare a fare il male. Così come l'ambizione può portarci a trascurare chi vogliamo bene o addirittura i nostri principìi.
Può anche darsi che fosse vero il fatto, di cui Marta m'imputava, che io non sopportavo di essere messo a confronto con altri uomini. Ma non è, come non era, un mio particolare vezzo mettermi a fare paragoni e differenze. Siccome io non lo facevo, perché mai avrebbe dovuto farlo lei?
La verità era che Marta si sentiva immune da critiche. La sua vanità scaturiva proprio da questa sua presunzione, da questa specie di stupida albagia, supponenza, che poi lei allargava a tutti i campi e le discipline della vita; arte, lavoro, rapporti personali, amore. Una vanità a tutto tondo, che lei non sapeva mettere da parte un attimo, e che anche quando ci provava spesso se la ritrovava in braccio come un piccolo cagnolino fedele che ha capito qual è l'unica persona che lo può nutrire.
Non era neanche in grado di dare giudizi sugli altri senza tirarsi in ballo. Se per esempio le chiedevo come le sembrava Enzo al basso, lei diceva che non le piaceva granché perché una volta le aveva risposto spocchiosamente. Non portava rancori, ma non sapeva disgiungere un comportamento o una personalità dalle qualità dell'individuo stesso.
Aveva quella vanità, portata sempre dalla presunzione, secondo la quale lei potesse occuparsi criticamente dei difetti altrui senza essere vittima di facili reciprocità. E vi assicuro che nel suo caso sarebbero state davvero facili, perché anche lei, come tutti, era proprietaria di diversi difetti che non riusciva a mascherare. E non parlo solo di quelli fisici.
L’albagia di cui il suo cuore grondava, la “puzzetta sotto il naso”, la supponenza fastidiosa della quale aveva pregni perfino i vestiti, lei le scaricava sugli altri insinuando sufficientemente che il suo modo di essere suscitasse invidia. In realtà era saccente senza averne le possibilità. Marta s'intendeva solo di cose futili, per nulla importanti e trascurabilissime. Era, come scrisse De Maupassant, “un’enciclopedia completa rilegata in pelle d'asino”.
Quando un ragazzo la guardava provocandole quel genere di auto compiacimento proprio delle persone vanitose, lei, cercando di prolungare quel piacere, si comportava in modo da far sì che questo continuasse a fissarla per tutta la sera. Sbattendo gli occhi, facendosi sorprendere a fissarlo, alzandosi per passargli davanti, ridendo forte, parlando ad alta voce gettandogli fugaci, ma in realtà ostentate, occhiate, eccetera. Il lato comico era la sua assoluta certezza che gli altri non s'accorgessero di niente, e che quando io glielo rinfacciavo (dicendole: “Quando hai intenzione di finirla avvisami”) lei mi dava del “visionario”. In realtà se n'erano accorti tutti, e, conscio che chi era seduto con noi al tavolo mi sapesse il suo uomo, l'unico a farci la figura dell'imbecille ero io.
Ma queste “movenze vanitose” erano le più palesi, perché altre ce n'erano, e queste sì facevano parte di quella vanità fastidiosa, quella che vuole ammaliare con la “saggezza del silenzio”. I bronci, innanzitutto. Molto spesso erano solo “addobbi” per far sì che chi le stava vicino finisse per chiederle cosa aveva. O il suo modo di essere compassata, che, era evidente, scadeva nel più becero esibizionismo intellettuale, e costringeva, per la verità solo chi la conosceva scarsamente, a domandarle cosa stava pensando. Che Marta col suo silenzio autoimposto volesse spacciarsi come quella che non si perde in stupide chiacchiere, era piuttosto palese, e questa sua supposta saggezza, dalla quale chi la frequentava non poteva esimersi dal subire, la rendeva assai più antipatica di quanto in realtà non fosse.
Soltanto io ero in grado di vedere queste sfaccettature perché soltanto io la conoscevo bene. Si sa, ci sono svariati tipi di vanità, e ognuno di questi riporta e si rifà alla personalità di chi la sfoggia. C'è la vanità iconastica, fisica, fatta per mostrare la faccia, il corpo, l'immagine, e quell'altra più silenziosa, che implicitamente vorrebbe attirare l'attenzione col mistero, mettendo addosso agli altri la foga di capire come siamo fatti. Dopotutto non è detto che la prima sia la più stupida.
C'è quella saccente, che si autoincensa come un emerito premio Nobel, che si compiace a rimirarsi nello specchio della sua sapienza, e quell'altra che si spaccia per conoscitiva perché ha viaggiato, visto e conosciuto, anche se molto spesso non si capisce se in tutte quelle partenze abbia goduto davvero o se le abbia messe in moto solo per sfoggiarsi raccontandole una volta essere tornata. Non so distinguere quale delle due sia la più fastidiosa.
Con Marta mi succedeva spesso di essere spettatore, assai disincantato, della sua vanità. La vedevo parlare, parlare, ammiccando, muovendo le mani come un disgraziato che per la prima volta in vita sua si trova al centro dell'attenzione, ma ciò che usciva dalla sua bocca io lo avevo sentito centinaia di volte. Era rimasta lì, ferma, immobile, uguale uguale a quando la conobbi. Diceva sempre le stesse cose, e in questo mi ricordava quei risibili personaggi che ogni tanto s'incontrano nelle discoteche, o anche nel locale dove suonavamo, i quali, sapendo di essere solo belli, non sanno far altro che frequentare posti rumorosi, dove non ci si sente a due centimetri di distanza, per evitare di mettersi in discussione.
Sanno di non capirsene di nulla, di essere vacui e interessanti come gli ospiti di un cronicario che ti torturano con la genesi, l'ontologia e l'apologia delle loro malattie, ed evitano di fare discorsi seri e impegnativi proprio perché chi hanno di fronte capirebbe subito di quale pasta sono fatti. Riescono a dire in due minuti tutto quel poco di cui s'interessano, e poi non gli rimane che star zitti oppure ripetersi.
Già allora la pensavo così, e sovente mi sono sorpreso a rimproverarmi, con amarezza, di uscire con Marta perché in fondo anche lei era fatta come quei tizi, e in quel modo la mia conquista perdeva di valore. Certo, chi di pochezza ferisce di pochezza perisce, e la sua pochezza mi feriva profondamente, soprattutto quando lei la sfoderava nei confronti di altri ragazzi, ma a perirne ero ancora io.
Quando partecipavo a quei tavolini di discussioni, sovente me ne andavo con la certezza di aver trascorso una serata inutile e senza scopo. Gli unici discorsi che si facevano, a parte la musica, riguardavano sempre storie d'amore; amori finiti male, un principio di flirt, un po’ di sesso, un mezzo approccio, una occhiata lasciata a metà e altre amenità del genere. Sembrava di essere al “Grande Fratello”, una soap opera recitata male, senza un copione e senza la guida di un regista. In pratica, niente di più ributtante. Sì, proprio così era. Talvolta, ascoltando i discorsi che Marta, i miei compagni e le loro fidanzate facevano, mi pareva di essere entrato di soppiatto dentro una di quelle telenovelas brasiliane, dove attori pagati male recitano da sembrare vittime di candid camera, cioè grottescamente seri, ma così grottescamente da non convincere nessuno.
I pettegolezzi sono tentazioni che solo la Filosofia può mitigare, e asserire che le nauseabonde logorroicità della “compagnia” potessero celare qualcosa di filosofico, è come credere che i balletti visti alla Tv abbiano a che fare con l'Arte.
Ricordo che alcune volte Alessandro ed Enzo litigavano per stabi-lire se la ragazza del tavolino in prima fila, quello di fronte e a pochi metri dal palco, stava guardando uno di loro (e se sì chi) o ascoltando la musica persa nello sguardo e nell'anima. Quando queste sceneggiate accadevano io mi vergognavo al posto loro. E' que-sta l'unica solidarietà che io conosca, arrossire per le miserie altrui.
Quando glielo rinfacciavo loro rispondevano sempre: “Senti chi parla”, sottintendendo che anch'io fossi come loro. Marta allora ne approfittava e, inserendosi, aggiungeva:
- Hai visto? Tutti abbiamo i nostri.
E' difficilissimo ammettere i propri difetti. Non per orgoglio o per qualcos'altro, ma proprio perché è arduo vederli, riconoscerli, accorgersi della loro presenza, altrimenti faremmo di tutto per sba-razzarcene, e infine non li avremmo. Succede ogni volta che quel che gli altri riescono a scorgere in noi non li riteniamo mai i nostri veri difetti. “Io orgoglioso?”, diciamo, “E' qui che ti sbagli! Difetti ne ho anch'io, ma l'orgoglio proprio...…….....……….....”, e invece, magari, è proprio l'orgoglio il nostro più evidente difetto, perché siamo tutti un po' orgogliosi quando si tratta di ammettere che gli altri ci hanno scoperto, che è proprio quello che vedono loro il no-stro difetto più marchiano. Del resto le cose più intime del nostro animo è solo dagli altri che possiamo saperle.
Io non mi sono mai ritenuto un vanitoso, almeno, non troppo. E' vero, qualche volta anch'io lo sono stato, ma la mia vanità non era di quelle fastidiose, frutto della presunzione, ma di quelle altre, risultato di un'irrefrenabile desiderio di piacere. Notavo una ragazza che mi piaceva, e per far colpo su di lei finivo per sfoggiarmi. Certo, anche questa può far male alla vista, ma è più ragionevole della vanità che sfoggiava Marta, perché aveva un obiettivo preciso, per-sonale, non era un principio né fine a sé stessa.
Probabilmente il mio difetto più grande è proprio l'eccessivo orgoglio. L'orgoglio, se preso in piccole dosi, può essere addirittura un pregio, una virtù, ma quando scade nella testardaggine, nel voler avere ragione a tutti i costi, allora diventa fastidioso, noioso, una degenerazione della dignità, e molte volte ti crea il vuoto attorno. La storia con Marta forse mi ha fatto capire di poterne fare a meno, di poter, in certi istanti, rinunciarci senza sentirmi troppo indifeso, volubile.
A volte ho creduto, per pochi momenti, che questo orgoglio, di cui sono abbastanza infagottato, mi rendesse vanitoso alla maniera di Marta. Non so perché, ma certe situazioni possono aiutarmi a spiegarlo.
Talvolta mi trovavo a litigare con Marta perché lei, come al solito, era caduta nel suo vizio di farsi guardare. Io, orgoglioso, cercavo di non farle vedere che me l'ero presa, e allora sfoggiavo la sua stessa vanità per convincerla che se volevo anch'io ero capace di farmi guardare dalle altre donne, che il suo non era un primato. Così diventavo un presuntuoso.
In verità mi piaceva cadere in contraddizione con me stesso. Nessuno si accorgeva di niente (o almeno così mi sembrava) e per un atti-mo provavo quello stesso compiacimento che in quel locale attanagliava un po’ tutti. Quando però tornavo a casa, da solo, nel buio amico della mia camera, ritrovavo me stesso e la determinazione per rimproverarmi quella mia debolezza, e per non ricascarci mi promettevo durezze che il giorno dopo ero ben lontano da volermi infliggere.
Ogni tanto tentavo di dar la colpa di quel mio cedimento a Marta, ma mi accorgevo subito di essere in errore. “Se tutti noi dovessimo far così”, mi dicevo, “nessuno sarà più capace di prendersi le proprie responsabilità”.
Un altro mio difetto era la gelosia. Non ero un Otello, ma qualcosa in questo campo la sapevo. Anche se ero portato, come tutti i gelosi che sono anche orgogliosi, a non far trasparire nulla. Non volevo compromettermi con inutili scenate di gelosia che sarebbero servite solo a prolungare il compiacimento di Marta e ad appagarle compiutamente la sua vanità.
Sorprendentemente, allora, mi scoprivo forte, e riuscivo a nascondere quella gelosia che conquista il cuore degli uomini stupidi. Infatti, anche se a volte serve per mantenere saldo il rapporto, ho sempre creduto che non ci sia difetto più futile della gelosia. Se la nostra donna ci vuol tradire non sarà certo una scenata di gelosia a farla desistere dai suoi propositi. Ciò che di una donna non siamo in grado di cancellare completamente, è la sua convinzione di poterci fare fessi e di riuscire poi a nascondercelo. Questo lo avevo sempre saputo, e Marta rafforzò questa mia convinzione.
La cosa di cui mi convinsi in quel periodo è che i nostri difetti, le nostre meschinità, le nostre pochezze, non possono far diventare una persona il simbolo dell'odio o del male, tutt'al più possono attirare solo facili maldicenze, che presto se ne vanno via così come sono venute, senza successo e senza salario. I nostri piccoli esseri sarebbero diventati, da lì a poco, uno dei gruppi più famosi d'Europa, e questo nonostante le vanità, le gelosie, le presunzioni e l'orgoglio. Nulla ci avrebbe più fermati. Saremmo stati amati da milioni d'individui, di corpi.
Anche se non mi sentivo in grado di festeggiare per questo, quel poco di felicità mi fu portata via pochi giorni dopo dalla persona che più avevo amato; la mia Marta.
IV.
La vanità, sebbene sia sempre esistita, soltanto ultimamente, col nuovo punto di vista sulla bellezza, sulla ricchezza e sulla posi-zione sociale, è diventata pericolosa. Come nel caso della Tecnologia nella Musica o nell'Informazione, anche la vanità ha risentito delle scoperte scientifiche, e, prima fra queste, della Tv e dell'Arte che vi si spaccia.
Non è vero che oggi esistono artisti maggiori e artisti inferiori e non arti maggiori e arti inferiori, e la colpa è della Tecnologia. Mi è capitato spesso di paragonare l'arte musicale alla Letteratura, e mi è venuta fuori la stessa differenza che ci può essere fra l'informazione giornalistica e quella televisiva.
Come per l'informazione giornalistica anche per la Letteratura ci vuole una predisposizione attiva, sia che la si faccia sia che la si goda. Mentre per fare Letteratura bisogna scrivere e per goderne bisogna leggere, e queste sono entrambe azioni attive, per far musica bisogna sì suonarla, ed anche questa è azione attiva, ma per ascoltarla basta essere passivi. La musica, sentendola, la si può anche subire, esattamente come l'informazione televisiva. E' per que-sto motivo che la Letteratura oggi è arte superiore alla musica.
Questo avviene per un fatto puramente naturale, fisico, anatomico. Dando per scontato che tutto viene assorbito, e trattenuto oppure scartato, anche dal cuore, mentre per sentire la musica basta attivare un recettore del cervello, nella parte dei sensi specificatamente l'udito, per leggere devi sincronizzare e assemblare più parti; leggendo si guarda, si diventa narratori per sé stessi, quindi ci si parla, ci si ascolta e ci si capisce. Inoltre la lettura favorisce la capacità d'astrazione, ci fa pensare, cosa che la musica non fa se non in modo onirico. Si sogna, con la musica, e si ricorda. Ma queste due cose si possono fare anche leggendo un libro. Le due arti potevano essere uguali quando ancora non avevamo subìto l'avvento della Tecnologia, ma oggi la Letteratura è arte superiore, perché non la si subisce mai.
Più mi guardavo dentro e più mi riconoscevo “non musicista”. Sebbene la mia passione per la musica non fosse scemata, anzi, aveva probabilmente più vigore di quando ero piccolo, si muoveva però verso quella passività di cui parlo sopra, l'amore nel sentire e non nel suonare. Chissà, forse mi consideravo a tal punto di scarso valore tecnico, che ero portato a lasciare agli altri, ritenuti da me “veri musicisti”, il saper creare emozioni, il saper inventare. Mi sta-vo innamorando talmente tanto della Letteratura che ormai provavo piacere solo a scrivere i testi delle nostre canzoni, a suonarle meno.
Ciononostante il successo discografico arrivò. Di soppiatto, è vero, quasi senza che ce ne accorgessimo, ma quanto bastava per far sì che le nostre anime cominciassero a cambiare. Ricordo che provai perfino imbarazzo per quello stato di presunta onnipotenza che ti viene subito dopo aver sentito pronunciare il tuo nome al telegiornale o ad essere indicato per strada. Io, come molti, pensavo che ad aver successo ci si sentisse un po' come alla festa per il proprio compleanno, quando tutti gli invitati ti fanno dei regali che sovente non pensi neanche di meritare.
La gente (ma anch'io ero così) immagina che chi ha successo facendo arte non ne sia degno. Tale convinzione è radicata perché tutti pensano che chi è diventato miliardario suonando, o scrivendo o dipingendo, non abbia lavorato un'ora in vita sua.
Questo pregiudizio viene fuori dalla mentalità che solo chi suda si è guadagnato da vivere, perché il lavoro che ha svolto è qualcosa di serio, che serve, e non una cosa di cui si può fare a meno, come invece è lo svago, ciò per cui vive l'arte. Del resto se una città è assediata da tutte le parti quello che interessa è se c'è l'acqua potabile o se il panettiere aprirà e avrà del pane da vendere, e non se “L'Autodidatta” de “La Nausea” di Sartre è da considerare un intellettuale oppure no.
In poco tempo ci trovammo, nella più piena incoscienza, conosciuti in gran parte del mondo. Io non sapevo darmi una risposta al nostro successo. Era davvero un merito nostro? Che il merito fosse tutto del Gagliardi non ci volevo credere. Doveva esserci un apprezzamento di fondo, per ciò che avevamo fatto, da parte di chi ora comprava i nostri dischi e veniva a vedere i nostri concerti. Non era possibile che fossimo soltanto il risultato di un lavoro di marketing.
Ora molto mi premeva sapere. Saremmo stati anche noi soggetti a strani mutamenti? Avremmo seguito nei cambiamenti il nostro nuovo ruolo sociale? Forse era presto per saperlo, ma già mi sembrava che qualcuno di noi stesse cambiando. Forse neanche per colpa sua, è vero, ma più ci si presta ad essere conquistati più lo si è. Ero nervoso. Come sarebbe cambiata la mia vita? Sarei diventato come una di quelle rock star tutte auto di lusso, abiti costosi e faccia di merda? E Marta, ora che avevo la possibilità di mantenere sia lei che il bambino, avrebbe perseverato nel suo folle progetto di abortire? Avevo ceduto accennandole qualcosa, ma non mi sembrava di averle fatto una grande impressione.
Tutti questi pensieri, esacerbati sicuramente dal mio nervosismo, mi tenevano sveglio la notte, tanto che quando, il giorno dopo, mi vedevo con gli altri per suonare, spesso mi addormentavo con la chitarra in braccio, come una balia al suo ventesimo allattamento giornaliero.
Un giorno arrivò una telefonata in sala. Era Marta e diceva di volermi parlare, dirmi qualcosa di urgente. Era una settimana circa che non la vedevo, e speravo dovesse comunicarmi la sua rinuncia all'aborto. Ora che ero famoso aveva ancora meno scuse d'accampare.
Mi diede appuntamento sul lungo mare una mezzora dopo. Io, che non avevo la patente e quindi neppure mezzi di locomozione, non mi spiegavo perché le avevo risposto che mi andava bene. Maurizio aveva l'automobile, e mi feci accompagnare da lui. Facemmo tutto il percorso in silenzio. Avevo deciso di confidarmi con lui qualche giorno prima. Era l'unico che sapeva tutto, e forse non disse nulla proprio per questa ragione, per non influenzarmi sull'eventuali decisioni da prendere. Sapeva che Marta era un osso duro, e che difficilmente avrebbe rinunciato a quella che lei chiamava “la mia libertà di scelta”.
Durante quel breve viaggio pensai che l'aborto, da un punto di vista giuridico, è più abominevole della pena di morte, perché se nella sedia elettrica ci si fa accomodare qualcuno di cui quasi sempre si è certi abbia commesso dei reati, nell'aborto ad essere ucciso è in ogni caso un innocente. Quando scendiamo in piazza a far le “veglie” a favore di un condannato texano, do-vremmo pensarci.
Facemmo un paio di curve, e dopo l'ultima me la trovai davanti. Era più di una settimana che non ci vedevamo e, nonostante tutto, lei mi piaceva ancora, ero innamorato. Gli scienziati, i Sociologi, hanno un bel parlare di disordini ossessivi e compulsivi, di serotonina e altre simili astrattezze. La verità è che se l'amore fosse solo un procedimento, una reazione chimica, le coppie, una volta esauritasi questa, non troverebbero tante difficoltà a sfasciarsi. In realtà ci vuole più coraggio per separarsi che per mettersi insieme.
Quando, a distanza di tempo, ripensiamo a come è nato il nostro amore, ci rendiamo conto che tutto è stato casuale, che è stato un gesto tanto involontario quanto ingenuo. Ci siamo fatti coinvolgere quasi inconsapevolmente, e quando il rapporto sta andando a rotoli capiamo che spezzarlo, romperlo definitivamente senza soffrirne, è impossibile. L'amore vero, sincero, fra due persone è pura osmosi. Siamo noi quell'Amore.
Marta, il mio Amore, era vestita normalmente, con una gonna di quelle larghe e una camicetta con un giubbotto sopra. Pareva dovesse andar via da un momento all'altro. Infatti ricordai che si con-ciava in quel modo quando scendeva da casa sua per accompagnarmi a prendere l'autobus. L'unica differenza stava nelle scarpe; invece che le pantofole aveva un paio di sandaletti.
Appena vide l'automobile di Maurizio prese a fissare l'asfalto, a testa china, con le braccia conserte come un insegnante che veglia sugli alunni mentre fanno un compito perché non copino dal compagno di banco.
Scesi dall'auto e dissi a Maurizio che poteva tornare in sala, io me la sarei cavata da solo. Lui fece una smorfia e disse:
- E' una parola! Qui non c'è posto per fare manovra!
Malgrado tutto ero speranzoso. Non credevo che lei avesse il coraggio di fare quel gesto. Per confutare le convinzioni altrui non basta tutta la scolarizzazione del mondo, perché i nostri principìi sono qualcosa di talmente monolitico ai nostri occhi, che chi la pensa diversamente da noi è, per il nostro punto di vista, una sorta di marziano. Tali sicurezze fanno a pugni con la tolleranza, e quando il monolite va in frantumi non è raro smarrire ogni parametro morale e sentirsi persi.
Ciò che è successo alla società.
Mi avvicinai a lei che mi salutò svogliatamente. Poi, fissandola, dissi: “Allora?”
- Sai bene dove sono stata in quest'ultima settimana. – rispose Marta guardando in terra - Sono andata ad abortire.
Fu la Morte. Una morte fisica, completa. Che vigliacca! In quell'istante mi sentii come uno che non viene accettato dalla società per un qualche motivo che la collettività reputa essere una grave pecca. Ciò che mi fece più male fu il sorriso ebete che Marta portava stampato sul viso quando pronunciò quelle parole.
Quello stesso dolore, quella sofferenza, fu presto tramutata da me in pietà. Pietà verso di lei, che, presumibilmente, non si rendeva neanche conto di quel che aveva fatto. Non che non si rendesse conto nel senso stretto del termine, ma che non capisse quanto fosse grave quel suo dar retta a certe convenzioni, a quelle libertà, a quelle emancipazioni che in certi casi sono la fine di tutto. La con-vinzione che aveva nel credere d'aver fatto l'unica cosa possibile me la rendeva priva di vitalità, di voglia di lottare, una bimbetta qualsiasi, senza meriti e senza colpe. L'unica vera colpa era il suo conformismo.
Poverina. Dev'essere bruttissimo non avere più speranze e ridurre la propria vita ad un egoistica rincorsa verso il benessere futile che ti può procurare la vanità.
La fissai per un lungo istante, poi le dissi:
- Che cazzo ridi troia! Hai ammazzato mio figlio!
Dopodiché scappai via. Chiamai Maurizio, che era ancora alle prese con l'automobile tentando di fare manovra per tornare indietro, in sala. Lo raggiunsi, salii in macchina e gli dissi di correre a più non posso, non m'importava dove sarebbe andato, volevo solo allontanarmi da quel posto.
Lo ricordo come se fosse oggi, quel momento. C'era su “Offramp”, di Pat Metheny, e, mentre “Au lait” mi strappava il cuore, io pian-gevo disperatamente. Piangevo perché quello era l'unico sfogo che mi avrebbe permesso di rimanere in libertà, di non finire in galera. O forse peggio.
Quella notte non dormii molto. Sdraiato sul letto ripensavo a Marta e al bambino. Piangendo. Piansi per gran parte della notte. A cosa mi sarebbe servito adesso tutto il successo del mondo? Neanche la musica poteva rincuorarmi dell'ingiustizia subita. Era tutto finito. Il sogno era finito. Presi le foto e iniziai a fissarle. Ci abbracciavamo. Ci baciavamo. Ridiamo, qui. In quest'altra siamo noi due, con gli altri del gruppo in lontananza. Pensai a come era stata cinica, a come mi aveva preso per il culo. Altro che studentessa in Legge all'ultimo esame!
Con la testa appoggiata al cuscino bianco del mio letto evocai il pomeriggio, ma quella scena era una vecchia fotografia che ormai aveva stufato tutti. Ogni cosa era finita. Male. La riguardavo, in quelle foto, e ripensavo di lei ciò che il mio istinto mi aveva imposto di credere quella sera, quando la vidi nel ristorante il giorno del mio compleanno. Un'eterna “Trofimova”.
E' proprio una sporca Tombola, questo mondo. Girare, girare, chiudere gli occhi e soffrire, non curarsi degli altri, voltarsi e scappare, fuggire, lontano dal dolore, amare ma così, a casaccio, aspirare ai sentimenti, nobili, sì, nobili, e poi andare con le prostitute, pagarle, usarle, sublimare rapporti, desiderare, amare ma senza tener conto di chi ci ricambia, fregarsene, delle immagini, sì, inseguirle, bramarle, richiamarle alla memoria, ma senza volerle far proprie, evocarle, nei ricordi, remoti, vicini, e poi adorarle ma tenendole a distanza, per non cadere loro vittime, per non farci ferire.
Asciugo gli occhi. Il Presente. Il Passato. Mi sale un'immagine. Sembra lontana, offuscata, un flash back dai contorni sbiaditi. Mi sforzo e li metto a fuoco. Eccola lì. La vedo, mischiata agli scogli sottostanti, passeggiare sulla schiuma bianca del mare, alzare la testa verso il cielo, bella, candida, vanitosa. E di nuovo. Lei. Marta. Marta che mi fissa dal tavolino del locale. Marta che allunga le braccia per essere stretta forte, come se chiedesse a suo padre di prenderla in braccio. La immagino. Piccola, in un girello, senza denti. E ancora il locale. Sguardi vicini, buoni, speranzosi. Ma è solo un lontano passato, un Tempo che non esiste più, che non posso arrestare. Una caduta di foglie d'Autunno che il vento porta via, che non mi sarà più restituita. E' lo sguardo fuggente di uno sconosciuto, quel passato tremendo, doloroso e stupendo al tempo stesso, che dopo aver distrattamente osservato subito si dimentica.
Perché mentivano tutte queste maledette, queste donne?
Forse il giorno del contratto, a casa mia, fu solo una ultima interpretazione, ma ora il sipario si era chiuso. Sì, chiuso. Definitivamente.
La mia sofferenza era piena, tonda, senza speranza.
Certo, mi sentivo così male non solo per la sorte che era toccata al bambino, ma anche perché l'amavo ancora. Quel pomeriggio era stato una sorta di Armaghedon, la fine di un ciclo, la perdita completa di quel rimasuglio d'ingenuità che il ricordo della mia giovinezza teneva imprigionata nel mio cuore, un momento orrendo, una fine doppia, che si srotola nei suoi titoli di coda, perché nell'uccidere nostro figlio Marta faceva tramontare ogni mia possibilità di riconsiderare i fatti e restare con lei.
Quel giorno persi definitivamente la mia adolescenza.
“Solo ora posso dire di non essermi sbagliato”, mi suggerivo.
Spesso è più conveniente dare ascolto al proprio istinto, alle prime sensazioni, senza stare a farci convincere dai casi, dalle situazioni e dal nostro cervello, che possono spacciarci la Morte come qualcosa di normale, banale perfino.
Non riuscii mai a perdonarmi quella leggerezza.
Ancora oggi, sebbene il dolore è ormai flebile per il tempo trascorso, non ci riesco. Sembra quasi che la principale goduria degli uomini sia farsi catturare dalle mani delle donne ciniche. Non ne voglio fare una questione di sessi (anche perché spiegare un certo discorso di categorie e corporativismi sarebbe, oltre che prolisso, noioso e generalizzante, ciò che non vorrei sembrare), ma la comprimarietà degli uomini in questi casi mi pare quantomai evidente. Ma allora, chi pagherà per queste morti? O bisogna far pagare solo i reati, i crimini commessi contro l'umanità visibile? Se così fosse i rischi non sono risibili. Potremmo iniziare ad interessarci solo a quelle miserie (guerre, morti di fame, malattie, eccetera) che vediamo alla Tv, finendo per provare pietà solo verso quelli per cui “altri” vogliono che proviamo pietà, e, viceversa, facendo passare tutte le altre efferatezze come genocidi di seconda classe, non imputabili a nessuno. Eppure la loro ferocia non è inferiore al sterminio dei pellerossa, all'inquinamento, alle stragi di Milosevic e Saddam Hussein, o a quelle di Mayak.
Sembra incredibile, ma tutto questo succede in nome della libertà e della democrazia.
Per un bimbo mai nato
Perdonaci. Perdonaci il timore di essere papà, di essere mamme, di essere nonne. Perdonaci il “ciucciotto” che non hai succhiato, le mammelle che non ti hanno svezzato. Perdonaci le tutine di spugna, le calzine azzurre, le scarpette. Perdonaci le dita che non hai impugnato, i bavaglini, le pappe che non hai sputato, il seggiolone, il girello. Perdonaci per i passi che non hai potuto fare, per la pioggia che non ti ha bagnato, per le carezze mancate del vento, delle nostre mani, per non aver mai visto il mare. Perdonaci per i baci che non ti abbiamo dato, per la forza delle braccia che non ti hanno stretto. Perdonaci la scarlattina che non hai preso, il morbillo, gli orecchioni. Perdonaci l'aria che non ha gonfiato i tuoi polmoni, il gelo dei ferri chirurgici che ti hanno violentato, il biancore della sala medica che non hai potuto vedere. Perdonaci per i colori sottratti ai tuoi occhi; per il rosso, per il verde, per il blu. Perdonaci per i tuoi dentini che non sono cresciuti, per il “battimanine” che non hai mai fatto. Perdonaci per i giocattoli che non ti abbiamo regalato, per quel primo giorno di scuola in cui non hai potuto piangere. Per le matite, le gomme, gli astucci, i quaderni, gli album da disegno sui quali non hai potuto liberare la tua fantasia. Perdonaci per i libri che non hai letto, per le parole che non hai imparato, per le cartelle pesanti che non hanno provato la tua schiena. Perdonaci per le partite di Calcio che non hai mai giocato, per i gol che non hai segnato. Perdonaci, se non sei potuto cadere dalla tua bicicletta. Perdonaci le cattive compagnie che non ti hanno sviato, gli amici per i quali non hai pianto. Perdonaci la Tv, la realtà virtuale, la realtà. Perdona “L'uomo Nero” che non è mai entrato nella tua stanza. Perdona il tepore delle coperte, il fruscio delle lenzuola, la neve che non ha bussato ai vetri della tua finestra. Perdonaci per l'ingenuità di cui non hai goduto, per le ragazze che non hai amato, baciato, desiderato. Perdonaci il sesso che non hai mai fatto, la paura che non hai provato. Perdonaci l'uomo che non sei diventato. Perdonaci se ti abbiamo privato del diritto di soffrire, di scegliere, di perdere, di morire. Perdonaci il nostro poco coraggio, la paura delle chiacchiere della gente, la vergogna di non essere sposati, di non poterti mantenere. Perdonaci tutto. Perdonaci il bianco e perdonaci il nero, perdonaci il freddo e perdonaci il caldo. Perdonaci per i tramonti mai visti, per le albe mai vissute. Perdona le nuvole, e perdonaci il Sole. Perdonaci le notti, le Lune, le stelle. Perdonaci le ore, i minuti, i secondi. Perdonaci il sacco di plastica nel quale ti sei addormentato, e perdona chi, davanti alla tua piccola bara, non ti ha battezzato. Perdonaci il nostro dolore ipocrita, la nostra emancipazione, la nostra libertà. Perdonaci per i nostri fallimenti, per le battaglie che non abbiamo fatto. Perdonaci il denaro e la nostra frivolezza. Perdonaci la testa all’insù. Perdonaci il potere, il dominio dell'uomo sull'uomo. Perdonaci i conformismi, le convenzioni. Perdonaci, se non siamo capaci di guardare in basso. Perdonaci le nostre felicità, i nostri egoismi, gli opportunismi, i finti altruismi. Perdonaci di essere vili, di essere uomini, di essere vivi. Perdonaci le nostre età adulte, la nostra concretezza, il nostro realismo. Perdonaci la nostra incapacità di sognare. Perdonaci la fiducia nel progresso, nel moderno. Perdonaci, se siamo così futili da bramare il successo. Perdonaci le schiavitù che ci siamo inventati. Perdonaci la politica, la storia, la scuola. Perdonaci per non aver imparato mai niente dalle nostre miserie. Perdonaci il passato per non aver perdonato, e perdonaci anche il presente, perché non perdoniamo. Perdonaci le volte che siamo stati cattivi, e perdonaci anche le volte che non lo siamo stati. Perdonaci la 194, il suo formalismo, la sua freddezza. Perdonaci se non sappiamo più piangere. Perdonaci la nostra faccia. Perdonaci l'ambizione. Perdonaci la Scienza. Perdonaci la Vita e perdonaci la Morte. Perdonaci un Dio ormai dimenticato. Perdonaci il problema che per noi sei stato. Perdonaci i tuoi anni, mai arrivati, mai vissuti, mai passati. Perdonaci i nostri aborti, ormai da tutte le parti. Perdonaci il cinismo, la vanità, l'alienazione. Perdona le mie lacrime su questo pezzo di carta. Perdonaci la nostra mancanza di speranza, e spera tu per noi, che da tempo non ne siamo più capaci. Perdonaci i sorrisi. Perdonaci la poca voglia di lottare, la smania di arrenderci, le nostre sconfitte. Perdona tua madre, che non se l'è sentita di regalarsi un sogno, e perdona tuo padre, che non ha saputo renderlo reale. Perdona il mondo, che senza te ha perso un'occasione, e perdona i suoi abitanti, che perdendo te hanno perso un mondo. Perdona chi crede che la tua morte sia libertà, ma anche chi, pur non credendolo, non l'ha saputa evitare. Perdona tutti i “perdono” del mondo, per i quali verrai presto dimenticato. E infine perdona la Legge, bambino mai nato, nel nome della quale non sei stato perdonato.
LA FELICITA’ DEGLI ALTRI
I.
Non dovete credere che Marta fosse una donna cattiva, era solo un individuo comune, uno di quelli con cui abbiamo a che fare tutti i giorni, che vedono il mondo, l'umanità, in maniera piatta, e che sono convinti che ogni cosa esista solo perché ci sono loro da soddisfare.
Non bisogna essere particolarmente meritevoli per avere in vita il privilegio di non arrabattarsi, ci può solo capitare in sorte, e dovremmo prendere tutto così come viene.
Purtroppo, però, non tutti sono capaci di tralasciare quest'evidente fatto. Di questi individui tanti possono apparire cattivi, ma non sono altro che dei superficiali, personaggi che non se la sono mai passata male e non capiscono cosa sia soffrire davvero. I loro dolori non riguardano che le cose futili della vita, e non hanno mai avuto la costrizione di risalire dal fondo.
Su queste persone, più che su altre, può far presa la tentazione di divenir vanitosi, poiché non v'è vanità dove c'è povertà o carenza di mezzi, ma solo dove c'è spensieratezza e ci si può attaccare ai piaceri futili della vita godendone. Per tali individui quello che più conta sono le apparenze, le cose esteriori, e non sono più capaci di tornare indietro quando danno valore supremo alla forma. I contenuti sono qualcosa che non li riguarda, poiché essi non si vedono, e la vita è troppo breve perché ci si perda dietro serietà e cose che non fanno godere nell'immediato.
Un vanitoso, tuttavia, non è mai consapevole del suo godere di nullità. Per la sua superficialità le cose futili di cui gode sono certamente le più importanti, e non è disposto a rinunciarvi anche se vede da vicino il dolore che provoca. Quando un vanitoso gode nell'indossare l'abito appena comprato, il piacere che prova non è tanto nel presentarsi elegante e nel godere d'essere osservato sapendo di stare bene, di avere un bel portamento, ma nel proiettare in un futuro prossimo il compiacimento provato, compiacimento che somiglia molto ad un bel voto preso dopo aver dato un esame, e che, nelle sue fantasie di superficiale, lo innalza ad oggetto di desiderio generale.
Un vanitoso si compiace scarsamente dei motivi per cui ha lavorato per essere guardato, perché la linea immaginaria di demarca-zione che segna il suo “confine d'ambizione” si sposta sempre più avanti, e se in un gruppo egli diventa l'attrazione, il centro gravitazionale dell'attenzione, non se ne compiace che per poco tempo, poiché, come il cacciatore mangia la selvaggina che ha cacciato, il vanitoso brucia la sua conquista in un breve periodo, passato il quale sente il bisogno di conquistare qualcun altro.
Il vanitoso ha la necessità di rinnovare continuamente il proprio compiacimento, e, per gli stessi motivi per cui i mariti si cercano un'amante, perché sanno di piacere alle proprie mogli, questo non può accadere con persone di cui sa già d'essere tenuto in grande considerazione.
Questa superficialità dilagante non poteva che venir fuori in questo tempo, dove l'immagine, come dice una pubblicità, è tutto. In questo mondo ogni cosa si fa per vanità, e non solo rimirarsi allo specchio, ma perfino dichiarare guerra. Il concetto di modernità è un parametro fissato sulla visibilità dell'individuo, tanto che oggi gli uomini che non sono maestri a far denaro sono considerati sempre e comunque dei falliti.
Molti anziani dicono che i giovani non hanno perso i valori, ma hanno dei valori diversi, che gli adulti non riescono a capire. Si sa, quando non ci sono più possibilità fisiche non rimane che la lusinga. In realtà i valori dei giovani d'oggi si appoggiano su due vocaboli, “modernità e progresso”, di cui si è stravolto il significato, finendo per dargliene uno più alto e nobile di ciò ch'essi in effetti hanno.
Capire questo ci fa pensare a quanto gli uomini siano superficiali, tutti presi da sé stessi, e a quanto non si accorgano assolutamente di far convergere il loro modo di vivere su un malinteso, finendo per dare alle cose futili un valore sproporzionato alla causa.
Questo modo di ragionare non è affatto innocuo. Non è raro vedere oggi che le grandi tolleranze, le libertà di scelta, le autodeterminazioni, portino spesso a cospicui egoismi che non hanno ragioni visibili e causano più mali di quelli che si vorrebbero curare.
Marta non era molto diversa dal mondo in cui viveva. Tante volte è quasi impossibile rifiutare il modernismo senza caderne vittima. Chi non è d'accordo si deve adattare e riciclarsi, altrimenti non avrebbe spazio nella società e nelle sue considerazioni. Ma gli altri? Intendo dire, i “normali”, cosa devono fare?
Era l'esatta situazione in cui mi trovavo io. Avevo sbagliato tutto? Stavo diventando una specie di ossimoro? E chi era in grado di dirmelo? di dimostrarmelo?
Se ci fosse stato qualcuno capace di dimostrarmi che stavo sbagliando io ne avrei gioito. Sono sempre stato abbastanza umile da accettare i rimproveri senza offendermi, perché chi si offende per un rimprovero dopo aver sbagliato sbaglia due volte, ma non trovai mai questa sorta di uomo.
Lo sbaglio di Marta stava proprio tutto nell'errata convinzione che il moderno fosse, chissà per quale sorta di ragionamento, sempre e comunque meglio dell'antico, e il “progresso” l'unica risposta possibile ai quesiti posti dall'umanità. Ma nel far questo non era diversa dal mondo. Si crede di volare di continuo, quando si scopre come modificare i cibi geneticamente, una medicina nuova o un modo per velocizzare la comunicazione, ma non si capisce che in realtà più che volare si sta precipitando.
Anche i miei amici del gruppo erano così.
Appena vedevano uno strumento nuovo, quei tipi di tastiere che producono più suoni di quanti ve ne siano all’Inferno, volevano usare sempre quello, e se gli facevi notare che il suono della “dodici corde” era più bello e più universale, loro rispondevano che bisognava saper e dover usare quel che la Tecnologia ci metteva a disposizione.
Ma ciò che ritengo essere le mie pecche non si limitano soltanto a questo “inadattamento alla modernità e al progresso”, ma più a quelle cose passate con Marta che continuo a portarmi dietro come piccole sorelline, anche se la diagnosi precisa mi sfugge. Non so dire se Marta fu soltanto il veicolo per cui i miei difetti, o pecche, o casini, o problemi, o come volete voi, trovarono libero sfogo, o se quegli stessi difetti me li avesse attaccati lei. Si sa, se un individuo continua a frequentare assiduamente una persona, come io vedevo Marta, è quasi impossibile essere immuni dai suoi comportamenti. Anche se non ritengo di essere particolarmente influenzabile, non ho la presunzione di essere per nulla penetrabile, ermetico.
Spesso mi accorgevo che quelli che chiamavo “riflessi condizionati” erano condizionati dal mio rapporto con lei. Mi rendevo conto, per esempio, che certi modi di fare, alcune frasi, modi di dire, molti gesti, non erano propri del mio bagaglio mimico o dialettico. Ma chissà se è proprio così. In genere siamo proclivi a pensare che l'ereditarietà e l'epidemie riguardino solo le stronzate, mai l'intelligenza o la genialità.
Il più delle volte ci convinciamo che le nostre pecche non siano completamente una colpa nostra. Come persone di poco conto crediamo che siano gli altri a portarci a fare certe cose, a costringerci a tirar fuori alcuni comportamenti, e così finiamo per essere poco responsabili.
“Paura del contrappasso”, mi diceva Maurizio quando ne parlavamo. Forse aveva ragione lui, perché ogni giudizio sotto il quale veniamo posti ci fa paura e lo consideriamo un'ingiustizia, qualcosa di troppo grande da sopportare per il male che riteniamo d'aver fatto, e così l'unica via di scampo che ci resta è discolparci accusando gli altri.
Ogni tanto ripenso a Marta, all'aborto, e penso che tutto doveva andare così, che per la mia pecca nel ritenere importante la storia con quella ragazza, per forza di cose, doveva accadere qualcosa di veramente grave, altrimenti non ci saremmo lasciati mai. E chissà se mai ci saremmo lasciati se invece che scappare via fossi rimasto lì a discutere con lei del suo gesto. Quasi sempre è improvvisando che riusciamo a cogliere soluzioni definitive.
Ma anche quando penso a queste cose, solitamente, dopo un paio di minuti mi ricredo, e sono convinto che dare al Destino più responsabilità di quelle che in effetti ha, sia sempre una questione di mancanza di coerenza e serietà. Così faccio nascere dentro di me quel realismo utile che mi convince di quanto tutto dipenda da noi.
Il Destino non c'entra niente, il Destino non esiste.
Credo che se non mi accorsi subito di come Marta era fatta, la responsabilità fu mia e solo mia. Non volevo ammettere a me stesso di essermi sbagliato, forse perché ero innamorato di lei. O probabilmente per una questione di orgoglio.
Che ridere. Siamo talmente orgogliosi che la sofferenza è l'ultimo dei sentimenti che vogliamo mostrare a chi vuol farci soffrire. Così resistiamo, fino a quando ci succede qualcosa di enorme. Così tiriamo avanti, magari fino all'angolo di un palazzo, o, come avevo fatto io, fino all'auto di un amico, e lontano dallo sguardo del nostro vessatore ci sciogliamo dentro quelle lacrime che, appese ai nostri occhi come panni stesi, non vedevano l'ora di potersi liberare.
Allora mi convinco che Marta abortì anche per colpa mia, per la mia incapacità nel persuadere le persone, per la mia poca determinazione nell'impormi. Chissà, forse era la sua presunta forza ad inibirmi.
Oggi si fa un gran parlare di “calo del desiderio” dell'uomo. Questo è vero, ma se succede è perché l'uomo portava in sé l'animo del padre, un animo che nelle intenzioni voleva essere quello del protettore, e vedeva nella donna la possibilità d'innalzarsi a qualcosa di più elevato del semplice ruolo di amante. Se l'uomo desidera sempre meno la donna è perché lei si è fatta in quattro per diventare sempre più forte, ed ha finito per perdere la prerogativa per cui noi l'ama-vamo; la sua debolezza. Oggi le donne non sono più capaci d'essere fragili. E' per tale ragione che capisco gli omosessuali. Le donne ci somigliano a tal punto che quasi non esiste più motivo di scelta. Oggi gli uomini non scappano dalle donne perché ne hanno paura, luogo comune come tanti, ma perché al loro fianco si sentono inutili.
Io avrei voluto proteggerla dal mondo, ciò che Marta invece non desiderava. Sì, perché era convinta di essere lei stessa il mondo. Così scadevo nell'ignavia, nell'acèdia. Il solo pensiero che lei potesse avercela con me per un qualsiasi banale motivo mi faceva venire la smania e l'ansia di appianare tutto, di far la pace, trasformandomi in un ributtante cerchiobottista, un acquiescente senza nerbo né vitalità. E allora, per riconquistarla, per sentirmi amato, per essere felice, mi svendevo. Lei mi comprava immediatamente, perché senza di me la sua vanità non avrebbe avuto alcuna ragion d'essere.
Vanità. Quale uomo, oggi, se ha il coraggio di porsi la domanda “Perché la mia donna sta con me?”, non si accorgerà che ci possono essere mille altre ragioni (quali l'automobile, il conto in Banca, la posizione sociale, la libertà che Egli le concede) che sono distanti dal motivo principale: “Perché mi ama, perché gli piaccio”? Il guaio di noi uomini oggi, è che confondiamo i nostri possedimenti materiali, ciò per cui nove volte su dieci veniamo apprezzati dalle donne, con pregi e virtù delle nostre persone. Che ingenui siamo!
Una volta i matrimoni duravano una vita. Perché? Perché non c'era il divorzio? Perché erano combinati? E allora? Oggi sono “scombinati”! No amici cari, non è per queste ragioni, ma perché dietro al motivo del piacersi e dello stare bene insieme non ce n'erano altri. Una donna si metteva con te, e se voleva ti sposava, perché ti conosceva bene e sapeva di non doversi aspettare altro oltre ciò che eri in grado di darle, sia in meglio che in peggio. Il rapporto era sincero in tutte le sue fasi.
Oggi tutto è cambiato. Gli uomini sono diventati dei cani rognosi che sbavano dietro la “dèa-cagna” del successo perché credono che una volta raggiunto la loro vita sarà più facile, e sono circondati da vere e proprie cagne che si fingono in calore per conquistarli e godere surrettiziamente di quelle celebrità e di quelle ricchezze. Oggi vediamo che le dive del cinema o le starlette televisive non sposano mai un manovale edile, ciò che invece non succede agli uomini, che non guardano mai al conto in Banca o alla posizione della donna che si sposano. Perché le donne lo fanno? Forse perché, data la loro fama, hanno a che fare solo con uomini ricchi e famosi? Per amore? Non fatemi ridere, per favore.
Il successo, il denaro, sono sinonimo di potere, e la donna ricerca il potere per avere certezze assolute. Quasi mai le trova in sé stessa, e allora non le rimane che ricercarle nell'uomo.
Questo ragionamento, che le donne, pur non dichiarandolo apertamente, fanno, è l'esatto con-trario dell'emancipazione e della libertà.
Molte donne, anche sposate, guardano la Tv, e vedendo uomini affascinanti accompagnati da “donne costose”, proiettano le loro fantasie nello schermo per partecipare a quelle cerimonie mondane, abbacando, speranzose, d'essere, un domani, loro stesse quelle “donne costose”. E in questo “delirio onirico senza ritorno” si trascinano dietro i loro uomini, che terrorizzati dall'idea di perderle si fanno in quattro per accontentarle. Quasi mai ci riescono, perché quella vanità non ha confini visibili, e l'appagamento di un desiderio è solo il presupposto per farne nascere uno più grande. Così, per tali deliri che fanno crescere incredibili sollettichìi nel cuore, celati dietro un'altra grande menzogna, quella della libertà, si sfasciano allegramente le coppie, e oggi non è difficile vedere pezzi di famiglie sfasciate che si uniscono ad altri pezzi di famiglie illudendosi di formarne una sola, e dove presto inizieranno licenziosità verso i genitori, frutto di equivoci libertari, rinfacciamenti, gelosie, invidie, vere e proprie battaglie interne senza esclusione di colpi fra figli e figliastri, padri e patrigni, madri e matrigne, e il risultato sarà un più che naturale fallimento. Tutto perché?
Oggi la vanità ha partorito una precarietà che ha invaso ogni strato e disciplina della vita (ed è ritenuta addirittura una cosa giusta), tanto che perfino chiedere spiegazioni è considerato un comportamento stupido, antico, poco moderno.
Insinuate in qualsiasi strampalato cervello che il vostro modo bizzarro di vedere le cose sia originale, nuovo e moderno, e chi era ad un passo dal prendervi per scemi rivaluterà ciò che avete appena detto e si convincerà di avere a che fare con una mente sofisticata e arguta.
Il problema è che questo ragionamento ogni volta viene tacciato di maschilismo, di misoginia, mentre invece è solo un'analisi logica dell'odierna situazione. Naturalmente nulla è genera-lizzabile.
Diciamoci la verità. Oggi gli unici uomini coraggiosi sono quelli che hanno la faccia per dire di “no” alla loro donna quando questa gli chiede un regalo o un po’ più di libertà di movimento. Sono co-loro che non si vergognano di dire pubblicamente che l'omosessualità non è una cosa normale, perché se fossimo tutti “normali” come gli omosessuali il mondo finirebbe domani. Sono coloro che hanno il coraggio di dire che l'aborto è un omicidio, che i principìi fanno a pugni con le tolleranze. Questi, che una volta erano definiti “conformismi”, oggi sono gli unici comportamenti davvero originali, fuori dal coro.
Siamo talmente assuefatti alle stravaganze, che ormai facciamo passare tutti coloro che ancora hanno il coraggio di combatterle come degli “stupidi idioti”. In realtà “quell'idiozia” è solo ragionevo-ezza. Il timore di essere tagliati fuori dal “pensiero vigente” ha prodotto una tolleranza universale che darebbe fastidio anche a Voltaire. Ma gli “anticonformisti di origine statale”, coloro che sono contro tutto e a favore di qualsiasi cosa, non la pensano allo stesso modo.
Se tutto questo credete sia un'esacerbazione del discorso, significa che non avete mai avuto a che fare con una persona fresca di Laurea. Individui che portano faticosamente sulle spalle anni di nozioni, che vorrebbero vedere il loro stile di vita assurto a modello universale, che non riescono a staccarsi da quei tre o quattro parametri di giudizio che hanno assorbito a scuola e che li rende completamente privi di capacità astrattive. In realtà non sanno nulla della vita. Le uniche tre cose che hanno imparato sono come far valere il loro titolo di studio davanti agli altri, come sfoderare quell'anticonformismo piatto e convenzionale che li rende scontati ancor prima di aprire bocca, e come fare soldi alla svelta. Sono loro, gli Anticonformisti di Origine Statale, a far passare quella falsa emancipazione per qualcosa di normale, solo un buon “cambiamento” da tollerare. Del resto il mondo gronda d'ignoranti con la Laurea.
Cristina, una ragazza di Giacomo laureata in Giurisprudenza, leggeva i miei testi e si permetteva di correggerli aggiungendo le congiunzioni in alcuni passi. Non sapeva cos'è un asindeto.
Quante volte mi sono chiesto quale assurdo piacere Marta poteva provare a recitare quella parte nella nostra fottuta storia. Negli ultimi giorni della nostra relazione le dicevo spesso che il suo comportamento mi ricordava quello di Madame de Creçy, la Odette de “Alla ricerca del tempo perduto” di Proust.
All'inizio sembrava smaniosa di passare tutto il suo tempo libero con me, di parlarmi, di baciarmi, di farsi piacere, poi, con una drammatica inversione a “U”, cambiò drasticamente atteggiamento. Divenne isterica, mai disposta a lasciar perdere e rissosa. Forse si era resa conto d'aver sbagliato scelta, che se si fosse buttata su qualcuno dei miei compagni la sua vanità ne avrebbe usufruito me-glio, più compiutamente. O probabilmente fu l'atavica convinzione delle donne, di certe donne, secondo la quale quando un uomo è conquistato lo è una volta per tutte e non serve più dimostrargli nulla.
Ma forse somigliava più a Rachel, la fidanzata-amante di Robert de Saint Loup. E cosa mai avrei dovuto dire io? Marta “allor che Iddio”?
Oggi che posso dire di essermi liberato della presenza silenziosa della vanità che Marta si portava addosso, non solo mi sento meglio, ma anche più pulito, più pulito, intendo dire, coscienziosa-mente, ciò che forse in passato non sono mai stato. E' bizzarro come a volte siano le situazioni peggiori a farci ricrescere l'amore per certi sani principìi.
Dopo l'aborto pensavo di aver chiuso a Marta ogni porta, ma mi sbagliavo. Quando capì il successo che avevamo avuto tornò all'attacco. In maniera subdola e strisciante, ma riprovò ad ammaliarmi.
II.
Subito dopo la nostra rottura immaginavo (e forse speravo) che lei, sebbene in un modo tutto suo, mi amasse ancora, che desiderasse vedermi. Infatti seppi che andava nel locale, che io non frequentavo più, e alcune volte era stata vista perfino fuori dalla sala prove. Così premeditai una puerile vendetta che si risolveva tutta nel privarla della mia presenza. In verità non potevo sapere quanto lei ne soffrisse, perché la presunzione d'infliggere del dolore alla persona amata togliendole il piacere di guardarci si basa, come nel mio caso, sulle passate ammissioni d'amore che lei ci ha fatto, ammissioni che, a quel punto giunti, non sapevo quanto considerare attendibili, giacché se vere fossero state lei non avrebbe buttato tutto all'aria solo per poter continuare ad appagare la sua vanità, il compiacimento di essere guardata dagli altri, desiderata.
Presupposto necessario per infliggere pene d'amore è proprio l'Amore, e io non sapevo quanto ancora Marta mi amasse. Ripagare con la stessa moneta un torto subìto non è sempre garanzia di vendetta compiuta, perché ciò che ferì noi si appoggiava allora sul nostro sentimento, sentimento che non siamo certi ci sia nell'oggetto della nostra rivalsa, e su cui dovrebbe basarsi il dolore che vogliamo infliggere.
Così presi ad evitarla. In un certo senso mi sentivo vincitore, cosa che quando stavo con lei non mi era successa che sporadicamente, solo in certi episodi. Per esempio.
Quando avevamo una discussione e, una volta tanto, ero io spuntarla, era come se lei perdesse dei pezzi, che le cadesse qualcosa di cui io, anche se non capivo cosa, mi accorgevo. In quegli istanti mi appariva come se fosse stata nuda. Mi ero accorto che lei stentava a ritrovare questi pezzi, e che era solita chiudersi in casa per qualche giorno, come se avesse dovuto dare il tempo a quella sorta di “appendici” di rinascere, di ricrescere. I pezzi che perdeva potevano essere la sicurezza come un unghia. Infatti non c'era differenza visibile fra il fisico che mostrava al mondo e le sue caratteristiche intellettuali, tutto era appiattito dalla vanità. Naturalmente soltanto a distanza di tempo mi accorsi di queste sfaccettature.
Un giorno arriva una telefonata a casa mia. La mia colf mi chiama e dice che è per me, “una certa Marta”. Fui tentato di non rispondere, ma poi, vinto da quella curiosità che porta i Ricercatori a testare su sé stessi un vaccino che hanno appena messo a punto, strinsi la cornetta fra le mani e chiesi: “Cosa c'è?”
- Calma, - disse lei - bel modo di rispondere.
- Senti, o parli e mi dici cosa vuoi o metto giù.
Non si agogna mai così tanto di risultare antipatici come verso la persona di cui siamo innamorati e che, pensiamo, non ci ricambia. Ma probabilmente non lo facciamo apposta, è solo un modo di difenderci dalla sua indifferenza. E' proprio la consapevolezza di non riuscire a far breccia nel suo cuore che ci rende antipatici.
- Ho chiamato per dirti che ho della roba tua da ridarti, e che, se non sbaglio, anche tu hai qualcosa che mi appartiene. Volevo anche parlarti, chiederti alcune cose.
- Credo proprio che non abbiamo niente da dirci. – risposi io infastidito dal tono riappacificatore della sua voce.
- Va bene. Ma voglio la mia roba. Possiamo vederci?
- Alle quattro al monumento.
“Al monumento”. Perché le avevo dato appuntamento in quel posto? Era lì che Marta mi aveva detto d'aver abortito mio figlio. Forse, inconsciamente, volevo riportarla nel “luogo del delitto”. O chissà se non volevo riprendere tutto da dove l'avevamo lasciato, come se ancora non fosse accaduto nulla, come se lei fosse ancora incinta.
I luoghi comuni fanno talmente parte di noi, che alcuni individui, raccogliendoli in un unico catalogo Estate-Inverno, li hanno fatti diventare una scienza battezzandoli col nome di “Psicologia”.
Non ebbi neppure il tempo di riattaccare che già mi stavo rimproverando il fatto d'aver ceduto. Ripromettendomi di non farmi ammaliare dalle sue moine, mi vestii e poco dopo ero giù in strada. Facendo quei quattro passi che mi separavano dal luogo dell'appuntamento mi tornarono alla memoria alcune sue critiche sulla nostra musica. Critiche che avevo inteso nascondessero, occultate nel profondo dello stomaco, stupide gelosie e inutili invidie.
Solo quel giorno capii che quelle critiche non erano frutto d'invidia furba, ma di mal celata ignoranza musicale. Marta era una di quelle persone, che la dispensazione nozionistica negropontista nutre a colpi di dischetti e “Malinformatica”, che non sapendo di cosa tu stessi parlando e non avendo il coraggio e la capacità di ammetterlo, cercava di apprenderlo dall'espressione della tua faccia o provando a farti finire le sue frasi che poi lei avrebbe cercato abilmente di accompagnare unendosi alla tua voce, dando vita ad una specie di coro a due, e sottintendendo che voleva dire proprio quello. Perché non riusciva semplicemente ad ammettere: “Di tecnica musicale non me ne capisco?”
Sgambettai velocemente con in mano il sacchetto pieno di quelle cianfrusaglie che lei aveva usato come scusa per rivedermi. Infatti non avevo nulla di così importante che le appartenesse. Misi dentro quel sacchetto anche alcuni dei suoi regali, futili oggetti che, secondo il suo strampalato cervello, avrebbero dovuto dimostrarmi tutto il suo amore, ma che, in quanto oggetti, erano affettuosi esattamente come la mia lavatrice o il mio tagliacarte.
Sono sempre stato convinto che di modi per tradire grondi il mondo. Basta saper scegliere. La rabbia che proviamo quando la nostra donna ci tradisce non ha come spunto il tradimento in sé, ma più un corollario scenografico che abbiamo stampato nella nostra mente, e, in quell'allestimento, il tempo che abbiamo impiegato per far sì che quella donna diventasse “la nostra donna”. Vedere che tutti quegli sforzi fatti sono stati vani ci preclude il raggiungimento di ogni ragionevolezza. Ci sentiamo persi, presi in giro. Da qui ne può scaturire una pericolosa voglia di rivalsa verso le donne in genere che ci trasforma in stupidi maschilisti fuori luogo. Ma non è tanto vero che “chi disprezza compra”, quanto che chi ora odia in verità è perché ha amato sperare ed è stato deluso.
Le pagine scombinate della nostra vita ci pongono dinanzi doman-de angosciose; cosa deve fare un individuo perché la sua vita abbia quella tranquillità a cui Egli aspira? Cosa deve fare per tenere saldo il filo sottile che lega come un pacco unico tutto ciò che ha costruito? Cosa deve fare perché la sua donna sia felice per ciò che lui può regalarle? Cosa deve fare per essere sicuro di essere amato, per avere la certezza che la sua donna non lo tradisca, incredibilmente, solo per vanità?
Io non volevo per fidanzata una dèa o una regina, ma una donna sincera, che magari mi odiasse, se solo l'avessi meritato, una donna onesta, che oggi può sembrare addirittura originale, una donna che prima di abortire si chiedesse, perfino trovandolo convenzionalmente bizzarro, per quale motivo non poteva restarmi fedele.
E’ a questo punto che i miei principìi vacillano. Di tanto in tanto, infatti, mi domando se per caso non sia io a voler credere a tutti i costi d’essere dalla parte della ragione, come un demente, un integralista. La mia certezza d’aver fatto tutto il possibile mi mette in un stato di presunta onnipotenza intellettuale che mi priva della ragionevolezza. Do per scontato che la ragione sia dalla mia, e che agli altri non rimanga che da dividersi il torto. Ma quanto è vero questo? Non lo so più.
Se tutti noi, uomini e donne, riuscissimo ad amare in modo per-fetto, se ne fossimo capaci, non sentiremmo più la necessità di allontanarci da casa. Tutto ciò che ci serve è lì! Il guaio è che oggi non basta più difenderlo con l'amore, verso la propria donna, verso i propri figli, verso i propri principìi, verso la propria casa, con l'amore per la verità, per la sincerità. Dovremmo cercare qualcosa d'altro, magari non così frammentario, magari non così provvisorio. Ecco, forse una fedeltà più propria, personale, completa, meglio se più verso noi stessi che verso il mondo, ci renderebbe meno sofferenti e più forti.
Anche davanti alla morte.
Sono un paranoico? Un pauroso aggrappato con le unghia e con i denti ai miei pezzetti bruciati? Forse. O forse sono solo realista.
La felicità che ogni persona ricerca non è che un miraggio, ma un miraggio a tal punto reale che ci sprona a considerare tutta quella “spedizione” come un normale lavoro di assemblaggio delle nostre possibilità. La verità, purtroppo, è che riusciamo a confutare solo la felicità degli altri, mai la nostra, perché ogni obiettivo raggiunto si trasforma immediatamente in un trampolino di lancio verso qualcosa in più, e la meta che abbiamo occupato e che un giorno non lontano agognammo conquistare, subito viene da noi scordata, perfino nei nostri desideri, perfino nelle nostre speranze.
Pare proprio che ai nostri occhi solo gli altri possano raggiungere la felicità, mentre la nostra si muta continuamente da obiettivo a punto di partenza per nuove conquiste.
La vidi da lontano, e spigliatamente mi avvicinai. Marta mi guardò. Anch'io la guardai, facendole capire di non temerla. Ci fissammo per alcuni secondi, che parevano durare ore, senza dire una parola. Sembravamo la vittima davanti al suo carnefice. All'improvviso capii il motivo di quel mio fissarla; volevo imprimermi nella mente la faccia di colei che mi aveva privato della responsabilità di essere padre.
Ad un certo punto allungò un braccio e mi toccò una mano. Mi sfiorò con una tale leggerezza che mi parve addirittura esagerata, quasi avesse paura di farmi ancora del male, e con quell'umiltà che si riscontra in certi moribondi che, rendendosi conto nel momento supremo della morte di essere stati dei peccatori, chiedono perdono al loro Dio col sacro timore d'infastidirlo.
- Perché è successo tutto questo? - disse piano, quasi sottovoce, con gli occhi che, staccati dal mio sguardo, adesso fissavano l'asfalto - Perché siamo arrivati a tanto? Noi ci amavamo!
Vidi in lei il rimorso e non risposi. Non avevo il coraggio di parlarle. Forse perché mi ritenevo scarsamente dotato nella proprietà del linguaggio e avevo paura di riaprire quel contenzioso senza la garanzia di non soccombere. O forse per un dolore troppo grande da sopportare. Subito le lacrime mi riempirono gli occhi, e mi sentii un idiota.
Essendo sincero devo ammettere che ero ancora profondamente in-namorato di quella donna, ma avevo sempre quell'inclinazione a pensare al peggio propria di coloro che si sentono vittime senza rimedio. Come se qualche misterioso sacerdote di antiche religioni arcaiche mi avesse scelto per il prossimo sacrificio al Dio della Fortuna, e aspettasse solo quel gesto del destino, gesto che doveva venire da me, per sgozzarmi e mettermi sull'altare, parte di un rito propiziatorio inutile e senza senso.
Certo, mi resi conto di amarla ancora (sei mesi sono pochi anche per chi, come me, crede di avere subìto un indicibile torto), ma non riconobbi di che genere di amore si trattava, se di quel tipo di amore che non so oppure di vero amore. Forse avevo trasformato quel sentimento in pietà, l'ultima ragione per cui potevo mettermi con una donna. Istintivamente supponevo di compiangerla troppo per essere sicuro che il sentimento che ancora provavo fosse quell’amore profondo di cui avevo sofferto e goduto, per cui avevo urlato e taciuto, che avevo protetto e infine respinto.
Non so dire se in quell'incontro fui davvero io. Sentivo una parte di me che, affogata nella speranza, voleva cedere, e un'altra, ch'io avevo ritenuto essere il mio vero animo, che non voleva saperne. “Il cuore è ingannevole”, dice la Bibbia. Probabilmente era proprio lui a voler ricominciare tutto da capo, mentre il mio cervello, che ripensava al fatto di aver davanti a sé ciò che lui giudicava un'assassina, stava maltrattando sia il mio cuore che il mio corpo. Avevo un conflitto interno che, credo, si vedeva anche da fuori.
M'imposi di non dar retta al mio cuore che bramava cedere. Così, dopo aver fuggito la sua mano con un gesto stizzito del braccio, le porsi la borsa con la sua roba ansioso di sbrigare quell'ultima formalità. Rinsavito, mi convinsi che l'ultima cosa a cui tenevo era riprendere i contatti con quella donna.
Me ne andai con indifferenza, lasciandola lì a masticare stancamente l’angosciosa domanda se in tutto quel tempo fosse stata lei, conquistandomi, a regalarmi un po’ di sé, o se, inconsapevolmen-te, piuttosto non fui io a sottrarle un pizzico della sua persona negandole, però, di godere della mia.
No, non mi voltai a guardarla, mentre triste come Pirro me ne andavo lasciandola ai suoi più che giustificati rimorsi. Anche se era piuttosto palese che ero uscito vincitore da quell'incontro, il mio cuore, insieme al mio corpo, sembravano non essersene accorti. Ma poi, camminando per diverse ore, in parecchie direzioni diverse, e passando attraverso stati d'animo assai diversi fra loro, non mi sentii dispiaciuto per ciò che avevo fatto, anzi. Anche se la mia faccia non mostrava d'essere felice, le mie gambe mi sussurravano di non stare affatto male, il mio cuore era già altrove, ben lontano dal voler tornare indietro, e il mio cervello pensava a ciò che avrei fatto il giorno dopo.
Anche se sapevo perfettamente di non poter definitivamente chiudere la partita con Marta, più che altro col ricordo di quella relazione, ero comunque sicuro di essermela lasciata alla spalle. Forse per la prima volta mi sentii veramente libero da lei, dai suoi giochetti, dalla sua furba vanità e dalla sua fittizia onestà. Tutto mi venne in mente nei giorni che seguirono, tutto tranne il suo viso, i suoi sguardi, la sua camminata da giurisprudentessa, la sua frivolezza, il suo voler avere l'ultima parola su tutto. Non ripensai più al suo corpo, al suo modo di far l'amore, alla sua ostentata disinibizione e al suo voler avere sempre ragione. Forse soltanto quell'ultimo in-contro riuscì a portarmi via il suo più piccolo ricordo, a rinfrancarmi dall'idea che era stata proprio lei a fare quel che aveva fatto, a non farmi più rimpiangere l'odore della sua pelle, dei suoi capelli, del letto quando si alzava per rivestirsi, del suo modo di parlare macchinoso, dalla sua risata volutamente forte, studiata per attirare l'attenzione. Non m'importava più niente. Se mi avessero detto che era finita sotto un camion avrei risposto: “Ma chi?”
Solo quel giorno riuscii a vederla come in realtà era; una innocua farfallina che a furia di svolazzare di fiore in fiore finisce per annoiarti.
Talvolta mi piaceva pensare a cos'era scampato quel povero bambino non nascendo. Era solo un meschino palliativo, ma riusciva a convincermi quanto bene avessi fatto a tagliare tutti i ponti con lei. “Incredibile”, odiavo ripetermi quando, da solo, nella mia nuvoletta semi vacua di pensieri, mi tornavano in mente i contorni offuscati di quella storia, “uccidere una persona per mantenere la linea e poter andare al mare”.
Ripensavo spesso che tutto quello che era successo era sì normale per la Legge, ma anche uno dei pilastri su cui si fonda il nostro amato modello di libertà e democrazia.
“Where do we go from here?”
C'erano cose di cui, nonostante tutto quello che mi era successo, avevo perso il filo, e per questo non ne capivo i motivi. Come si è arrivati al punto di considerare l'uomo un estraneo per quanto riguarda le questioni di parto e di gestazione?
Non riuscivo a ricostruire il percorso di certe decisioni, prima di tutto prese dagli stessi uomini. Come si è arrivati a legalizzare l'aborto? Perché si è istituzionalizzato col pretesto che “tanto le donne lo facevano ugualmente rischiando la vita e arricchendo le mammane”? E noi uomini, come eravamo entrati nel ruolo di comprimari? Come potevamo uscirne? Tutto mi sembrava così illogico. Avevo forse perso qualche passaggio? No, ripensandoci mi pareva ormai impossibile un ravvedimento strada facendo. Quante donne abortiscono senza il consenso del loro uomo o, comunque, del padre del bambino? Eppure tali comportamenti sono considerati “diritti ed emancipazione”. E' così che siamo diventati un popolo di rincoglioniti. Di chi è il “merito”?
Ormai non lo ricordo più.
Che ogni cosa avesse avuto inizio con Olimpia de Gouges nel 1789 mi pare inverosimile. E quelle suffragette avevano cominciato tutto con l'intenzione di fare una strage d'infanti? Non ci credo. Non ci credo, è il pensiero moderno che distorce le cose! Quelle suffragette, e nel ventesimo secolo il Movimento inglese per i Diritti della Donna, si battevano per la parità di diritti fra i quali non c'era anche quello di uccidere.
Ma tutto è cambiato ormai, tutto è distorto.
L'aborto non può essere un “diritto” semplicemente perché, come disse Baldassarre, Presidente della Corte Costituzionale, “la Costituzione difende e privilegia il diritto alla vita, e l'autodeter-minazione della donna non può essere un diritto maggiore, o anche solo pari, a quello della vita”.
Forse quello che più impera oggi è una grande confusione. Una grande confusione che porta gli individui a distorcere ciò che sentono e quello che vivono, manipolando il pensiero delle masse che non aspettano altro che sentire qualcosa di nuovo, anche se poi così nuovo non è. Una grande mistificazione, ecco cos'è tutto. Una enorme mistificazione che ingigantisce e altera i significati delle cose, così che siamo portati a credere che le nostre priorità siano le sole, le uniche e più importanti faccende da sbrigare.
Ma non è così che si vincono le guerre.
III.
L'amore è amore, non ci si deve aspettare nulla in cambio. E questo tanto più vale per quelli che reputiamo nostri amici. Il valore che siamo abituati a dare alle persone è direttamente proporzionato all’interesse che queste suscitano in noi. Non è un caso che quelli con cui andiamo a vedere concerti, mostre, film e commedie teatrali siano di solito anche i nostri amici consueti. I gusti sono l'essenza dei rapporti umani. Sono andato pochissime volte in discoteca, e non ho amici ai quali piace andarvi, credete sia un caso? No, è un fatto consequenziale a ciò che penso e ai gusti che ho.
L'affetto che proviamo verso un amico è un sentimento mobile; la sua simpatia ce lo fa amare, il suo successo ci rende partecipi, la sua dolcezza ce lo indebolisce, rendendolo caro, intimo e sacro co-me la nostra faccia. Dentro questa mobilità ci sono due punti fissi; la reciproca considerazione, che a seconda dei casi ce lo innalza o ce lo affonda, e l'individuale capacità di perdonare. Nella scarsità di queste due cose l'amico diventa un conoscente, ma con l'abbondanza l'amicizia è valore più alto e possente del sentimento che proviamo verso una donna. Essa è compassionevole come una madre, indulgente come un padre, lusinghiera come un complimento, vivace come un bambino, bella come un'opera d'arte, commovente come un parto, naturale come un albero, eterna come Dio. Forte come la Morte.
Due anni dopo che Marta abortì e che ci lasciammo, accadde una di quelle disgrazie che meno si augurano perfino a chi ci vuole male; la perdita di un amico.
Maurizio se ne andò. Così, da un giorno all'altro, senza avvisare nessuno e senza farsi compiangere. Lentamente ma in modo occulto ci lasciò costringendoci a porci quelle domande che riempiono la testa delle persone, purtroppo, solo nei casi di lutto disperato. Chissà, forse sono io a compiangerlo più di quanto esso stesso desiderasse. O forse i miei sono solo rimpianti.
Quando, coi ricordi, rievochiamo i dolori e le sofferenze di una persona che abbiamo amato e che ha abbandonato questo mondo, la nostra pietà, unita al nostro amore per quella persona e alla nostra impotenza, li esalta esagerandoli a dismisura.
Purtroppo è solo nei ricordi che riusciamo a compiangere appieno, così come riusciamo ad amare o ad odiare, dando tutto noi stessi, perché siamo sciolti da quella mancanza d'impaccio che era proprio la vita del moribondo, ancora piena di baldanza e testimone (la quale, non avendolo ancora lasciato, c'imponeva rispetto e un certo timor reverenziale), a bloccarci. Nei ricordi possiamo avvicinarci a quello sfasciamento di sofferenza e guardarlo negli occhi. Non c'è più la paura, data da quell'ingombrante imbarazzo, di cadere nell'irrispettosità, non c'è bisogno di cautele, la discrezione non serve più a nessuno, né a noi né a lui né agli altri.
Aspettare la morte altrui è come attendere quelle sentenze che ci riguardano da vicino, verso le quali, una volta che tutto è finito, malgrado siamo stati condannati, non proviamo più alcun timore, solo rassegnazione.
Ma non è del tutto vero che se ne andò senza avvisare nessuno. La vita, e questo saltava agli occhi, lo aveva lasciato molto tempo prima della sua dipartita terrena e carnale.
Me ne accorsi perché da qualche tempo era cambiato. Ultimamente aveva perso quel brio che lo caratterizzava. Era diventato soltanto l'ombra futile del ragazzo gioioso e pieno di vita che cono-scevo fin dall'infanzia. Non aveva più interessi. Dire che era diventato un cacciaballe è usare un eufemismo. Negli ultimi tempi Maurizio non avrebbe detto la verità neppure sotto l'effetto del Pento-thal. I suoi occhi trasmettevano tristezza. Le sue labbra, da un po’ di tempo pallidamente viola, tremavano come se fosse stato sempre sul punto di dire qualcosa. Il suo fisico era diventato malinconicamente ossuto, e quelle spalle curve sembravano l'anticamera dell'obitorio.
Ma non c'è molta apologia da fare. Ognuno di noi si cerca il suo modo di morire come si cerca quello di vivere, e anche se io arrivai a piangere per lui quando lui, invece, si sforzava di sorri-dere, forse anche il segreto della mia vita è tutto qua.
Anche il suo comportamento era mutato. Non era più capace di dire in faccia alla gente quel che di loro pensava. Forse credeva che un giorno avrebbe potuto avere bisogno anche di quelli che non gli erano mai stati particolarmente simpatici. Era sempre pronto ad appianare i contrasti, ora. Non che questo sia in ogni caso un male, ma non era il genere di comportamento che mi sarei aspettato da lui, ecco.
Da Alessandro l'avrei anche capito, perché nulla era più distante dalla sua testa che non mostrarsi tollerante e comprensivo in ogni momento. E' vero, anche lui, su certi argomenti, talvolta s'induriva. Quando questo succedeva io gli dicevo:
- Sai cos'è che mi fa sorridere? Che questo tipo di principìi vengano proprio da una personalità squinternata come la tua.
Allora Alessandro mi guardava, stupidamente fiero, con l'aria di chi ha capito che gli si stava facendo un complimento.
Maurizio aveva preso a bucarsi. Si sa, in certe ristrettezze, in certi giri di vite, non ci si entra sempre perché uno si rende conto di avere dei problemi irrisolvibili o, facendo chissà quale arguto ragionamento, per rivalsa sulla società. A lui andava tutto abbastanza bene, non aveva bisogno di granché. Ma quel che ignora lo spettatore a volte può essere ignorato anche dall'attore, anche se per motivi diversi. La sua morte mi sembrava così illogica. Come mi pareva illogico e inimmaginabile l'eventuale motivo che aveva avuto per entrare a far parte di quel mondo, la tossicodipendenza.
Ricordo che due mesi prima di morire, dopo aver suonato in sala, mi aveva chiesto se l'accompagnavo a comprare della pittura. Voleva ridipingere il suo appartamento. Quando gli chiesi perché non lo dava da pitturare a qualcuno del mestiere, lui rispose:
- Mah, non so cosa fare. E poi dar la pittura mi diverte.
Ma non era così. Negli ultimi tempi Maurizio veniva da me e mi chiedeva dei soldi. Sebbene guadagnassimo più o meno le stesse cifre lui era sempre miscio come l'ultimo dei pezzenti. Ora so perché, ma prima mi arrabbiavo parecchio anche per questo fatto. Gli davo sempre qualcosa, prestiti a cui lui non ha mai fatto fronte, soldi che non mi ha mai restituito, ma io ero ben felice di aiutarlo.
Quando seppi di cosa soffriva Maurizio prima che dispiaciuto rimasi sorpreso. Non lo facevo un tipo da infognarsi con l'eroina, anche se tutto cambia, se tutto è in eterno movimento.
Cercai di aiutarlo a salvarsi, ma lui prendeva tutto alla leggera. Diceva che non aveva bisogno di nessuno perché ne sarebbe uscito come e quando voleva. Io allora gli chiedevo quando lo avesse voluto, e lui rispondeva:
- Prima o poi. Ora di smettere non ne ho voglia, non ne sento la necessità. E poi se smetto cosa faccio?
Quando mi rispondeva così mi rendevo conto che stava per fare una brutta fine. Del resto nessuno avrebbe potuto farci nulla. La tossicodipendenza è un “affare” troppo personale. Se Maurizio aveva scelto l'eroina per suicidarsi, noi, sicuramente, non potevamo farci niente. Soltanto lui poteva decidere di uscirne, così come aveva deciso di entrarci.
Il giorno in cui arrivò la notizia che Maurizio era stato ricoverato all'ospedale eravamo in sala prove a suonare. Buttati gli strumenti in un angolo corremmo subito al suo capezzale.
Arrivammo che lo avevano appena portato in reparto. Non capivo perché. “Se era grave sarà stato da operare immediatamente!”, mi dissi. Ci vietarono di entrare nella sua stanza, abbandonandoci in corridoio a divorare le nostre ansie.
Dopo una decina di minuti vidi arrivare, dal fondo del corridoio, uno stuolo di persone. Era un gruppo compatto. Sembravano hooligans in trasferta. Vidi i loro camici bianchi che, man mano che si avvicinavano, le luci del corridoio rendevano addirittura abbaglianti. Nel centro, davanti a tutti, camminava il Primario. Il suo passo era veloce, stizzito, a scatti. Guardava diritto dinanzi a sé e non aveva l'aria di voler dare confidenza ad alcuno. I suoi collaboratori, Dottori, Dottoresse e Capo Sala, lo accerchiavano facendogli da corollario come i petali di un fiore. Faticavano a tenere il suo passo, arrancavano, restavano un po' indietro, poi lo raggiungevano di nuovo, discutendo con lui parlandogli ossequiosamente, quasi chiedendone il permesso, seguendone, lusingatori di mestiere, ogni insignificante smorfia. Il Primario gli rispondeva con sufficienza, senza guardarli. Sembravano il Re e la sua Corte dei Miracoli.
Quando mi fu a pochi metri riuscii a scorgere bene il suo volto rasato di fresco, i suoi capelli brizzolati e perfettamente squadrati, le basette che cascavano rade rade e piene di sussiego, i suoi occhi vispi che facevano da contraltare a un naso sottile e svogliato, mentre le labbra serrate, perfette, parevano menefreghisticamente annoiate.
Mi passò davanti senza vedermi. La sua luminosità di Luminare, con ignavia e senza alcun impegno, calzava appieno tutti i luoghi comuni che la riguardano.
Quando fummo vicini parve quasi puntar dritto verso di me con l'intenzione di speronarmi e, come un pirata, di abbordarmi. Io feci per andargli incontro, ma giunti a non più di trenta centimetri uno dall'altro, virò bruscamente ad angolo retto, come se dovesse seguire un muro immaginario, e infilò la porta della stanza dove Maurizio, cosciente, stava agonizzando.
Una volta davanti al letto guardò il mio amico, che dava ampia visione di sé e della sua misera condizione di moribondo, prendendo a scrutare la sua cartella clinica come un archeologo cerca la verità decifrando geroglifici egizi. Dopodiché tirò su la testa e lo guardò con una smorfia. Il suo volto, prima sicuro e saccente, seguì la drammaticità degli eventi e si fece più greve. Improvvisamente inventò una giravolta su sé stesso e si mosse verso l'uscita della camera. Fu così lesto che la Corte biancovestita per un istante restò sorpresa e spaesata. Il suo camice svolazzò come la gonna di una ballerina di tango nell'erotiche piroette, e i suoi collaboratori dovettero cercarlo per qualche secondo, giacché era scomparso alla loro vista come un fantasma nella notte. La situazione era critica e il suo volto ci si dovette adattare. Giunto a poche decine di centimetri da me si schiarì la voce come un tenore sta attento, poco prima del “Nessun dorma”, a prendere la tonalità giusta. Iniziò a parlare ma dovette metterla a punto un paio di volte, prima abbassandola, ma eccessivamente, quindi rialzandola di un'ottava.
- Lei è un parente? - disse guardando sopra la mia spalla con occhi abbattuti e ignorando volutamente gli altri del gruppo.
- No. - risposi faticando a trovare il suo sguardo - Sono un amico.
- La situazione, come avrà capito, non è affatto allegra. Il suo amico sarebbe da operare subito. Ha il fegato completamente in cirrosi............………
- In cirrosi? - chiesi stupito.
- Sì, epatite C. Glielo ha divorato. Servirebbe un trapianto ma……..
- E allora? - lo interruppi - Che problema c'è?
- Non è così semplice. Lui dice di non voler subire trasfusioni di sangue. Ora, il tempo stringe. Non possiamo più portarlo in un altro ospedale dove hanno le apparecchiature per trapiantarlo senza far uso di sangue, perché non c'è tempo e rischierebbe di andarsene senza vedere neppure la sala operatoria. L'unica speranza è che il vostro amico - e per la prima volta girò la testa verso gli altri – cambi idea, altrimenti.......………
- Ma non è possibile! - dissi infastidito da tanta rassegnazione - Fatemi entrare un momento, lo convinco io.
- Prego. Se ce la fa........................
Entrammo. Coi miei amici ci sparpagliammo circondando il suo letto, come Generali attorniano un tavolo per decidere, scrutando una cartina, le tattiche di guerra. Il biancore asettico della stanza rendeva tutto più muto e sospeso. Sembrava che il mondo avesse spento le luci e abbassato la saracinesca.
L'arredamento era moderno, ricoperto di fòrmica grigio chiara. Ogni cosa era pallida, bianca, che poi è il vero colore del lutto, perché quando si muore ci si rifà vergine la coscienza. Le gambe nude delle sedie di metallo davano al tutto un'impressione cerimoniosa, formale, poco adatta a ciò che erano i momenti. Le finestre, punteggiate di pioggia, lasciavano passare una luce flebile e vuota. Era giorno, ma senza la lucentezza gioiosa propria del giorno. Il panorama era l'autorità della Morte sull'intera umanità, che, traboccando da un corpo ormai ridotto a nulla, va ad infettare ogni cosa intorno, gli oggetti, le persone, la vita stessa. Si aggrappa, la Morte, tira e scalcia, fetente, prepotente, olezza. Se ne approfitta, perché un malato terminale non è nelle condizioni di rifiutare niente. Ma non è sempre così. Altre volte invece è più silenziosa, ha il volto della vita, delle Istituzioni, sorride, si tira i capelli indietro come un vanitoso, ti si mette accanto, ti prende per mano, vuole parlarti, comunicare, convincerti che è l'ora e bisogna andare.
Maurizio era debole, e con gli occhi semichiusi non mi riconobbe subito. Teneva le braccia lungo i fianchi, smorte, coi palmi delle mani rivolte verso l'alto. Il suo viso era pallido e sudato, ma non trasmetteva agli sguardi intorno la Morte, tutt'altro. Sembrava pieno di vigore, nonostante la voce comunicasse uno stato d'abbandono, d'incuria, d'arrendevolezza. Sembrava un bambino con poche linee di febbre che si possono curare più coi baci di una madre che con gli antibiotici. Mi fissò. Quando riuscì a capire che ero io si allargò in un sorriso ingeneroso e impotente.
- Ehi, cosa mi combini? - dissi a voce bassa - Cos'è questa storia che non vuoi fare trasfusioni?
- Anche tu sei un appassionato lettore della Bibbia, - rispose lui con un fil di voce - e dovresti sapere che Dio non accetta che chi lo vuol seguire, chi vuol seguire le sue leggi, commetta consapevolmente peccato.
- Da quando sei diventato religioso?
- Lo sai, mi è sempre piaciuto leggere la Bibbia, e non sono di-sposto a vendermi per salvare il mio misero culo. Altrimenti cosa ne sarebbe di me?
- Ma perché, Dio vieta di assumere sangue?
- Sì. Il sangue rappresenta l'anima, e chiunque lo assuma si macchia di un reato molto grave, un reato che merita la morte. Se io muoio ora, senza assumere sangue, ho qualche possibilità che Lui si ricordi di me quando resusciterà l'umanità, nell'ultimo giorno….…….… altrimenti….………....E poi morirei ugualmente…….…….credimi Gianni………..non è spocchia…………..
- Ti credo......................ma allora................cos'è?
- Tu credi veramente - disse Maurizio faticando a parlare - che tutto ciò che siamo, che abbiamo, la gente che ci stima e ci vuol bene, ci appartenga? L'unica cosa che è davvero nostra sono i nostri princìpi. Senza princìpi non siamo nessuno. I nostri principìi siamo noi stessi. Ora dovrei andare contro i miei principìi, contro ciò che penso, per salvarmi la vita. Ma dopo questo compromesso cosa resterà di me? Dovrei vendermi? No, questa cosa, come la chiami tu, è mia, nessuno potrà mai portarmela via. Se oggi muoio così come sono, sono sicuro di essere io a morire. Ma salvandomi contravvenendo a ciò che Dio vuole da me, magari per morire fra dieci anni, sarò ancora certo di essere io a vivere il tempo che mi rimane?
Non ebbi il coraggio di aggiungere niente. Avrei voluto dirgli tante cose, ma non seppi osare e le parole restarono imprigionate dentro il mio stomaco in una smorfia di rassegnazione. Le smorfie non nascono dalle facce, ma dagli stomaci. Le facce sono solo un punto d'arrivo. Alzai la testa, e vidi che gli altri fissavano il pavimento quasi fosse l’enorme schermo di un cinematografo.
Poi guardai Maurizio. Avevo il corpo sobillato da una matassa ingarbugliata di sentimenti contrastanti. Nonostante il mio amore per lui, in quel momento un po’ lo odiai. Perché era stato così stupido? Perché anche lui aveva finito per farmi soffrire? La memoria, anticipatamente commemorativa, iniziò a frugare fra le pieghe degli anni per riportarmi indietro il mio amico, al quale Maurizio, in quel letto, così poco somigliava, tentando di consolarmi e prefigurando ciò che lui sarebbe stato nei ricordi degli anni a venire. Un gesto solo, una parola, forse rimasticata confusamente, un sorriso, sbiadito perché lui non esiste più. E poi le battute stupide, gli scherzi scemi, e, perché no?, perfino le incomprensioni, i battibecchi. Ma anche il suo ricordo in noi era destinato a spegnersi, magari lentamente, come il fumo di un braciere, resto di un falò enorme, che a notte inoltrata, quando tutti sono andati a casa a dormire, decide di arrendersi anche lui.
Forse i nostri ricordi non sono altro che il tentativo di tenere in vita istanti piacevoli e piacevoli facce, perché sappiamo bene che ogni volta che un uomo se ne va un poco è tutto il mondo a morirne, e, consci d'essere noi stessi il mondo, è come se un pezzettino delle nostre anime rimanga incastrato nel lontano passato, purtroppo non in qualcosa di lieto, bello da ricordare, ma piuttosto perso per sempre in quelle morti tremende, nello sfasciamento umano.
Restai in quella stanza perdendo la cognizione del tempo. Tutti i pensieri, passati e presenti, vennero a tormentarmi, il silenzio di quell'ospedale fece il resto. Entro un’ora Maurizio aveva abbassato gli occhi alla terra. Una volta fuori da lì andai a spasso per la città, titubante come un cieco che a tastoni cerca la sua via.
Avevo immaginato spesso che qualcuno dall'alto, come spettatore fedele di un teatrino in cui si mette in scena ogni giorno la medesima commedia, ci osservasse divertendosi pazzamente. Immaginavo che fosse lui stesso a cambiare di volta in volta la scenografia e le battute, conservando però i ruoli. Cambiava sovente anche il genere, passando dal drammatico al fantastico, e dall'avventuroso al grottesco. Avevo sempre creduto che il mondo sarebbe passato quando lo spettatore avrebbe finito di divertirsi, e non ci sarebbe stato più nessuno che avrebbe pagato il biglietto.
Gli altri non avevano capito molto di quel che Maurizio aveva voluto dire, io sì. Forse è vero. Tutto il coraggio di cui disponiamo può venir fuori solo in casi estremi, come di fronte alla morte, per amore della vita, per tener fede a un principio.......……….………...
Mentalmente misi a confronto Maurizio e Marta. E' incredibile come certa gente, con le azioni, riesca a farti capire quanto l'umanità viva in funzione propria, quanto poco ci curiamo di conoscere le persone in profondità, perfino coloro che reputiamo nostri amici. Allora rivediamo i loro atteggiamenti, le loro espressioni, i loro gesti soliti, addirittura i loro vizi, come qualcosa d'incomparabile, e ci rammarichiamo di non aver avuto quel secondo in più per urlargli in faccia tutto il nostro amore.
Due giorni dopo, davanti al sagrato della chiesa dove i suoi genitori, contravvenendo a ciò che Maurizio aveva lasciato detto, gli fecero il funerale, c'era tutta la città. Nostri fans, sicuramente, ma anche gente normale, che si fermava mentre faceva la spesa o andava al lavoro. L'eco della sua morte, ma soprattutto di com'era morto, in quali circostanze, si propagò come un incendio. Il diretto risultato fu che i nostri dischi (il terzo era appena uscito) in un paio di giorni entrarono nelle classifiche di tutto il pianeta.
Fu al cimitero, percorrendo il lungo sentiero consumato, che pensai seriamente di lasciare il gruppo. Come potevo mettermi in tasca i soldi di quei dischi? Maurizio era morto per i propri principìi. Se noi del gruppo avevamo ancora qualche principio e un po' d'amore per Maurizio era arrivato il momento di dimostrarlo.
Lasciai il gruppo perché gli altri non lo dimostrarono.
IV. Delirio di un artista (presunto)
In questa casa alle Cinque Terre, sulle alture di Monterosso, posso vedere la vita da vicino, strapparle quell'orribile maschera dietro la quale si nasconde il bellissimo volto di Dio. Le pochezze, i sotterfugi, le meschinità, le vanità, appartengono ad un altra mia vita. Una vita che forse non volevo fare, e che invece mi ha cresciuto. Quella stessa vita che ha dovuto prendermi a calci per farmi capire che ero diventato uomo, che i miei anni non me li avrebbe perdonati più nessuno.
Oggi ho capito che siamo stati solo degli effimeri personaggi, comparse alla stessa strenua di tanti individui che affollano il mondo, quasi non fossimo mai esistiti. Come quegli artisti inventati da Marcel Proust per “Alla ricerca del tempo perduto”; Elstir per la pittura, Bergotte per la letteratura e Vinteuil per la musica. Ma, a pensarci bene, sono rimasti più loro che noi.
Se quell'effimera vita è stata solo una commedia teatrale noi siamo stati soltanto i suoi distratti e vanitosi spettatori. Non abbiamo pagato il biglietto e ci siamo seduti nei posti migliori. Non l'abbiamo seguita e ci siamo vantati con chi non è potuto entrare di sapere cos'è stato messo in scena. Ci siamo alzati, verso la fine, e ce ne siamo andati spocchiosamente, senza applaudire. Ma, appena fuori dal teatro, abbiamo sentito dire che quella è stata la miglior rappresentazione dell'anno. Così ci è presa la voglia di rientrare. Ma non ci sarà dato altro da vedere che la morte, perché la vita è l'unica commedia che non si replica mai.
Guardando il mare da vicino mi è difficile non ammettere a me stesso che quello che siamo stati non è che una risata continua, l'illusione di restare, di perpetuare la nostra esistenza. L'immortalità è il desiderio che l'abitudine si protragga all'infinito, ma è in vita che si coltiva la propria eternità, così che spesso arriviamo di fronte alla Morte disarmati, perché abbiamo perso troppo tempo a bighellonare per le strade scure nella notte del mondo. Proprio ciò che ci rende deboli davanti alla Morte. Un giorno tutti saremmo costretti ad uscire da questo mondo senza avere la possibilità di abitarne un altro, e soltanto chi resta saprà cosa abbiamo lasciato.
Anche oggi che sono affannosamente ricercato da chi vuole i miei testi o le mie interviste, mi rendo conto della pochezza dell'artista, e capisco di essere un uomo qualunque. Scrivo, ogni tanto, ma non godo molto. Non so perché, ma sento che gli altri mi regalano quei complimenti di circostanza che fanno più male delle critiche feroci e disoneste. Il successo è una calamita di compassioni e benevolenze che solo l'invidia può inibire.
A volte, sperando in un improbabile normalizzazione della mia vita, m'immagino impiegato del catasto, col tavolo ingombrato da protocolli e sommerso dalla polvere, e col potere di tenere fuori dalla porta tutta l'umanità. Vorrei, oh come lo vorrei!, che qualcuno venisse da me e mi dicesse: “Questa cosa che hai scritto fa veramente cagare”, e magari restare lì con lui a farmi spiegare perché. E invece niente. Solo complimenti, risa, pacche sulle spalle, scherzi e cameratismo. Quante volte avrei voluto, entrando in un albergo per chiedere una camera, che non mi avessero riconosciuto. Quante volte mi sono sentito in questo il Nemico Pubblico Numero Uno.
A volte penso a quanto sarebbe più facile la vita per me senza l'ausilio del successo. Come mi piacerebbe fare il cameriere nelle navi da crociera! La notte, appena smontato dal lavoro, fermarmi sul ponte a fumarmi una sigaretta pensando che la terra non esiste mentre guardo il mare! E poi alzare la testa, fissare il cielo tentando di scorgere qualche stella cadente per allungare una mano ed afferrarla proprio mentre si spegne, e rammaricarmi d'aver pensato che fosse eterna come il mio amore. Camminare sul ponte di legno a piedi nudi, assaporando il dondolìo del mare come se fossi un bambino cullato dalle braccia di una tenera madre. Avere la cabina piena di posters d'auto e di donne, gli uni per ridere e gli altri per piangere. Quando il Sole tramonta riuscire a scoprire dall'oblò dove si trova il Levante in alto mare, e, fra una portata e l'altra, carpire i segreti del cuoco di bordo.
Nonostante tutto credo che i miei “Cent'anni di solitudine” siano stati un po’ troppo brevi.
Ogni tanto mi capita di sentirmi come il soldato di una Armata vinta. Quale misera vita fa “l'artista”! Sempre a ricercare l'umiltà perché sa che prima o poi, come quel sole disegnato da un bambino sulla lavagna nell'ora di ricreazione, toccherà anche a lui tramontare con un colpo di cancellino. E' soltanto lì, in quel momento tremendo, che si capisce, come tutti gli altri, d'aver perso. E allora?
Bisogna avere quell'umiltà di fondo per convincersi che nella sconfitta, come nella morte, siamo tutti uguali. Quale differenza può esserci fra un pittore senza il suo pennello e uno scrittore che fa il tassista? Nulla! E' l'omologazione! La nostra misera paghetta morale di artisti è andata a farsi fottere. Come per tutte le cose che col tempo invecchiano per poi morire, anche noi siamo passati o passeremo.
Forse aveva ragione Maurizio. Ciò che di noi resta è soltanto il nostro comportamento, che ha permesso a qualche persona di amarci davvero. Questo si può ottenere solo con la coerenza, coi principìi, fondamento delle amicizie e degli amori. Tutto il resto non è che un’apparizione fugace destinata all’oblìo.
Quando ripenso ai vecchi tempi non provo quella che sarebbe una più che giustificata nostalgia. Piano piano si cresce e i ricordi si offuscano, così che non arrivo mai a pensare di aver perso chissà cosa. Gli unici momenti magici sono quelli che si vivono, il passato se ne esce, e a volte sento che il mio non mi è mai appartenuto. Cosa può mai darti la vita? Niente altro che ciò che ti prendi! Senza meriti siamo venuti al mondo, e senza particolari colpe ce ne andremo.
Soltanto raramente mi mancano gli alberghi, i concerti, i voli in aereo, i lunghi viaggi in macchina, le urla dei fans, gli autografi fatti bene, quelli fatti male, le notti in treno, le serate a perder tem-po con amici sconosciuti e fidanzate che non ti amano. Solo di tanto in tanto sento la mancanza della chitarra, del palco, di Maurizio, di Marta, di mio figlio. Non c'è tristezza in un volto che non vuole ricordare, ma solo questo successo, tremendo, una barriera invalicabile fra me e il mondo. Per la prima volta in vita mia sono davvero solo, malgrado fuori dalla porta di casa qualcuno sosti continuamente per chiedermi un autografo.
Chissà, forse è questa separazione la mia Morte.
Il nostro attaccamento alla vita non si affievolisce perché invecchiamo e vediamo che i nostri amici invecchiano con noi e tanti muoiono, ma perché i ricordi si offuscano e nella nostra memoria non rimane nulla di cosciente che non sia lo squallido presente. Non si muore mai perché aumentano gli anni, ma perché diminuiscono i ricordi.
Talvolta, sorridendo, mi chiedo se esisto ancora o se sono solo la proiezione dell'immaginario collettivo del divismo. Forse ognuno di noi verrà ricordato solamente come punto di riferimento della storia personale di qualcun altro, o come un passaggio vuoto fra due date.
- In quegli anni mio padre era ancora vivo. – diranno i nostri figli.
Chissà, potremmo diventare oggetto di vanto, di vanità, di presunzione.
- Mio padre ha conosciuto il tal cantante.
Oppure:
- Mio nonno suonava in una band famosa.
Che meschinità! Che frivolezza! Sentirsi grandi per i meriti altrui! Mai capito. Queste cose, chissà per quale motivo, sono abituato a figurarmele con la faccia di Marta. E allora mi scatta l'input e ripenso al ruolo che la vanità ha avuto nella mia vita, o al dolore che mi sono inflitto correndo dietro all'illusione che Marta fosse il “vero amore”, quello con la A maiuscola.
La vanità è abituata a prendersi sempre di più dagli individui che la sfoggiano, suoi padroni, così che per loro diventa il centro gravitazionale di ciò che sentono e di quel che vivono, e il mezzo per poterla sfoggiare acquista una tale importanza ai loro occhi che non lo sanno tenere in disparte per un attimo.
Quante persone ho conosciuto, anche bravi artisti, eccellenti musicisti, che se gli toglievi il loro lavoro non sapevano più come entrare né come uscire. Erano il balìa delle onde, di ciò che spesso cambia. Dove li mettevi stavano; se c'era il sole si abbronzavano e se pioveva si bagnavano. Tutto questo aspettando...……………….
Ancora non sono riuscito a capire cosa stessero aspettando, se il tempo, che secondo loro tutto cambia, o che gli cascasse un sacco pieno di soldi sulla testa. Si guardavano smarriti, e credevano che quel po' di musica che avevano gli sarebbe bastata, che fosse l'unica cosa importante. Non avevano capito che lo svago, ciò che la musica rappresenta per chi l'ascolta, se si è messi alle strette è la prima cosa di cui la gente fa a meno. Come tutti i divertimenti, che in sé stessi non sono l'essenziale ma il superfluo, anche la musica è una di quelle cose che in tempi di carestia non servono a nulla. Ma bisognava capirli, quello era il solo modo che gli permetteva di sentirsi “qualcuno”.
Comunque non c'è limite all'illusione. Anch'io per qualche tempo ho creduto di essere un artista. La verità era che con questa convinzione che mi seguiva da vicino, seduta accanto a me sull'autobus, nel locale, o dove volete voi, mi sentivo come se fossi più di quel che ero. Poi arrivò la vanità, il sentirsi importanti in modo sproporzionato alla causa, e quel poco d'arte che c'era in me svanì lasciando il posto alla disillusione. Capii che le mie miserie non appartenevano solo a quella faccia sulla Carta di Identità, ma anche a quell'altra che anch'io conoscevo solo a sprazzi. Ero, come già detto, padrone di due me stessi. Uno disilluso, cosciente di non voler far parte del mondo, delle sue stranezze, delle sue cose consuete, e un secondo, più portato verso la fantasia, un inguaribile sognatore che era ancora convinto di poter cambiare qualcosa, in definitiva più simile a ciò che ero da fanciullo. Non so dire quale dei due sia stato più misero, vuoto e nudo.
Ciò che più mi preme oggi è stare fuori dalla scena. Da quella politica, dalla musica, dalla comunità. Tutto quel che ho mi basta. Non voglio correre il rischio di tornare ad illudermi come mi è successo in passato. Illudermi che una madre voglia sempre bene al suo bambino, illudermi che chi si occupa d'arte abbia in sé un animo candido, migliore di altri, e voglia occuparsi d'arte perché gli piace, perché è uno spirito libero. Non voglio illudermi che gli amici non debbano morire mai solo perché sono i “nostri amici”.
Mi spiace umanità, ma non susciti in me alcun moto, non ho più niente da dirti. Quello che oggi voglio è che tu ti distragga un momento, che volti la testa dall'altra parte per farmi uscire da te in silenzio, senza clamori né false sorprese.
Non ho mai amato i funerali di Stato o quelli di cadaveri eccellenti che con la loro dipartita riescono a riempire i sagrati delle chiese e i piazzali sottostanti.
Ricordo i funerali di Maurizio. Sì, c'era tantissima gente, ma molta era lì per caso o per noia, perché non sapeva cosa fare quella mattina. Quando li guardavo, quando li vedevo indaffarati a farsi riprendere dalle Tv, pensavo che Maurizio meritasse di più. Di più di quella specie di gazzarra messa in opera, di più delle parole che quel prete dietro quell'altare pronunciò senza neppure conoscerlo, di più dell'affetto fittizio che molti gli avevano riservato, di più della vita che aveva condotto contrattando i suoi anni con la Morte.
Seduto su questa sdraio, sul mio cortile a Monterosso, nella Liguria più discreta, penso che non tutti, come me, hanno il privilegio di vivere senza arrabattarsi. Ma tutto ciò che ho, che sono e che sarò, lo devo realmente alla musica?
Quando ripenso a ciò che la musica è per me mi metto a ridere da solo. Il nostro successo, il mio, è solo frutto di considerazioni esagerate, frutto dell'illusione dei nostri fans che dando un po’ di celebrità ad una persona normale, e considerandosi persone normali essi stessi, possano usufruire di un indefettibile sillogismo, frutto di speranze di chi ce lo ha dato, di potercelo un giorno togliere. E prendetevelo allora, questo cazzo di successo!
Sono sicuro che se un giorno qualcuno che mi conosce, anche solo di fama, non importa, venisse a rinfacciarmi la mia agiatezza, tutto quello che posso rispondergli non basterebbe a calmarlo seriamente. Ma è davvero molto che ho?
La mia casa, la mia donna, i miei figli e io stesso, riesco a tenerli insieme soltanto col timore. Quello stesso timore che mi prende la sera, quando sto per andare a dormire e penso al domani chiedendomi che ne sarà di me e di tutto quel che ho. Quel timore che, ne sono sicuro, il mondo non sarebbe in grado di capire fino in fondo.
V.
Subito dopo la morte di Maurizio entrai in una crisi profonda. Una crisi dalla quale, sentivo, non mi sarebbe stato facile uscire. In quei giorni molti mi consigliarono l'Analista, ma io non vi andai mai. Non ne vedevo, come non ne vedo, l'utilità. Anche perché non ho mai creduto nell'efficacia della Psicoanalisi. Sarebbe come andare da un ateo a farsi spiegare Dio.
Che comica. La Psicoanalisi è l'unica Scienza Medica che cura i pazienti usando come medicina i luoghi comuni.
Fatico a capire perché le persone che vanno dall'Analista non provino prima con un loro amico. Presumibilmente perché sanno già di cosa soffrono e, per superbia, non vogliono farselo dire da chi già li conosce e in modo gratuito.
Confondiamo l'originalità, l'essere unici, con la complessità del nostro carattere, e se qualche nostro amico ci dice “non ti capisco”, invece che pensare se per caso non ci siamo spiegati male, ci sentiamo stupidamente orgogliosi. Sovente penso che la vera terapia siano i soldi che si lasciano in quelle sedute.
Quando un tizio va dall'Analista, quasi sempre, è perché si rende conto d'aver sbagliato in qualcosa e che sia proprio quell'errore a farlo stare male. Dando quei soldi per le sedute il paziente si fa la convinzione di pagare principalmente per quello sbaglio. Per carità, non c'è nulla di male in questo, ma facendoci caso traspare in questi individui una convinzione di fondo che fa più paura della loro pseudo malattia: che i soldi riescano a comprare non solo il benessere fisico, ma anche un certo stato di coscienza che fa sentire più puliti.
Demostene, rispondendo ad una cortigiana che gli aveva chiesto una grossa somma di denaro per concedergli i suoi favori, disse: “Non pago così caro un rimorso”.
Per un breve periodo rimasi come separato dalla vita, dal mondo. Come se l’atto di quella donna nell’uccidere nostro figlio mi avesse contagiato, mi allontanai da tutto con la vaga speranza di mondarmi da quel contagio, da quell’epidemia conformista che tentava di annientarmi. Certo, ben presto capii che la ricerca di quella stravagante purezza era solo una scappatoia meschina, e che la salvezza personale sarebbe stata comunque ben poca cosa al cospetto del dolore che provavo, ma, con quel rancore dentro che per i primi tempi mi fu necessario, riuscii a so-pravvivere.
La presenza di Marta nel mio cuore e nella mia coscienza d'esser vivo continuava ad essere qualcosa di estremamente doloroso. Si materializzava sottoforma di odio, certo, di rabbia, di gelosia, perfino di rimorso, e per alcuni anni non mi lasciò in pace un momento. Ebbi successo nel trasformare ciò che aveva fatto in una specie di tradimento, e il rancore era per me come una droga, un'assuefazione, un'assuefazione della quale non riuscivo a fare a meno.
L'amore che vogliamo ad una donna è una sorta di specchio che riporta indietro la nostra immagine, e quand'ella in qualche modo ci tradisce è come se perdessimo la fiducia in noi stessi. Consideriamo quel tradimento come una nostra pecca; “l'incapacità di essere uomini”. Amiamo perché narcisisticamente “ci amiamo”, e quando veniamo traditi dalla nostra donna vediamo nella nostra condizione di traditi non solo la fine di un rapporto, ma anche quella della nostra capacità di accettarci per ciò che siamo. Così, vittime di tali situazioni, si reagisce in modi assai diversi; gli uomini si attaccano alla bottiglia per darsi il colpo di grazia, e le donne vanno da un Chirurgo Estetico a rifarsi il seno. Si potrebbe dire che l'uomo vede nel tradimento di cui è vittima, una delusione irreparabile che lo porta verso il suicidio, e la donna invece la sua morte vera e propria. Così il primo si uccide davvero, e la seconda, considerandosi già morta, tenta di rinascere più bella di prima.
Entrambi i comportamenti sono frutto di millenari retaggi.
L'uomo, più cacciatore che cacciato, non sopporta di essere snobbato dalla sua preda, mentre la donna, preda per definizione, mal digerisce che a lei si preferisca altra selvaggina. Da tali fatti si può desumere che la donna, benché meno capace di amare (altrimenti non si spiegherebbe la contraddittorietà del suo “perdersi” e la destrezza nel riuscire a “voltare pagina”), tenga più dell'uomo al suo ruolo di specchio, e che l'uomo, stupidamente convinto di essere invincibile, veda nella rottura di quello specchio non sette anni di sfortuna, ma il completo annullamento del suo spirito.
La consapevolezza che agguanta un tradito è simile a quella visita medica che siamo convinti di fare per una sciocchezza o per routine, e che invece ci rivelerà un nostro stato tumorale.
La vera forza degli uomini oggi, è tutta nel saper rompere gli specchi senza torturarsi poi con un ridicolo rimorso. Non so dire se qualcuno di voi si sia mai fermato a pensare seriamente a ciò che sono gli specchi, neppure io per molto tempo lo avevo fatto. Noi ci fissiamo, ci presentiamo davanti a loro, gli chiediamo di presentarci al mondo, convinti che soltanto loro siano in grado di raffigurarci per ciò che siamo. In realtà lo specchio non ci mostra per quel che siamo ma per ciò che vorremmo essere. E’ senz’altro questo il motivo principale per cui gli specchi non servono a niente.
Sono convinto che se sapessimo con chiarezza cos'è uno specchio, avremmo in mano la Pietra Filosofale del Terzo Millennio.
L’unico nostro specchio credibile sono gli altri, e principalmente la persona di cui siamo innamorati. Capisco che sia difficile ammetterlo, ma purtroppo è proprio così. Quando la nostra donna vede in un altro uomo la capacità di farla sentire più importante e più fedele a sé stessa, più simile a come si vorrebbe, capiamo che il nostro, di specchio, è andato in frantumi, e, vittime di quello che consideriamo un tradimento, siamo portati istintivamente a non fidarci più di alcuno specchio. Solo mutando le nostre ambizioni amorose riusciamo a rifarci una vita sentimentale con un’altra donna. In pratica, solo cambiando specchio.
Il tradimento è difficilmente perdonabile perché il suo atto ingiusto d'infedeltà sfrutta la fiducia di chi ama, e, per questo stesso motivo, è capace di violentare nelle carni le sue vittime. Si può capire, e forse anche giustificare, chi salta la barricata per opportunismo, molto meno chi lo fa per noia o per vanità. L'infedeltà non è solo “andare” con una persona diversa dal nostro partner solito, ma regalargli il proprio lato migliore (il farsi belli, andare dal parruc-chiere, profumarsi e mettersi in bella forma per un altro, o un'altra, in pratica gli “addobbi” che un vanitoso allestisce per la collettività) mentre riserviamo al compagno legittimo la squallida monotonia della normalità (la faccia gonfia dal sonno, il modo orrendo di cucinare, le spese pazze, la puzza delle defecazioni, la pochezza intellettuale e ogni altro difetto). E' questa la faccia visibile del tra-dimento. Difetti che si sopportano fino a quando ci si sente amati, ma che diventano una tortura dal momento che il nostro partner trova altrove l'amore che prima gli davamo noi. Chi è in grado di tradire la persona di cui sa d'essere amato, è capace di fare qualsiasi cosa.
Naturalmente nulla è generalizzabile, e tanto più le considerazioni amorose, altrimenti molti non perderebbero tempo a tentare di rifarsi una vita, e vedrebbero nella canna del gas una più semplice e meno frustrante via d'uscita.
Ricordo che allora, poco prima dell'aborto, quando meditavo di lasciare Marta, bastava solo quel pensiero per rovinarmi la giornata, mettendomi in uno stato di assoluta ansietà. Volevo essere un mago, che con un colpo di bacchetta cancella tutto. Volevo non esser mai nato. Volevo che lei fosse come prima. Volevo lasciarla, ma anche reinnamorarmene. Volevo farla soffrire, ma pure curarla.
Queste contraddizioni non sono un fatto strano, perché vedete, nonostante tutta la Letteratura, per quante ragioni valide ci possano essere, abbandonare l'essere amato è sempre un atto di estremo coraggio. Non tanto nel voltare le spalle e andarsene, quanto poi nel ritrovare la strada, digerire i ricordi, la solitudine, la mancanza di fisicità, sopportare le tristezze, le malinconie, ed essere in grado, col tempo, di sostituirle. E' il “punto del non-ritorno”, un limite oltre il quale sappiamo che di là in avanti non ci aspetta altro che sofferenza.
Quello che in vita più ci preme è di entrare nelle grazie di quel personaggio che, a detta di tutti, rappresenta la personificazione, seppur momentanea, dell'importanza. Nel piccolo quotidiano di ciascuno di noi esiste una persona del genere. Può essere il Capo Ufficio, la ragazza che ci piace, o colui che può farci fare un salto di qualità nella nostra vita. Ma se qualcosa improvvisamente cambia (c'innamoriamo, perdiamo il posto di lavoro, traslochiamo in un'altra casa o in un'altra città, siamo vittime d'incidenti o perdiamo una persona cara), allora il nostro cervello è disposto a dimenticare il clima, le fattezze e gli atteggiamenti di quell'importanza così, in modo anonimo e naturale. Magari in attesa d'incarnarne un'altra.
A volte, più che la vita delle persone, è la manipolazione del nostro ricordo ad esserci fatale. Gli individui cadono sempre nell'errore d'idealizzare. E' uno sbaglio che si ripete ciclicamente, un circolo vizioso fatto di richiami memorizzati. Si ragiona a caselle, ci si affida all'inferenza; una voce, un individuo, una mentalità, una faccia, un nome. Un rumore una cosa, un posto, una situazione. Il problema è che il nostro cervello tende a rimuovere quanto di brutto abbiamo passato, e allora non restano che i momenti felici, che spesso e volentieri siamo stati noi, nelle nostre evocazioni manipolandoli, a far divenire tali. Nel far questo, però, resta nell’aria un pericolo; che la nostra volontà vada a stuzzicare la memoria in maniera sbagliata, così che le immagini che Ella ci riporta indietro non sono le desiderate, e le brutte figure che quell’oggi ricordiamo, ci fanno arrossire più di quanto non ci abbiano fatto arrossire il giorno stesso che ne fummo vittime.
Non è così male cadere preda di questo formulacro di considerazioni che, sebbene scontate, ci fanno ricrescere dentro quei punti fermi che plasmano la stima per noi stessi, perché se così non fosse molti di noi si farebbero vincere dal rancore e dalla rivalsa, e finirebbero per strangolare il loro ex partner, propinatore di quelle umiliazioni.
Per qualche tempo mi sentii improvvisamente vecchio. Mi scoprii a guardare le donne per strada, cosa che non era mia abitudine fare. Non le guardavo come avrebbe potuto fare un qualsiasi “affamato”, fantasticando sessualmente su di loro, ma giusto come può fare un anziano disilluso, convinto che siano il male che c'è sulla terra. Mi appostavo dietro la vetrina di un bar, seduto ad un bisunto tavolino, e da lì le spiavo. E nel vedere le loro teste voltarsi rincorrendo i posteriori di uomini eleganti e “costosi”, o le loro auto, o le loro dita asettiche d’impiegati bancari o agenti di Borsa, battevo le mani sulle gambe ridendo come un matto, per il ridicolo. O forse per l’invidia. Non lo saprò mai. Così le odiavo, per un istante, e se guardandole pensavo al sesso, mi ritrovavo, sadico, a frustarle e torturarle.
Ogni tanto, però, sentendo la mancanza dell'innamoramento, riprendevo ad amarle, e, proprio come gli anziani, avrei voluto sapere qualcuna di loro innamorata di me perché io, allora, potessi innamorarmi di lei. Come gli anziani, che vivendo il solo amore per loro possibile, l'amor senile, si trasformano in “fratelli intellettuali” (perché non hanno più possibilità fisiche e l'unico ruolo che godono rivestire con le donne è quello del Mentore), non badavo più di tanto alle facce, e la mia smania di rinvigorire gli affari di cuore che, ancora come gli anziani, avevo creduto spenti per sempre, mi avrebbe permesso d'innamorarmi di chiunque.
Fu allora che mi ritrovai ad essere combattuto da un sentimento contrastante; volevo ucciderle tutte, queste donne, queste maledette, o me ne volevo innamorare globalmente, come se fossero una squadra di Calcio o una corporazione? E Marta? Il mio amore per lei? Dovevo considerarla, dopo ciò che aveva fatto, una persona normale? Avevo provato, simulando una condizione fatta di contorni sfuocati, a perdonarla, ma la mia coscienza, scarsamente allenata al peggio, mi rimetteva continuamente davanti la sua faccia ghignante mentre mi diceva di aver abortito.
Sapevo che quel ghigno era solo superficialità o frutto di un istinto isterico, ma, seppur nei ricordi soltanto, non riuscivo a sopportarlo.
Nei giorni che seguirono il nostro distacco, quell'immagine fu per me, al tempo stesso, un'àncora che mi teneva ormeggiato al passato, al nostro amore appena finito, agli istanti belli vissuti assieme, e una specie di distributore di determinazione. Libertà e schiavitù, felicità e tristezza. Era la voglia di amare Marta e quella di disprezzarla. Era, nelle sue possenti apparizioni, uno di quei Sergenti che in trincea spronano i soldati a non temere il nemico poco prima di un assalto alla baionetta, o un pazzo pacifista, un disertore che saltando fuori dal camminamento va incontro al nemico urlando: “Vi voglio bene tutti, nemici miei!”
Quando il desiderio di perdonarla iniziava il suo ruffiano lavoro di convincimento sulla mia coscienza, a me bastava chiudere gli occhi ed evocare, in modo che sorgesse dall'angolino del cuore dove avevo accatastato odii e rancori, l'immagine della sua faccia, che tanto avevo amato, mentre pronunciava quelle fatidiche parole. Chissà, forse se non mi fosse importato nulla di lei sarei anche riuscito a perdonarla.
Talvolta pensavo di tornare con lei e di schiavizzarla, d'imporle rapporti sessuali contro natura e di picchiarla se solo avesse aperto bocca senza il mio permesso, ma quelle meditazioni erano vacue nuvolette che lasciavano il tempo che trovavano. Alla donna di cui siamo innamorati non saremmo in grado di torcere un capello.
Riuscire a dar sfogo alle proprie perversioni è il risultato di una lunga operazione che ha come obiettivo quello di trasformare le vittime, o le complici, di quelle nostre depravazioni in oggetti di estranee confidenze. Con le donne che amiamo questo ci riesce scarsamente. E non tanto perché elle non ci eccitano, quanto perché il nostro amore funziona da inibitore. Il nostro sentimento è un tubicino di scappamento dal quale evaporano tutti i nostri perversi desideri sessuali, così che quel “far all'amore con loro” diventa più un atto dissacratorio che una “partita doppia”.
Forse ha ragione il Professor Kafka, che riconduce la scarsità di serotonina nel fisico alla ragione principale per cui i maniaci sessuali sentono la spinta a stuprare le donne. Si sa che quando siamo innamorati la serotonina raggiunge livelli altissimi, per cui, secondo il succitato Professore, il nostro eccitamento sessuale ne risente.
Con gli occhi della memoria ogni tanto la riguardavo, la mia Marta, e la ritrovavo come l'archetipo della donna moderna tutta gambe e collant, tailleur e ventiquattrore, capelli e shampoo alle erbe, tette e Consigli d'Amministrazione. Una “finta potente”. Sì, “finta” perché ora capivo di averla avuta in pugno, seppur per un breve istante, di aver avuto il potere di prenderla o di rifiutarla, ciò che infine feci. Io non ero come lei, sapevo soffrire io, contestualizzando, senza dare le colpe ai movimenti, studenteschi o dinoccolati che fossero. Scoprii che quella presunta “potenza” che le avevo attribuito era anch'essa veicolo di vendetta, perché più la ricordavo “potente” sapendo di averla avuta in pugno, più godevo perché capivo di essere io stesso potente. Si sa, le vittorie non sono tutte uguali. C'è quella sul misero, un disgustoso approfittarsi, quella sul coniglio, che lascia l'amaro in bocca, e quella sul potente vero, che ci trasmette, rubandola a lui, un po' della sua potenza. Fu così che mi resi conto di essere diventato un uomo. Forse anche per colpa di Marta, ora la mia nemica.
Siamo sempre pronti a raffigurarci il dolore e la cattiveria col volto di chi ci ha fatto qualche carognata. Siamo talmente certi che la cattiveria sia lui, che solo il tempo può cambiare le sembianze di quel viso e restituirci l'essere astratto che prima d'incarnarlo ci eravamo sempre immaginati. Ora, per me quel nemico era Marta, il mio amore, per Marta era nostro figlio, vittima predestinata del suo conformismo. A nessuno dei due venne in mente che quel viso poteva anche essere del mondo.
Un giorno, insipiente, pensando affogato nella mia crisi esistenziale, capii che mi era rimasta solo una cosa da fare; staccare la spina. Prendermi un po' di tempo, per me, per rinfrancare il mio spirito, per uscire dall'inappetenza, per recuperare qualche speranza nella vita senza, tuttavia, perdere la mia amata disillusione e finire per diventare come uno dei tanti ingenui che ci capita d'incontrare sempre più spesso (con la vista occlusa da rosei paraocchi e un qualunquismo ottimista nutrito di superficialismo), secondo i quali il mondo in fondo possa essere un bel posto, che a tutto ci sia rimedio, che bisogna battersi per la pace, e che per questo crede nelle guerre umanitarie, meschinetto, che vede le nazioni come un insieme di armonia e di sicurezza. Volevo solo uscire dalla mia crisi esistenziale senza perdere la mia disillusione, mica diventare un deficiente! Non volevo mettermi a bere o, come fanno molti, abbandonare la mia casa e mettermi a viaggiare. Credo fosse Cèline che scrisse: “Il viaggio non è che una piccola vertigine per coglioni”.
Chissà, forse ha ragione lui e noi siamo davvero dei coglioni che ancora non l'hanno capito.
C'è chi parte per fuggire, e fa il “giro del mondo in ottanta giorni” per ritrovarsi poi allo stesso punto di partenza, con gli stessi problemi da risolvere e le stesse insofferenze. Purtroppo quel bagaglio di pochezza che siamo non si perde mai agli aeroporti o nelle stazioni. Pare abbia un'intelligenza propria, e nelle rotelle la velocità per riacchiapparci anche se andiamo a finire in Polinesia.
Qualsiasi cosa ha il suo contrappasso, comprese vanità e superficialità. Scappare dai problemi è scappare da sé stessi, e per quanto lunghe le nostre gambe possano essere, alla fine è sempre il corpo a cui sono attaccate che si porteranno dietro.
Sono quasi sicuro che la nostra vita sia su un'eterna bilancia. Una bilancia che tutto pesa e che tutto calcola, anche i comportamenti minimi, oltre alle tragedie, alle fortune, al caso e alla pianificazione o ciò che noi crediamo tale. In realtà ci è stata data da consumare una porzione, che è la nostra intera vita, e tutto quello che facciamo o che ci capita, sia esso bellissimo o doloroso, altro non è che parte di quella porzione. Possiamo prenderla per farne quel che vogliamo, darla da mangiare ai cani o usufruirne al massimo, ma non ci sarà dato altro che non sia di quella porzione. La vanità può essere parte integrante di quella porzione, e, come se ci fosse caduto un capello nel piatto, dobbiamo costantemente ricercarla e tirarla via, gettarla nella spazzatura.
Ma probabilmente un giorno scoprirò che anche la bilancia è una mia, una nostra invenzione. Non è improbabile che il contrappasso sia soltanto una scusante, e che il solo espediente per mettere le cose al loro posto sia unicamente la Morte.
Quante storie ho visto finire male per troppa vanità o per la presunzione di essere riusciti a celarla perfettamente, dove nessuno potesse vederla. In realtà è proprio la vanità stessa ad ostentarsi, a non perdere occasione per mettersi in mostra, e a tutto questo non c’è rimedio alcuno.
Se bene ci pensiamo, il tizio che vediamo nello specchio quasi mai siamo noi stessi. Il riflesso di uno specchio è l'unico caso conosciuto di ubiquità, così che guardandoci indossiamo sia i panni del-l'attore che quelli dello spettatore (che potrebbero anche essere quelli del fraudolento e della sua vittima, del peccatore e di chi ha subito il “surrettizio”, dell’assassino e dell’assassinato), e per pia-cerci siamo portati, quasi istintivamente, a recitare una parte che non abbiamo recitato mai, a trasformarci in un personaggio che calzi appieno i nostri gusti.
In verità stiamo solo tentando d’ingannare noi stessi.
E' davanti agli specchi che gli individui diventano ridicoli, perché per piacersi recitano dando il meglio di sé stessi ma vestendo vanitosamente abiti di scena che non gli somigliano per niente, e finiscono per caricaturare il vicino di casa, un personaggio televisivo o un amico. Un vanitoso, per piacersi davanti allo specchio, deve necessariamente abbandonare la sua personalità e indossar-ne un’altra, ed è in quell’esatto istante che sta tentando di eludere il contrappasso.
Ricordo che quando mi accadeva di vedere della vanità in individui che avevo ritenuto di un certo spessore, subito mi rimproveravo il fatto di essere caduto di nuovo in quella voglia di speranza, in quella voglia di fiducia dentro la quale cascano gli ingenui.
Allora mi rimproveravo la mia avventatezza nel giudicare gli individui. Ma a pensarci bene non era tanto colpa mia, quanto la diversità delle situazioni in cui li avevo, la prima volta, conosciuti e considerati, e, la seconda, rigettati. Allora rimanevo spaesato, smarrito, e mi chiedevo come potevo esser stato così ingenuo. Certo, la loro vanità non avrebbe dovuto interessarmi, ma sono sempre stato un tipo troppo sofferente, un moribondo con la voglia di guardare la Morte negli occhi solo un secondo, appena un secondo prima di morire, e avere quel secondo per allietarmi il cuore dicendo:
“Certo, era proprio lei, e io l'ho vista”.
Non ci si rimprovera mai abbastanza nella vita, datemi retta. Così, ogni volta, ci troviamo di fronte agli stessi sbagli e davanti alla stessa delusione, agli stessi sintomi che la delusione porta nel cuore. Stanchezza per la vita, rabbia, lacrime per troppa autocommiserazione, falso vigore e fin troppo vero rancore. Nulla ci sembra così naturale come odiare il mondo, ma sentiamo anche che quell'odio è la strada più breve per morire. Allora? Ti allontani da tutto e da tutti. Ti prepari, ricamando, un mondo alla tua portata, fatto su misura per te, dove nessuno può entrare e portar via. E' il solo modo per sentirsi vivi, vincitori, e, se capita, perfino uomini.
Qualche volta può anche venirti la spinta per ricominciare, per provare a rientrare nel mondo, nella società, ma capisci presto che per te non c'è rimedio, che il tuo posto non è in mezzo agli altri, o non completamente. Cerchi di cacciare questo sentore, vuoi sentirti un caso disperato. Sovente non ci riesci.
Così successe anche a me.
Cambiai casa, andai ad abitare a Monterosso, in paese. La mia casa era veramente lontano da tutti, confusa nei monti. Solo raramente andavo in città, a Genova, giusto quando non potevo farne a meno. Il fatto che mi fossi spostato a vivere in un paesino tranquillo mi rendeva agli occhi degli altri, amici, parenti, giornalisti, televisioni e fans, una specie di oggetto misterioso. In realtà la ragione per cui me n'ero andato era semplice. Di tanto in tanto, sotto casa mia, trovavo alcuni curiosi che si avvicinavano, mi squadravano da testa a piedi e, con l'aria di dire: “Tutto qua?”, allungavano un foglietto sul quale io scarabocchiavo una firma deprimente che li acconten-tava. Giusto così.
A Monterosso ho preso dimestichezza con la vita da casalingo, e mi sto convincendo che sia proprio questa a rivelarci la compatibilità che eventualmente possiamo avere con una donna. Quando si va d’accordo in camera da letto, in cucina e in bagno (l’igiene non è da trascurare), allora siamo a metà dell’opera. Se poi troviamo affinità anche nello studiolo, davvero abbiamo trovato la nostra scarpetta.
Un'altra cosa che m'incuriosisce di questo paesino è l'aspetto diffidente che le forze dell'ordine nutrono nei miei confronti. Non capisco come affrontano l'obbligatorietà di avere a che fare con me. Io ero famoso, ero un artista, e loro lo sanno, però sono considerato da Carabinieri e Polizia come uno di quegli artisti moderni tutto sesso, droga e rock 'n roll. Così, ogni volta che li incontro, li vedo combattuti se fermarmi per chiedermi i documenti e, con fare indagatore, cercare di capire quale sorta di personaggio sono, o, come normali cittadini, tentati dal chiedermi un autografo o snobbarmi. In quel paese, però, non è che ci sia molto da fare, quindi io sono diventato l'attrazione principale. Così esco il meno possibile, e quando lo faccio me ne vado, per non star fermo a farmi ammirare come una scimmia dentro una gabbia allo zoo, nei paesi vicini; Vernazza, Corniglia, Manarola eccetera.
Alle Cinque terre c'è una stradina che costeggia il mare e che unisce tutti i paesini. Spesso, con mia moglie, partiamo la mattina e andiamo a passeggiare in questo sentiero, in questa strada.
Abbiamo fatto amicizia con qualche persona, così succede che ci fermiamo in ognuno di questi paesini e le andiamo a trovare. A Vernazza abbiamo conosciuto due ragazze che sono proprietarie di un negozio nel quale si degustano vini locali. Sono simpatiche e sovente, nei nostri giri di perlustrazione, ci fermiamo da loro a farci qualche bicchiere di Sciacchetrà o di vino delle Cinque Terre. A Corniglia, non molto distante, poco più avanti, ho fatto la conoscenza del Capo Stazione che abita vicino a dove lavora. E' vedovo e ama il vino. Di tanto in tanto m’invita per una cena o per vedere la partita insieme. Ha sempre mille cose da raccontarmi e la sua parlata, cadenzata come quella di un anchor man, mi diverte parecchio.
Per come ero abituato in passato questo genere di vita non è granché, ma io cercavo proprio questo. Ero stanco delle confusioni, delle amicizie opportuniste e dei “partiti presi”. La vita “dell'artista” è tanto pregiudizievole che ti ritrovi ad aver a che fare sempre con la stessa gente perché ti convinci che gli altri, che non siano i tuoi amici, non possono essere interessanti e simpatici.
Soltanto raramente ripenso a Marta. Lei è lontana nei miei ricordi, lontana a tal punto che oggi ho perfino scordato la sua faccia. Mi va bene così. Il rancore sordo che le portavo si è quasi sopito del tutto, e solo pensando a ciò che poteva essere mio figlio ogni tanto riesco a destarlo. Ma è solo parvenza d'odio. Non l'ho mai perdonata, ma non sento di volergliene più di tanto. Mi piace pensarla con qualche bel giovanotto, con casa, auto, telefono cellulare a carico, e senza la costrizione di volerle bene. Qualche tempo fa mi sono convinto che fosse lei a rappresentare lo stereotipo di quella che si è fatta fregare dalla Tv. Il bisogno di protagonismo è uno dei mali del nostro secolo, più pericoloso della droga e di altri “vizi personali”, e lei ne era assolutamente assuefatta.
Chissà, oggi, con tutti quei programmi “in diretta” dove chiudono dieci persone in un unico ambiente e le spiano per mesi ventiquattrore al giorno, Marta potrebbe avere un bel palco-scenico su cui esibirsi.
Fu in uno dei tanti giorni seduto ad aspettare che la mia vita cambiò drasticamente. Non pensavo che la mia porzione mi serbasse qualcosa di nuovo, ed ero sul punto di considerarmi un uomo di poco conto che non avrebbe lasciato alcuna traccia visibile di sé stesso.
Anche questa volta fui smentito.
VI.
Un bel giorno venni a sapere, tramite posta, che eravamo in debito con la nostra casa discografica. Gli dovevamo un disco. Avevamo firmato un contratto per cinque dischi e ne avevamo fatto solo quattro. Erano diversi anni ormai che avevo smesso di suonare per il pubblico. La chitarra la tiravo fuori solo con gli amici del paese ed ero sempre risoluto a non voler rientrare nel mercato discografico. Questa faccenda era comunque da mettere a posto, se non altro per non pagar penale.
Telefonai ad Alessandro e lui fu d'accordo con me.
Quando il gruppo si era sciolto lui e Giacomo si erano messi insieme e avevano continuato a suonare, facendo qualche disco che aveva avuto anche un discreto successo. In pochi giorni rin-tracciammo anche Enzo, e ci accingemmo a comporre qualcosa di nuovo. Sostituimmo Maurizio con Massimo, un ottimo tastierista, ed iniziammo a provare. I primi tempi mi sentivo abbastanza legato nelle dita. Un conto è suonare in spiaggia per la tua fidanzata o per qualche amico, un altro è suonare insieme ad altre persone. Dopo la prima settimana fu abbastanza chiaro che non riuscivamo a cavare un ragno dal buco, e dopo esserci riuniti e averne parlato, decidemmo di abbandonare definitivamente quel progetto.
Dopo aver convocato Gagliardi e il Produttore Lopresti, dicemmo che non ci usciva niente di buono. Il Produttore, non dopo aver tentato più volte di farci cambiare idea, cedette ed accettò la nostra proposta di far uscire sul mercato una raccolta di pezzi vecchi più un brano inedito. Così uscì l'album che doveva sancire il nostro definitivo tramonto come gruppo rock.
Trovammo per questo disco un titolo originale e assai divertente, una specie di scioglilingua:
“Seghiri Munilaciu,
Gheramastumapasu del mistico Sole”
Era anche il titolo dell'unico pezzo nuovo che eravamo riusciti a comporre. Come al solito ero stato io a scriverne i testi. Era la storia di un uomo che avevo conosciuto a Vernazza in un pomeriggio d'Inverno, quando il mare mosso e il cielo grigio fanno riemergere i ricordi e ci fanno sentire più tetri e malinconici di quel che siamo.
Passeggiavo nei pressi del moletto quando si scatenò un acquazzone. Cominciai a correre cercando un riparo che mi proteggesse dalla furia della pioggia, e lo trovai in un'osteria lì vicino. Il locale era quasi completamente vuoto. Le sue travi scricchiolavano solo a guardarle, il pavimento era spaccato in più punti, e il bancone sembrava un suppellettile improvvisato, di quelli che i venditori ambulanti allestiscono nelle Fiere e nei mercati rionali.
Gli unici due abitanti erano il barista e padrone del lurido postaccio, e un vecchio che, di-scretamente defilato, occupava sgraziatamente un antico e sporco tavolo di legno. Aveva gli abiti sunti e consunti, con macchie evidenti sul davanti, e un paio di scarpe da marcia forzata dell’ARMIR. Il suo viso era da giovane vecchio, con la barba spettinata e i capelli che parevano essergli cascati in testa dal quinto piano di un palazzo. Aveva un portamento malandato, con spalle curve da becchino, ed emanava anche un discreto “odorino”.
Ordinai un bicchiere di vino caldo e mi adagiai su una sedia per aspettare la fine del Diluvio. Il vecchio, sebbene pareva non tener conto del nuovo arrivato, io, cercava di ammaliarmi con finto interesse. Sfogliava dei giornali laceri passandoli da una parte all'altra del tavolo. Anche lui, malgrado la sua condizione, aveva un fare vanitoso. Probabilmente era convinto che i suoi anni potevano per-mettergli d'essere saccente e di considerare, certo di conoscere il mondo, l'intera umanità molto più ignorante di lui. Si sa, ad una certa età si raggiungono consapevolezze che non s'avevano mai avute in precedenza. Almeno, nominalmente.
“Questi sono gli individui che mi fanno salire la voglia di rompere definitivamente col mondo”, pensai io. Mi sbagliavo.
- Permette una parola? - mi disse.
- Prego. - risposi io trattenendo uno sbuffo di noia.
- Mi chiedevo se poteva interessarle il mio lavoro. – continuò il vecchio.
Prese a raccontarmi una strana storia. Si occupava di pesca, ma nel tempo libero faceva anche dell'altro. Era appassionato di spiritismo e mi disse che molti di quei posti, alle Cinque Terre, erano infestati da fantasmi e da spiriti. Mi disse anche che quando la pesca non riusciva a mantenerlo in vita faceva un lavoro nuovo e originale; vendeva quotidiani di seconda mano. Quei giornali erano vecchi e portavano notizie datate che, in certi casi, potevano anche avere venti-trentanni.
- Lei non si rende conto di quanto interessanti possano essere le notizie rilette a distanza di qualche anno. – disse - Certe sono rimaste avvolte nel mistero, altre, anche se palesate da indagini e completate da finali, agghiaccianti o lieti che siano, conservano quella grazia e quell'interesse propri dei romanzi d'appendice. Non gli è mai capitato di rileggere una notizia alla luce della conclusione che ha avuto la vicenda? Le assicuro che può essere divertente e molto istruttivo. Come può essere istruttivo rivedere l'andamento della Borsa e dell'Economia di qualche anno fa, quando gli Imprenditori erano seri e non avevano ancora partorito i figli che oggi vogliono dominarci spocchiosamente, e che sono portati a confondere i loro interessi con quelli generali. E poi le polemiche sportive. Che spasso! Si parlava già di doping, e oggi ancora non sono riusciti a metterlo sotto controllo. Qualche dubbio ti viene. Io mi diverto coi Necrologi e le pubblicità. Ogni tanto mi accorgo che le pagine parlano. Ci dicono che il fatto di essere consunte può essere messo in relazione con chi li ha letti. Spesso ci trovo appunti scritti a penna, e gli annunci sottolineati possono suggerirci quale tipo di persona aveva comprato il giornale e perché, se per cercare lavoro, casa o qualche oggetto di seconda mano. A volte riesco ad estrapolare anche i gusti sessuali di chi ha consultato i “matrimoniali”.
Restammo a parlare per ore e ore facendo discorsi di ogni tipo; spiritismo, religione, politica, vita, era una specie di “tuttologo”.
Quando si alzò per uscire mi accorsi che zoppicava ed era giù di peso. Lo accompagnai alla porta e vidi che il tempo si era rimesso, anzi, c'era un sole fortissimo e un caldo da Agosto fiorentino.
Quella fu la prima e l'ultima volta che lo vidi. A quanto pare non aveva mai abitato in quel paese né in altri vicino. Spesso pensai che forse mi ero imbattuto in un fantasma, dal momento che soltanto pochi giorni dopo il padrone dell'osteria non si ricordava né di me né di lui. Più vero-similmente era soltanto un mistificatore, il classico cacciaballe.
L'unica cosa che è rimasta di quell'incontro è questo testo che ho scritto per la mia probabile ultima canzone. Quando tornai a casa, nel mio paesino, riconobbi che quella vita non faceva più per me. La musica mi aveva dato tanto, è vero, ma mi aveva anche privato della mia vita, del mio modo di concepire la vita. Ero rimasto in letargo per parecchi anni senza rendermene conto. Non ch'io ora disprezzi la musica in quanto tale, ma piuttosto m'infastidisce la concezione che di lei ha il mondo, quello dei giovani ma anche quello di certi adulti.
Fu allora che iniziai a scrivere non più per la musica ma per me stesso. Scrivevo dei romanzi che mi permettevano di occuparmi la giornata. Non avevo velleità artistiche letterarie, non me ne fregava niente di entrare a far parte di un altro tipo di mercato artistico, fatto solo per vendere le facce, non certo per arricchire i cuori. Scrivevo così, per dar corpo ai miei pensieri.
Fu per questo mio nuovo interesse d'idolatra letterario che conobbi Francesca. Lei, come me, amava leggere, e fu proprio in una libreria che feci la sua conoscenza. Ormai non mi aspettavo più nulla dalla vita, e tantomeno che lei avesse in serbo per me qualcosa di molto simile all'amore. Ero riuscito a diventare ciò che avevo sempre aspirato essere; un disilluso.
Francesca dunque. Anche lei aveva l'aria della studentessa fuori corso. Biondina, occhialini, sguardo ingenuamente azzurro, nasino all'insù stupendo, belle gambe da donna adulta malgrado non lo fosse, gonna stretta appena sopra al ginocchio, camicetta bianca con piccoli bottoncini color perla, nessun interesse per ciò che le girava attorno, e movenze da piccola liceale in vacanza. Ma quest'ultime sembravano non appartenerle. La sua parlata, da quanto era “accennata”, abbozza-ta, pareva presa a nolo, e che lei avrebbe dovuto restituirla fra breve.
Subito caddi nella mania di giudicar le persone e pensai: “Questa non è padrona neanche di diri-gere il suo passo”.
Mi sbagliavo ancora. Era soltanto la solita ragazza semplice che aveva la solita vanità di farsi guardare, che probabilmente aveva fatto, e forse ancora faceva, la spesa a sua madre, che andava in centro, per vetrine di negozi, che credeva di avere visioni assolute delle cose e la convinzione necessaria per confondere la Psicoanalisi col “Vangelo secondo Freud”.
Francesca somigliava al mondo.
Io ero in quel periodo in cui, convinto e persuaso dall'idea di bastarmi, non ricercavo alcun tipo di compagnia. Le mie voglie erano altre. Le donne mi piacevano ancora, ma non credevo nella loro duttilità, e nemmeno nel bisogno che di loro il mio corpo, ogni tanto, reclamava. Si sa, ci si abitua a tutto, perfino all'astinenza sessuale. Sono certo che se non fossero esistite in quel periodo non me ne sarei neanche accorto.
La conobbi in quella libreria e la rividi la sera stessa. Francesca era una donna curiosa. Quella sera, dopo aver mangiato e bevuto, ci dilungammo in chiacchiere, fino a che, verso le undici, lei saltò su e disse che doveva scappar via.
- E perché? - chiesi io - Non è mica così tardi!
La gelosia è un violino tzigano che suona note dissonanti richiamate direttamente dall'Inferno, e che su noi, sebbene ne sappiamo la provenienza, hanno un effetto incantatore che ci travolge, e non è tanto raro, guardando la donna che non amiamo più mentre bacia il suo nuovo uomo, esser scossi da quella gelosia melodiosa che ha la potenza di farci innamorare di lei. Magari per la prima volta. Lo troveremmo strano, allora, e forse ci rammaricheremmo di non essere riusciti ad amarla come meritava.
- Lo so, ma non vado a casa. - rispose lei.
- E dove vai, allora?
- In un posto speciale. Puoi venire anche tu se vuoi. Vado al “Picco”, a vedere i treni che passano.
Quella sera ripresi a guardare la vita con l'animo del mondo. Certo, con frivolezza, con poco realismo e con la convinzione che, volutamente distratti, in fondo si possa anche vivere bene. La semplicità di Francesca m'insegnò a non dar troppo peso a quel genere di situazioni e di comportamenti che si vedono in giro. Imparai a non fissarmi sulle altrui vanità, su egoismi e presunzioni, e trovai quel distacco necessario per sopravvivere senza martoriarmi il cuore.
IN SILENZIO
Quel che ci sembra l'apoteosi della felicità, il preludio al paradiso, può in un'attimo cambiare per diventare severo, tirannico, persecutore. La vita non si farà mai apprezzare come dono divino fino a quando non saremo noi, rifiutandola lasciandoci socialmente morire, a metterle addosso la frenesia di riconquistarci. E ciò che fino ad allora ce l'aveva con noi, era tignosa, sorda alle suppliche, aveva spocchia da vendere, la vita, ecco che diventa una tenera bimba, ci tira per la giacca, c'invita a giocare con lei, ci promette mille fedeltà come un'innamorata pazza. Ma pare che poi nessuno l'abbia vista mai, quest'innamorata pazza. E' vero, poco ce ne importa. Anche se le sue promesse non vengono mai mantenute, sembra che il solo fatto che ce le abbia fatte ci basti. Così ci facciamo convincere da lei. Così ci facciamo comprare come per quattro soldi si fanno cor-rompere i traditori. Così ci facciamo battere e riconquistare dal suo sinistro fascino. Sconfitti ci facciamo strappare, senza reagire in alcun modo, al nostro piccolo rifugio fatto di sogni e di ricordi.
E' in questo modo che si diventa “alienati mentali”.
Iniziamo a rifiutare tutto, il dolore è troppo grande, ad isolarci, perché sebbene vinti, sia dentro che fuori, siamo orgogliosi, e non vogliamo che il nostro cervello e la pubblica opinione ci conside-rino complici di quella che ora riteniamo essere “la nostra perduta vita”.
Sì, perché la nostra vita, e tanto più la nostra vita amorosa, è un cumulo di grano che si presta ad essere trebbiato, e il nostro successo consiste in gran parte nella capacità di convivere con l’eterogenesi dei fini, la nostra, quella interiore, e l’eterogenesi altrui. La compatibilità di una coppia, il loro successo amoroso, dipende esclusivamente da tale capacità di adattamento. Sap-piamo vivere con una donna quando lei non c’impone il suo pacchetto di diversità, e quando noi riusciamo a sopravvivere al nostro.
Non è un lavoro facile, questo, perché molto spesso ci succede di partire per raggiungere un luogo e invece ci ritroviamo in un altro. La delusione allora ci può conquistare, e l’amarezza segnarci in modo determinante la vita. La sola cosa che ci salva è la forza di sorriderne. Solo così riusciamo a sopravvivere alla delusione di un obiettivo mancato.
Non avevo più pensato alla possibilità di farmi una vita normale, con moglie, figli, casa e beghe famigliari. Non ho problemi econo-mici e quindi neppure la necessità di lavorare. Sposai Francesca e continuammo a vivere alle Cinque Terre. Il passato non influisce più di tanto sul tempo che mi resta da vivere. Ogni tanto suono la chitarra, quasi sempre per gli amici del paese, ma più che altro scrivo. Scrivere mi diverte parecchio.
Gli sfoggi di vanità non m'infastidiscono più tanto. Ho imparato a non farmi toccare da certi atteggiamenti, anche se non ne posso essere sicuro fino in fondo (perché Monterosso è un piccolo paesino), credo di essere “guarito” dalla mia sofferenza. Oggi, quando ricordo le serate al locale, sorrido e tiro avanti.
Qualche volta mi capita di pensare a Marta e al bambino, e quei ricordi non sembrano bruciarmi troppo. Arrivano così, in silenzio, e sempre in silenzio se ne vanno. L'unica cosa che sono in grado di causarmi è una leggera e vaga pena, che non trovando posto nel mio cuore, va subito ad angosciare qualcun altro in qualche altra parte del pianeta.
Con Francesca usciamo spesso, anche senza scopo. Ci divertiamo a girare per i monti a strapiombo sul mare. Ci piace entrare a far parte di un paesaggio, come quello ligure, unico nel sul genere. In Francesca adoro la discrezione, il suo presentarsi a me senza chiedere nulla in cambio. Sovente penso che la mia sola presenza le basti. Lei è in grado di appagare tutti i miei pruriti cardiaci e io non le chiedo altro che non sia questo lasciarsi amare così, sempli-cemente, senza particolari bramosie. Lei sembra averlo capito.
Dopo non molto tempo che stavo con lei sentivo che qualcosa ancora mi mancava, anche se non ci facevo troppo caso. Finché un giorno Francesca entrò in casa e disse:
- Aspetto un bambino.
Il silenzio che riempì l'appartamento dopo quell'affermazione era la vera colonna sonora della mia vita. Rimembrante cercai di buttar fuori tutta la felicità di cui ero capace per far sentire a Francesca che non era sola, che quel figlio lo avremmo condiviso.
Chissà, forse Maurizio, mio figlio, è proprio quel bambino che ritorna.
Ho paura di credere che questa sia la felicità, non ci sono mai stato granché abituato. Quel che faccio è cercare di vivere appieno tutto ciò che arriva, e sforzarmi di sentirne il gusto. Forse solo così riuscirò a convincermi che finalmente un po’ di gioia è toccata pure a me, anche se non dimenticherò mai la prima volta che vidi Marta.
fine
I.
Non dovete credere che Marta fosse una donna cattiva, era solo un individuo comune, uno di quelli con cui abbiamo a che fare tutti i giorni, che vedono il mondo, l'umanità, in maniera piatta, e che sono convinti che ogni cosa esista solo perché ci sono loro da soddisfare.
Non bisogna essere particolarmente meritevoli per avere in vita il privilegio di non arrabattarsi, ci può solo capitare in sorte, e dovremmo prendere tutto così come viene.
Purtroppo, però, non tutti sono capaci di tralasciare quest'evidente fatto. Di questi individui tanti possono apparire cattivi, ma non sono altro che dei superficiali, personaggi che non se la sono mai passata male e non capiscono cosa sia soffrire davvero. I loro dolori non riguardano che le cose futili della vita, e non hanno mai avuto la costrizione di risalire dal fondo.
Su queste persone, più che su altre, può far presa la tentazione di divenir vanitosi, poiché non v'è vanità dove c'è povertà o carenza di mezzi, ma solo dove c'è spensieratezza e ci si può attaccare ai piaceri futili della vita godendone. Per tali individui quello che più conta sono le apparenze, le cose esteriori, e non sono più capaci di tornare indietro quando danno valore supremo alla forma. I contenuti sono qualcosa che non li riguarda, poiché essi non si vedono, e la vita è troppo breve perché ci si perda dietro serietà e cose che non fanno godere nell'immediato.
Un vanitoso, tuttavia, non è mai consapevole del suo godere di nullità. Per la sua superficialità le cose futili di cui gode sono certamente le più importanti, e non è disposto a rinunciarvi anche se vede da vicino il dolore che provoca. Quando un vanitoso gode nell'indossare l'abito appena comprato, il piacere che prova non è tanto nel presentarsi elegante e nel godere d'essere osservato sapendo di stare bene, di avere un bel portamento, ma nel proiettare in un futuro prossimo il compiacimento provato, compiacimento che somiglia molto ad un bel voto preso dopo aver dato un esame, e che, nelle sue fantasie di superficiale, lo innalza ad oggetto di desiderio generale.
Un vanitoso si compiace scarsamente dei motivi per cui ha lavorato per essere guardato, perché la linea immaginaria di demarca-zione che segna il suo “confine d'ambizione” si sposta sempre più avanti, e se in un gruppo egli diventa l'attrazione, il centro gravitazionale dell'attenzione, non se ne compiace che per poco tempo, poiché, come il cacciatore mangia la selvaggina che ha cacciato, il vanitoso brucia la sua conquista in un breve periodo, passato il quale sente il bisogno di conquistare qualcun altro.
Il vanitoso ha la necessità di rinnovare continuamente il proprio compiacimento, e, per gli stessi motivi per cui i mariti si cercano un'amante, perché sanno di piacere alle proprie mogli, questo non può accadere con persone di cui sa già d'essere tenuto in grande considerazione.
Questa superficialità dilagante non poteva che venir fuori in questo tempo, dove l'immagine, come dice una pubblicità, è tutto. In questo mondo ogni cosa si fa per vanità, e non solo rimirarsi allo specchio, ma perfino dichiarare guerra. Il concetto di modernità è un parametro fissato sulla visibilità dell'individuo, tanto che oggi gli uomini che non sono maestri a far denaro sono considerati sempre e comunque dei falliti.
Molti anziani dicono che i giovani non hanno perso i valori, ma hanno dei valori diversi, che gli adulti non riescono a capire. Si sa, quando non ci sono più possibilità fisiche non rimane che la lusinga. In realtà i valori dei giovani d'oggi si appoggiano su due vocaboli, “modernità e progresso”, di cui si è stravolto il significato, finendo per dargliene uno più alto e nobile di ciò ch'essi in effetti hanno.
Capire questo ci fa pensare a quanto gli uomini siano superficiali, tutti presi da sé stessi, e a quanto non si accorgano assolutamente di far convergere il loro modo di vivere su un malinteso, finendo per dare alle cose futili un valore sproporzionato alla causa.
Questo modo di ragionare non è affatto innocuo. Non è raro vedere oggi che le grandi tolleranze, le libertà di scelta, le autodeterminazioni, portino spesso a cospicui egoismi che non hanno ragioni visibili e causano più mali di quelli che si vorrebbero curare.
Marta non era molto diversa dal mondo in cui viveva. Tante volte è quasi impossibile rifiutare il modernismo senza caderne vittima. Chi non è d'accordo si deve adattare e riciclarsi, altrimenti non avrebbe spazio nella società e nelle sue considerazioni. Ma gli altri? Intendo dire, i “normali”, cosa devono fare?
Era l'esatta situazione in cui mi trovavo io. Avevo sbagliato tutto? Stavo diventando una specie di ossimoro? E chi era in grado di dirmelo? di dimostrarmelo?
Se ci fosse stato qualcuno capace di dimostrarmi che stavo sbagliando io ne avrei gioito. Sono sempre stato abbastanza umile da accettare i rimproveri senza offendermi, perché chi si offende per un rimprovero dopo aver sbagliato sbaglia due volte, ma non trovai mai questa sorta di uomo.
Lo sbaglio di Marta stava proprio tutto nell'errata convinzione che il moderno fosse, chissà per quale sorta di ragionamento, sempre e comunque meglio dell'antico, e il “progresso” l'unica risposta possibile ai quesiti posti dall'umanità. Ma nel far questo non era diversa dal mondo. Si crede di volare di continuo, quando si scopre come modificare i cibi geneticamente, una medicina nuova o un modo per velocizzare la comunicazione, ma non si capisce che in realtà più che volare si sta precipitando.
Anche i miei amici del gruppo erano così.
Appena vedevano uno strumento nuovo, quei tipi di tastiere che producono più suoni di quanti ve ne siano all’Inferno, volevano usare sempre quello, e se gli facevi notare che il suono della “dodici corde” era più bello e più universale, loro rispondevano che bisognava saper e dover usare quel che la Tecnologia ci metteva a disposizione.
Ma ciò che ritengo essere le mie pecche non si limitano soltanto a questo “inadattamento alla modernità e al progresso”, ma più a quelle cose passate con Marta che continuo a portarmi dietro come piccole sorelline, anche se la diagnosi precisa mi sfugge. Non so dire se Marta fu soltanto il veicolo per cui i miei difetti, o pecche, o casini, o problemi, o come volete voi, trovarono libero sfogo, o se quegli stessi difetti me li avesse attaccati lei. Si sa, se un individuo continua a frequentare assiduamente una persona, come io vedevo Marta, è quasi impossibile essere immuni dai suoi comportamenti. Anche se non ritengo di essere particolarmente influenzabile, non ho la presunzione di essere per nulla penetrabile, ermetico.
Spesso mi accorgevo che quelli che chiamavo “riflessi condizionati” erano condizionati dal mio rapporto con lei. Mi rendevo conto, per esempio, che certi modi di fare, alcune frasi, modi di dire, molti gesti, non erano propri del mio bagaglio mimico o dialettico. Ma chissà se è proprio così. In genere siamo proclivi a pensare che l'ereditarietà e l'epidemie riguardino solo le stronzate, mai l'intelligenza o la genialità.
Il più delle volte ci convinciamo che le nostre pecche non siano completamente una colpa nostra. Come persone di poco conto crediamo che siano gli altri a portarci a fare certe cose, a costringerci a tirar fuori alcuni comportamenti, e così finiamo per essere poco responsabili.
“Paura del contrappasso”, mi diceva Maurizio quando ne parlavamo. Forse aveva ragione lui, perché ogni giudizio sotto il quale veniamo posti ci fa paura e lo consideriamo un'ingiustizia, qualcosa di troppo grande da sopportare per il male che riteniamo d'aver fatto, e così l'unica via di scampo che ci resta è discolparci accusando gli altri.
Ogni tanto ripenso a Marta, all'aborto, e penso che tutto doveva andare così, che per la mia pecca nel ritenere importante la storia con quella ragazza, per forza di cose, doveva accadere qualcosa di veramente grave, altrimenti non ci saremmo lasciati mai. E chissà se mai ci saremmo lasciati se invece che scappare via fossi rimasto lì a discutere con lei del suo gesto. Quasi sempre è improvvisando che riusciamo a cogliere soluzioni definitive.
Ma anche quando penso a queste cose, solitamente, dopo un paio di minuti mi ricredo, e sono convinto che dare al Destino più responsabilità di quelle che in effetti ha, sia sempre una questione di mancanza di coerenza e serietà. Così faccio nascere dentro di me quel realismo utile che mi convince di quanto tutto dipenda da noi.
Il Destino non c'entra niente, il Destino non esiste.
Credo che se non mi accorsi subito di come Marta era fatta, la responsabilità fu mia e solo mia. Non volevo ammettere a me stesso di essermi sbagliato, forse perché ero innamorato di lei. O probabilmente per una questione di orgoglio.
Che ridere. Siamo talmente orgogliosi che la sofferenza è l'ultimo dei sentimenti che vogliamo mostrare a chi vuol farci soffrire. Così resistiamo, fino a quando ci succede qualcosa di enorme. Così tiriamo avanti, magari fino all'angolo di un palazzo, o, come avevo fatto io, fino all'auto di un amico, e lontano dallo sguardo del nostro vessatore ci sciogliamo dentro quelle lacrime che, appese ai nostri occhi come panni stesi, non vedevano l'ora di potersi liberare.
Allora mi convinco che Marta abortì anche per colpa mia, per la mia incapacità nel persuadere le persone, per la mia poca determinazione nell'impormi. Chissà, forse era la sua presunta forza ad inibirmi.
Oggi si fa un gran parlare di “calo del desiderio” dell'uomo. Questo è vero, ma se succede è perché l'uomo portava in sé l'animo del padre, un animo che nelle intenzioni voleva essere quello del protettore, e vedeva nella donna la possibilità d'innalzarsi a qualcosa di più elevato del semplice ruolo di amante. Se l'uomo desidera sempre meno la donna è perché lei si è fatta in quattro per diventare sempre più forte, ed ha finito per perdere la prerogativa per cui noi l'ama-vamo; la sua debolezza. Oggi le donne non sono più capaci d'essere fragili. E' per tale ragione che capisco gli omosessuali. Le donne ci somigliano a tal punto che quasi non esiste più motivo di scelta. Oggi gli uomini non scappano dalle donne perché ne hanno paura, luogo comune come tanti, ma perché al loro fianco si sentono inutili.
Io avrei voluto proteggerla dal mondo, ciò che Marta invece non desiderava. Sì, perché era convinta di essere lei stessa il mondo. Così scadevo nell'ignavia, nell'acèdia. Il solo pensiero che lei potesse avercela con me per un qualsiasi banale motivo mi faceva venire la smania e l'ansia di appianare tutto, di far la pace, trasformandomi in un ributtante cerchiobottista, un acquiescente senza nerbo né vitalità. E allora, per riconquistarla, per sentirmi amato, per essere felice, mi svendevo. Lei mi comprava immediatamente, perché senza di me la sua vanità non avrebbe avuto alcuna ragion d'essere.
Vanità. Quale uomo, oggi, se ha il coraggio di porsi la domanda “Perché la mia donna sta con me?”, non si accorgerà che ci possono essere mille altre ragioni (quali l'automobile, il conto in Banca, la posizione sociale, la libertà che Egli le concede) che sono distanti dal motivo principale: “Perché mi ama, perché gli piaccio”? Il guaio di noi uomini oggi, è che confondiamo i nostri possedimenti materiali, ciò per cui nove volte su dieci veniamo apprezzati dalle donne, con pregi e virtù delle nostre persone. Che ingenui siamo!
Una volta i matrimoni duravano una vita. Perché? Perché non c'era il divorzio? Perché erano combinati? E allora? Oggi sono “scombinati”! No amici cari, non è per queste ragioni, ma perché dietro al motivo del piacersi e dello stare bene insieme non ce n'erano altri. Una donna si metteva con te, e se voleva ti sposava, perché ti conosceva bene e sapeva di non doversi aspettare altro oltre ciò che eri in grado di darle, sia in meglio che in peggio. Il rapporto era sincero in tutte le sue fasi.
Oggi tutto è cambiato. Gli uomini sono diventati dei cani rognosi che sbavano dietro la “dèa-cagna” del successo perché credono che una volta raggiunto la loro vita sarà più facile, e sono circondati da vere e proprie cagne che si fingono in calore per conquistarli e godere surrettiziamente di quelle celebrità e di quelle ricchezze. Oggi vediamo che le dive del cinema o le starlette televisive non sposano mai un manovale edile, ciò che invece non succede agli uomini, che non guardano mai al conto in Banca o alla posizione della donna che si sposano. Perché le donne lo fanno? Forse perché, data la loro fama, hanno a che fare solo con uomini ricchi e famosi? Per amore? Non fatemi ridere, per favore.
Il successo, il denaro, sono sinonimo di potere, e la donna ricerca il potere per avere certezze assolute. Quasi mai le trova in sé stessa, e allora non le rimane che ricercarle nell'uomo.
Questo ragionamento, che le donne, pur non dichiarandolo apertamente, fanno, è l'esatto con-trario dell'emancipazione e della libertà.
Molte donne, anche sposate, guardano la Tv, e vedendo uomini affascinanti accompagnati da “donne costose”, proiettano le loro fantasie nello schermo per partecipare a quelle cerimonie mondane, abbacando, speranzose, d'essere, un domani, loro stesse quelle “donne costose”. E in questo “delirio onirico senza ritorno” si trascinano dietro i loro uomini, che terrorizzati dall'idea di perderle si fanno in quattro per accontentarle. Quasi mai ci riescono, perché quella vanità non ha confini visibili, e l'appagamento di un desiderio è solo il presupposto per farne nascere uno più grande. Così, per tali deliri che fanno crescere incredibili sollettichìi nel cuore, celati dietro un'altra grande menzogna, quella della libertà, si sfasciano allegramente le coppie, e oggi non è difficile vedere pezzi di famiglie sfasciate che si uniscono ad altri pezzi di famiglie illudendosi di formarne una sola, e dove presto inizieranno licenziosità verso i genitori, frutto di equivoci libertari, rinfacciamenti, gelosie, invidie, vere e proprie battaglie interne senza esclusione di colpi fra figli e figliastri, padri e patrigni, madri e matrigne, e il risultato sarà un più che naturale fallimento. Tutto perché?
Oggi la vanità ha partorito una precarietà che ha invaso ogni strato e disciplina della vita (ed è ritenuta addirittura una cosa giusta), tanto che perfino chiedere spiegazioni è considerato un comportamento stupido, antico, poco moderno.
Insinuate in qualsiasi strampalato cervello che il vostro modo bizzarro di vedere le cose sia originale, nuovo e moderno, e chi era ad un passo dal prendervi per scemi rivaluterà ciò che avete appena detto e si convincerà di avere a che fare con una mente sofisticata e arguta.
Il problema è che questo ragionamento ogni volta viene tacciato di maschilismo, di misoginia, mentre invece è solo un'analisi logica dell'odierna situazione. Naturalmente nulla è genera-lizzabile.
Diciamoci la verità. Oggi gli unici uomini coraggiosi sono quelli che hanno la faccia per dire di “no” alla loro donna quando questa gli chiede un regalo o un po’ più di libertà di movimento. Sono co-loro che non si vergognano di dire pubblicamente che l'omosessualità non è una cosa normale, perché se fossimo tutti “normali” come gli omosessuali il mondo finirebbe domani. Sono coloro che hanno il coraggio di dire che l'aborto è un omicidio, che i principìi fanno a pugni con le tolleranze. Questi, che una volta erano definiti “conformismi”, oggi sono gli unici comportamenti davvero originali, fuori dal coro.
Siamo talmente assuefatti alle stravaganze, che ormai facciamo passare tutti coloro che ancora hanno il coraggio di combatterle come degli “stupidi idioti”. In realtà “quell'idiozia” è solo ragionevo-ezza. Il timore di essere tagliati fuori dal “pensiero vigente” ha prodotto una tolleranza universale che darebbe fastidio anche a Voltaire. Ma gli “anticonformisti di origine statale”, coloro che sono contro tutto e a favore di qualsiasi cosa, non la pensano allo stesso modo.
Se tutto questo credete sia un'esacerbazione del discorso, significa che non avete mai avuto a che fare con una persona fresca di Laurea. Individui che portano faticosamente sulle spalle anni di nozioni, che vorrebbero vedere il loro stile di vita assurto a modello universale, che non riescono a staccarsi da quei tre o quattro parametri di giudizio che hanno assorbito a scuola e che li rende completamente privi di capacità astrattive. In realtà non sanno nulla della vita. Le uniche tre cose che hanno imparato sono come far valere il loro titolo di studio davanti agli altri, come sfoderare quell'anticonformismo piatto e convenzionale che li rende scontati ancor prima di aprire bocca, e come fare soldi alla svelta. Sono loro, gli Anticonformisti di Origine Statale, a far passare quella falsa emancipazione per qualcosa di normale, solo un buon “cambiamento” da tollerare. Del resto il mondo gronda d'ignoranti con la Laurea.
Cristina, una ragazza di Giacomo laureata in Giurisprudenza, leggeva i miei testi e si permetteva di correggerli aggiungendo le congiunzioni in alcuni passi. Non sapeva cos'è un asindeto.
Quante volte mi sono chiesto quale assurdo piacere Marta poteva provare a recitare quella parte nella nostra fottuta storia. Negli ultimi giorni della nostra relazione le dicevo spesso che il suo comportamento mi ricordava quello di Madame de Creçy, la Odette de “Alla ricerca del tempo perduto” di Proust.
All'inizio sembrava smaniosa di passare tutto il suo tempo libero con me, di parlarmi, di baciarmi, di farsi piacere, poi, con una drammatica inversione a “U”, cambiò drasticamente atteggiamento. Divenne isterica, mai disposta a lasciar perdere e rissosa. Forse si era resa conto d'aver sbagliato scelta, che se si fosse buttata su qualcuno dei miei compagni la sua vanità ne avrebbe usufruito me-glio, più compiutamente. O probabilmente fu l'atavica convinzione delle donne, di certe donne, secondo la quale quando un uomo è conquistato lo è una volta per tutte e non serve più dimostrargli nulla.
Ma forse somigliava più a Rachel, la fidanzata-amante di Robert de Saint Loup. E cosa mai avrei dovuto dire io? Marta “allor che Iddio”?
Oggi che posso dire di essermi liberato della presenza silenziosa della vanità che Marta si portava addosso, non solo mi sento meglio, ma anche più pulito, più pulito, intendo dire, coscienziosa-mente, ciò che forse in passato non sono mai stato. E' bizzarro come a volte siano le situazioni peggiori a farci ricrescere l'amore per certi sani principìi.
Dopo l'aborto pensavo di aver chiuso a Marta ogni porta, ma mi sbagliavo. Quando capì il successo che avevamo avuto tornò all'attacco. In maniera subdola e strisciante, ma riprovò ad ammaliarmi.
II.
Subito dopo la nostra rottura immaginavo (e forse speravo) che lei, sebbene in un modo tutto suo, mi amasse ancora, che desiderasse vedermi. Infatti seppi che andava nel locale, che io non frequentavo più, e alcune volte era stata vista perfino fuori dalla sala prove. Così premeditai una puerile vendetta che si risolveva tutta nel privarla della mia presenza. In verità non potevo sapere quanto lei ne soffrisse, perché la presunzione d'infliggere del dolore alla persona amata togliendole il piacere di guardarci si basa, come nel mio caso, sulle passate ammissioni d'amore che lei ci ha fatto, ammissioni che, a quel punto giunti, non sapevo quanto considerare attendibili, giacché se vere fossero state lei non avrebbe buttato tutto all'aria solo per poter continuare ad appagare la sua vanità, il compiacimento di essere guardata dagli altri, desiderata.
Presupposto necessario per infliggere pene d'amore è proprio l'Amore, e io non sapevo quanto ancora Marta mi amasse. Ripagare con la stessa moneta un torto subìto non è sempre garanzia di vendetta compiuta, perché ciò che ferì noi si appoggiava allora sul nostro sentimento, sentimento che non siamo certi ci sia nell'oggetto della nostra rivalsa, e su cui dovrebbe basarsi il dolore che vogliamo infliggere.
Così presi ad evitarla. In un certo senso mi sentivo vincitore, cosa che quando stavo con lei non mi era successa che sporadicamente, solo in certi episodi. Per esempio.
Quando avevamo una discussione e, una volta tanto, ero io spuntarla, era come se lei perdesse dei pezzi, che le cadesse qualcosa di cui io, anche se non capivo cosa, mi accorgevo. In quegli istanti mi appariva come se fosse stata nuda. Mi ero accorto che lei stentava a ritrovare questi pezzi, e che era solita chiudersi in casa per qualche giorno, come se avesse dovuto dare il tempo a quella sorta di “appendici” di rinascere, di ricrescere. I pezzi che perdeva potevano essere la sicurezza come un unghia. Infatti non c'era differenza visibile fra il fisico che mostrava al mondo e le sue caratteristiche intellettuali, tutto era appiattito dalla vanità. Naturalmente soltanto a distanza di tempo mi accorsi di queste sfaccettature.
Un giorno arriva una telefonata a casa mia. La mia colf mi chiama e dice che è per me, “una certa Marta”. Fui tentato di non rispondere, ma poi, vinto da quella curiosità che porta i Ricercatori a testare su sé stessi un vaccino che hanno appena messo a punto, strinsi la cornetta fra le mani e chiesi: “Cosa c'è?”
- Calma, - disse lei - bel modo di rispondere.
- Senti, o parli e mi dici cosa vuoi o metto giù.
Non si agogna mai così tanto di risultare antipatici come verso la persona di cui siamo innamorati e che, pensiamo, non ci ricambia. Ma probabilmente non lo facciamo apposta, è solo un modo di difenderci dalla sua indifferenza. E' proprio la consapevolezza di non riuscire a far breccia nel suo cuore che ci rende antipatici.
- Ho chiamato per dirti che ho della roba tua da ridarti, e che, se non sbaglio, anche tu hai qualcosa che mi appartiene. Volevo anche parlarti, chiederti alcune cose.
- Credo proprio che non abbiamo niente da dirci. – risposi io infastidito dal tono riappacificatore della sua voce.
- Va bene. Ma voglio la mia roba. Possiamo vederci?
- Alle quattro al monumento.
“Al monumento”. Perché le avevo dato appuntamento in quel posto? Era lì che Marta mi aveva detto d'aver abortito mio figlio. Forse, inconsciamente, volevo riportarla nel “luogo del delitto”. O chissà se non volevo riprendere tutto da dove l'avevamo lasciato, come se ancora non fosse accaduto nulla, come se lei fosse ancora incinta.
I luoghi comuni fanno talmente parte di noi, che alcuni individui, raccogliendoli in un unico catalogo Estate-Inverno, li hanno fatti diventare una scienza battezzandoli col nome di “Psicologia”.
Non ebbi neppure il tempo di riattaccare che già mi stavo rimproverando il fatto d'aver ceduto. Ripromettendomi di non farmi ammaliare dalle sue moine, mi vestii e poco dopo ero giù in strada. Facendo quei quattro passi che mi separavano dal luogo dell'appuntamento mi tornarono alla memoria alcune sue critiche sulla nostra musica. Critiche che avevo inteso nascondessero, occultate nel profondo dello stomaco, stupide gelosie e inutili invidie.
Solo quel giorno capii che quelle critiche non erano frutto d'invidia furba, ma di mal celata ignoranza musicale. Marta era una di quelle persone, che la dispensazione nozionistica negropontista nutre a colpi di dischetti e “Malinformatica”, che non sapendo di cosa tu stessi parlando e non avendo il coraggio e la capacità di ammetterlo, cercava di apprenderlo dall'espressione della tua faccia o provando a farti finire le sue frasi che poi lei avrebbe cercato abilmente di accompagnare unendosi alla tua voce, dando vita ad una specie di coro a due, e sottintendendo che voleva dire proprio quello. Perché non riusciva semplicemente ad ammettere: “Di tecnica musicale non me ne capisco?”
Sgambettai velocemente con in mano il sacchetto pieno di quelle cianfrusaglie che lei aveva usato come scusa per rivedermi. Infatti non avevo nulla di così importante che le appartenesse. Misi dentro quel sacchetto anche alcuni dei suoi regali, futili oggetti che, secondo il suo strampalato cervello, avrebbero dovuto dimostrarmi tutto il suo amore, ma che, in quanto oggetti, erano affettuosi esattamente come la mia lavatrice o il mio tagliacarte.
Sono sempre stato convinto che di modi per tradire grondi il mondo. Basta saper scegliere. La rabbia che proviamo quando la nostra donna ci tradisce non ha come spunto il tradimento in sé, ma più un corollario scenografico che abbiamo stampato nella nostra mente, e, in quell'allestimento, il tempo che abbiamo impiegato per far sì che quella donna diventasse “la nostra donna”. Vedere che tutti quegli sforzi fatti sono stati vani ci preclude il raggiungimento di ogni ragionevolezza. Ci sentiamo persi, presi in giro. Da qui ne può scaturire una pericolosa voglia di rivalsa verso le donne in genere che ci trasforma in stupidi maschilisti fuori luogo. Ma non è tanto vero che “chi disprezza compra”, quanto che chi ora odia in verità è perché ha amato sperare ed è stato deluso.
Le pagine scombinate della nostra vita ci pongono dinanzi doman-de angosciose; cosa deve fare un individuo perché la sua vita abbia quella tranquillità a cui Egli aspira? Cosa deve fare per tenere saldo il filo sottile che lega come un pacco unico tutto ciò che ha costruito? Cosa deve fare perché la sua donna sia felice per ciò che lui può regalarle? Cosa deve fare per essere sicuro di essere amato, per avere la certezza che la sua donna non lo tradisca, incredibilmente, solo per vanità?
Io non volevo per fidanzata una dèa o una regina, ma una donna sincera, che magari mi odiasse, se solo l'avessi meritato, una donna onesta, che oggi può sembrare addirittura originale, una donna che prima di abortire si chiedesse, perfino trovandolo convenzionalmente bizzarro, per quale motivo non poteva restarmi fedele.
E’ a questo punto che i miei principìi vacillano. Di tanto in tanto, infatti, mi domando se per caso non sia io a voler credere a tutti i costi d’essere dalla parte della ragione, come un demente, un integralista. La mia certezza d’aver fatto tutto il possibile mi mette in un stato di presunta onnipotenza intellettuale che mi priva della ragionevolezza. Do per scontato che la ragione sia dalla mia, e che agli altri non rimanga che da dividersi il torto. Ma quanto è vero questo? Non lo so più.
Se tutti noi, uomini e donne, riuscissimo ad amare in modo per-fetto, se ne fossimo capaci, non sentiremmo più la necessità di allontanarci da casa. Tutto ciò che ci serve è lì! Il guaio è che oggi non basta più difenderlo con l'amore, verso la propria donna, verso i propri figli, verso i propri principìi, verso la propria casa, con l'amore per la verità, per la sincerità. Dovremmo cercare qualcosa d'altro, magari non così frammentario, magari non così provvisorio. Ecco, forse una fedeltà più propria, personale, completa, meglio se più verso noi stessi che verso il mondo, ci renderebbe meno sofferenti e più forti.
Anche davanti alla morte.
Sono un paranoico? Un pauroso aggrappato con le unghia e con i denti ai miei pezzetti bruciati? Forse. O forse sono solo realista.
La felicità che ogni persona ricerca non è che un miraggio, ma un miraggio a tal punto reale che ci sprona a considerare tutta quella “spedizione” come un normale lavoro di assemblaggio delle nostre possibilità. La verità, purtroppo, è che riusciamo a confutare solo la felicità degli altri, mai la nostra, perché ogni obiettivo raggiunto si trasforma immediatamente in un trampolino di lancio verso qualcosa in più, e la meta che abbiamo occupato e che un giorno non lontano agognammo conquistare, subito viene da noi scordata, perfino nei nostri desideri, perfino nelle nostre speranze.
Pare proprio che ai nostri occhi solo gli altri possano raggiungere la felicità, mentre la nostra si muta continuamente da obiettivo a punto di partenza per nuove conquiste.
La vidi da lontano, e spigliatamente mi avvicinai. Marta mi guardò. Anch'io la guardai, facendole capire di non temerla. Ci fissammo per alcuni secondi, che parevano durare ore, senza dire una parola. Sembravamo la vittima davanti al suo carnefice. All'improvviso capii il motivo di quel mio fissarla; volevo imprimermi nella mente la faccia di colei che mi aveva privato della responsabilità di essere padre.
Ad un certo punto allungò un braccio e mi toccò una mano. Mi sfiorò con una tale leggerezza che mi parve addirittura esagerata, quasi avesse paura di farmi ancora del male, e con quell'umiltà che si riscontra in certi moribondi che, rendendosi conto nel momento supremo della morte di essere stati dei peccatori, chiedono perdono al loro Dio col sacro timore d'infastidirlo.
- Perché è successo tutto questo? - disse piano, quasi sottovoce, con gli occhi che, staccati dal mio sguardo, adesso fissavano l'asfalto - Perché siamo arrivati a tanto? Noi ci amavamo!
Vidi in lei il rimorso e non risposi. Non avevo il coraggio di parlarle. Forse perché mi ritenevo scarsamente dotato nella proprietà del linguaggio e avevo paura di riaprire quel contenzioso senza la garanzia di non soccombere. O forse per un dolore troppo grande da sopportare. Subito le lacrime mi riempirono gli occhi, e mi sentii un idiota.
Essendo sincero devo ammettere che ero ancora profondamente in-namorato di quella donna, ma avevo sempre quell'inclinazione a pensare al peggio propria di coloro che si sentono vittime senza rimedio. Come se qualche misterioso sacerdote di antiche religioni arcaiche mi avesse scelto per il prossimo sacrificio al Dio della Fortuna, e aspettasse solo quel gesto del destino, gesto che doveva venire da me, per sgozzarmi e mettermi sull'altare, parte di un rito propiziatorio inutile e senza senso.
Certo, mi resi conto di amarla ancora (sei mesi sono pochi anche per chi, come me, crede di avere subìto un indicibile torto), ma non riconobbi di che genere di amore si trattava, se di quel tipo di amore che non so oppure di vero amore. Forse avevo trasformato quel sentimento in pietà, l'ultima ragione per cui potevo mettermi con una donna. Istintivamente supponevo di compiangerla troppo per essere sicuro che il sentimento che ancora provavo fosse quell’amore profondo di cui avevo sofferto e goduto, per cui avevo urlato e taciuto, che avevo protetto e infine respinto.
Non so dire se in quell'incontro fui davvero io. Sentivo una parte di me che, affogata nella speranza, voleva cedere, e un'altra, ch'io avevo ritenuto essere il mio vero animo, che non voleva saperne. “Il cuore è ingannevole”, dice la Bibbia. Probabilmente era proprio lui a voler ricominciare tutto da capo, mentre il mio cervello, che ripensava al fatto di aver davanti a sé ciò che lui giudicava un'assassina, stava maltrattando sia il mio cuore che il mio corpo. Avevo un conflitto interno che, credo, si vedeva anche da fuori.
M'imposi di non dar retta al mio cuore che bramava cedere. Così, dopo aver fuggito la sua mano con un gesto stizzito del braccio, le porsi la borsa con la sua roba ansioso di sbrigare quell'ultima formalità. Rinsavito, mi convinsi che l'ultima cosa a cui tenevo era riprendere i contatti con quella donna.
Me ne andai con indifferenza, lasciandola lì a masticare stancamente l’angosciosa domanda se in tutto quel tempo fosse stata lei, conquistandomi, a regalarmi un po’ di sé, o se, inconsapevolmen-te, piuttosto non fui io a sottrarle un pizzico della sua persona negandole, però, di godere della mia.
No, non mi voltai a guardarla, mentre triste come Pirro me ne andavo lasciandola ai suoi più che giustificati rimorsi. Anche se era piuttosto palese che ero uscito vincitore da quell'incontro, il mio cuore, insieme al mio corpo, sembravano non essersene accorti. Ma poi, camminando per diverse ore, in parecchie direzioni diverse, e passando attraverso stati d'animo assai diversi fra loro, non mi sentii dispiaciuto per ciò che avevo fatto, anzi. Anche se la mia faccia non mostrava d'essere felice, le mie gambe mi sussurravano di non stare affatto male, il mio cuore era già altrove, ben lontano dal voler tornare indietro, e il mio cervello pensava a ciò che avrei fatto il giorno dopo.
Anche se sapevo perfettamente di non poter definitivamente chiudere la partita con Marta, più che altro col ricordo di quella relazione, ero comunque sicuro di essermela lasciata alla spalle. Forse per la prima volta mi sentii veramente libero da lei, dai suoi giochetti, dalla sua furba vanità e dalla sua fittizia onestà. Tutto mi venne in mente nei giorni che seguirono, tutto tranne il suo viso, i suoi sguardi, la sua camminata da giurisprudentessa, la sua frivolezza, il suo voler avere l'ultima parola su tutto. Non ripensai più al suo corpo, al suo modo di far l'amore, alla sua ostentata disinibizione e al suo voler avere sempre ragione. Forse soltanto quell'ultimo in-contro riuscì a portarmi via il suo più piccolo ricordo, a rinfrancarmi dall'idea che era stata proprio lei a fare quel che aveva fatto, a non farmi più rimpiangere l'odore della sua pelle, dei suoi capelli, del letto quando si alzava per rivestirsi, del suo modo di parlare macchinoso, dalla sua risata volutamente forte, studiata per attirare l'attenzione. Non m'importava più niente. Se mi avessero detto che era finita sotto un camion avrei risposto: “Ma chi?”
Solo quel giorno riuscii a vederla come in realtà era; una innocua farfallina che a furia di svolazzare di fiore in fiore finisce per annoiarti.
Talvolta mi piaceva pensare a cos'era scampato quel povero bambino non nascendo. Era solo un meschino palliativo, ma riusciva a convincermi quanto bene avessi fatto a tagliare tutti i ponti con lei. “Incredibile”, odiavo ripetermi quando, da solo, nella mia nuvoletta semi vacua di pensieri, mi tornavano in mente i contorni offuscati di quella storia, “uccidere una persona per mantenere la linea e poter andare al mare”.
Ripensavo spesso che tutto quello che era successo era sì normale per la Legge, ma anche uno dei pilastri su cui si fonda il nostro amato modello di libertà e democrazia.
“Where do we go from here?”
C'erano cose di cui, nonostante tutto quello che mi era successo, avevo perso il filo, e per questo non ne capivo i motivi. Come si è arrivati al punto di considerare l'uomo un estraneo per quanto riguarda le questioni di parto e di gestazione?
Non riuscivo a ricostruire il percorso di certe decisioni, prima di tutto prese dagli stessi uomini. Come si è arrivati a legalizzare l'aborto? Perché si è istituzionalizzato col pretesto che “tanto le donne lo facevano ugualmente rischiando la vita e arricchendo le mammane”? E noi uomini, come eravamo entrati nel ruolo di comprimari? Come potevamo uscirne? Tutto mi sembrava così illogico. Avevo forse perso qualche passaggio? No, ripensandoci mi pareva ormai impossibile un ravvedimento strada facendo. Quante donne abortiscono senza il consenso del loro uomo o, comunque, del padre del bambino? Eppure tali comportamenti sono considerati “diritti ed emancipazione”. E' così che siamo diventati un popolo di rincoglioniti. Di chi è il “merito”?
Ormai non lo ricordo più.
Che ogni cosa avesse avuto inizio con Olimpia de Gouges nel 1789 mi pare inverosimile. E quelle suffragette avevano cominciato tutto con l'intenzione di fare una strage d'infanti? Non ci credo. Non ci credo, è il pensiero moderno che distorce le cose! Quelle suffragette, e nel ventesimo secolo il Movimento inglese per i Diritti della Donna, si battevano per la parità di diritti fra i quali non c'era anche quello di uccidere.
Ma tutto è cambiato ormai, tutto è distorto.
L'aborto non può essere un “diritto” semplicemente perché, come disse Baldassarre, Presidente della Corte Costituzionale, “la Costituzione difende e privilegia il diritto alla vita, e l'autodeter-minazione della donna non può essere un diritto maggiore, o anche solo pari, a quello della vita”.
Forse quello che più impera oggi è una grande confusione. Una grande confusione che porta gli individui a distorcere ciò che sentono e quello che vivono, manipolando il pensiero delle masse che non aspettano altro che sentire qualcosa di nuovo, anche se poi così nuovo non è. Una grande mistificazione, ecco cos'è tutto. Una enorme mistificazione che ingigantisce e altera i significati delle cose, così che siamo portati a credere che le nostre priorità siano le sole, le uniche e più importanti faccende da sbrigare.
Ma non è così che si vincono le guerre.
III.
L'amore è amore, non ci si deve aspettare nulla in cambio. E questo tanto più vale per quelli che reputiamo nostri amici. Il valore che siamo abituati a dare alle persone è direttamente proporzionato all’interesse che queste suscitano in noi. Non è un caso che quelli con cui andiamo a vedere concerti, mostre, film e commedie teatrali siano di solito anche i nostri amici consueti. I gusti sono l'essenza dei rapporti umani. Sono andato pochissime volte in discoteca, e non ho amici ai quali piace andarvi, credete sia un caso? No, è un fatto consequenziale a ciò che penso e ai gusti che ho.
L'affetto che proviamo verso un amico è un sentimento mobile; la sua simpatia ce lo fa amare, il suo successo ci rende partecipi, la sua dolcezza ce lo indebolisce, rendendolo caro, intimo e sacro co-me la nostra faccia. Dentro questa mobilità ci sono due punti fissi; la reciproca considerazione, che a seconda dei casi ce lo innalza o ce lo affonda, e l'individuale capacità di perdonare. Nella scarsità di queste due cose l'amico diventa un conoscente, ma con l'abbondanza l'amicizia è valore più alto e possente del sentimento che proviamo verso una donna. Essa è compassionevole come una madre, indulgente come un padre, lusinghiera come un complimento, vivace come un bambino, bella come un'opera d'arte, commovente come un parto, naturale come un albero, eterna come Dio. Forte come la Morte.
Due anni dopo che Marta abortì e che ci lasciammo, accadde una di quelle disgrazie che meno si augurano perfino a chi ci vuole male; la perdita di un amico.
Maurizio se ne andò. Così, da un giorno all'altro, senza avvisare nessuno e senza farsi compiangere. Lentamente ma in modo occulto ci lasciò costringendoci a porci quelle domande che riempiono la testa delle persone, purtroppo, solo nei casi di lutto disperato. Chissà, forse sono io a compiangerlo più di quanto esso stesso desiderasse. O forse i miei sono solo rimpianti.
Quando, coi ricordi, rievochiamo i dolori e le sofferenze di una persona che abbiamo amato e che ha abbandonato questo mondo, la nostra pietà, unita al nostro amore per quella persona e alla nostra impotenza, li esalta esagerandoli a dismisura.
Purtroppo è solo nei ricordi che riusciamo a compiangere appieno, così come riusciamo ad amare o ad odiare, dando tutto noi stessi, perché siamo sciolti da quella mancanza d'impaccio che era proprio la vita del moribondo, ancora piena di baldanza e testimone (la quale, non avendolo ancora lasciato, c'imponeva rispetto e un certo timor reverenziale), a bloccarci. Nei ricordi possiamo avvicinarci a quello sfasciamento di sofferenza e guardarlo negli occhi. Non c'è più la paura, data da quell'ingombrante imbarazzo, di cadere nell'irrispettosità, non c'è bisogno di cautele, la discrezione non serve più a nessuno, né a noi né a lui né agli altri.
Aspettare la morte altrui è come attendere quelle sentenze che ci riguardano da vicino, verso le quali, una volta che tutto è finito, malgrado siamo stati condannati, non proviamo più alcun timore, solo rassegnazione.
Ma non è del tutto vero che se ne andò senza avvisare nessuno. La vita, e questo saltava agli occhi, lo aveva lasciato molto tempo prima della sua dipartita terrena e carnale.
Me ne accorsi perché da qualche tempo era cambiato. Ultimamente aveva perso quel brio che lo caratterizzava. Era diventato soltanto l'ombra futile del ragazzo gioioso e pieno di vita che cono-scevo fin dall'infanzia. Non aveva più interessi. Dire che era diventato un cacciaballe è usare un eufemismo. Negli ultimi tempi Maurizio non avrebbe detto la verità neppure sotto l'effetto del Pento-thal. I suoi occhi trasmettevano tristezza. Le sue labbra, da un po’ di tempo pallidamente viola, tremavano come se fosse stato sempre sul punto di dire qualcosa. Il suo fisico era diventato malinconicamente ossuto, e quelle spalle curve sembravano l'anticamera dell'obitorio.
Ma non c'è molta apologia da fare. Ognuno di noi si cerca il suo modo di morire come si cerca quello di vivere, e anche se io arrivai a piangere per lui quando lui, invece, si sforzava di sorri-dere, forse anche il segreto della mia vita è tutto qua.
Anche il suo comportamento era mutato. Non era più capace di dire in faccia alla gente quel che di loro pensava. Forse credeva che un giorno avrebbe potuto avere bisogno anche di quelli che non gli erano mai stati particolarmente simpatici. Era sempre pronto ad appianare i contrasti, ora. Non che questo sia in ogni caso un male, ma non era il genere di comportamento che mi sarei aspettato da lui, ecco.
Da Alessandro l'avrei anche capito, perché nulla era più distante dalla sua testa che non mostrarsi tollerante e comprensivo in ogni momento. E' vero, anche lui, su certi argomenti, talvolta s'induriva. Quando questo succedeva io gli dicevo:
- Sai cos'è che mi fa sorridere? Che questo tipo di principìi vengano proprio da una personalità squinternata come la tua.
Allora Alessandro mi guardava, stupidamente fiero, con l'aria di chi ha capito che gli si stava facendo un complimento.
Maurizio aveva preso a bucarsi. Si sa, in certe ristrettezze, in certi giri di vite, non ci si entra sempre perché uno si rende conto di avere dei problemi irrisolvibili o, facendo chissà quale arguto ragionamento, per rivalsa sulla società. A lui andava tutto abbastanza bene, non aveva bisogno di granché. Ma quel che ignora lo spettatore a volte può essere ignorato anche dall'attore, anche se per motivi diversi. La sua morte mi sembrava così illogica. Come mi pareva illogico e inimmaginabile l'eventuale motivo che aveva avuto per entrare a far parte di quel mondo, la tossicodipendenza.
Ricordo che due mesi prima di morire, dopo aver suonato in sala, mi aveva chiesto se l'accompagnavo a comprare della pittura. Voleva ridipingere il suo appartamento. Quando gli chiesi perché non lo dava da pitturare a qualcuno del mestiere, lui rispose:
- Mah, non so cosa fare. E poi dar la pittura mi diverte.
Ma non era così. Negli ultimi tempi Maurizio veniva da me e mi chiedeva dei soldi. Sebbene guadagnassimo più o meno le stesse cifre lui era sempre miscio come l'ultimo dei pezzenti. Ora so perché, ma prima mi arrabbiavo parecchio anche per questo fatto. Gli davo sempre qualcosa, prestiti a cui lui non ha mai fatto fronte, soldi che non mi ha mai restituito, ma io ero ben felice di aiutarlo.
Quando seppi di cosa soffriva Maurizio prima che dispiaciuto rimasi sorpreso. Non lo facevo un tipo da infognarsi con l'eroina, anche se tutto cambia, se tutto è in eterno movimento.
Cercai di aiutarlo a salvarsi, ma lui prendeva tutto alla leggera. Diceva che non aveva bisogno di nessuno perché ne sarebbe uscito come e quando voleva. Io allora gli chiedevo quando lo avesse voluto, e lui rispondeva:
- Prima o poi. Ora di smettere non ne ho voglia, non ne sento la necessità. E poi se smetto cosa faccio?
Quando mi rispondeva così mi rendevo conto che stava per fare una brutta fine. Del resto nessuno avrebbe potuto farci nulla. La tossicodipendenza è un “affare” troppo personale. Se Maurizio aveva scelto l'eroina per suicidarsi, noi, sicuramente, non potevamo farci niente. Soltanto lui poteva decidere di uscirne, così come aveva deciso di entrarci.
Il giorno in cui arrivò la notizia che Maurizio era stato ricoverato all'ospedale eravamo in sala prove a suonare. Buttati gli strumenti in un angolo corremmo subito al suo capezzale.
Arrivammo che lo avevano appena portato in reparto. Non capivo perché. “Se era grave sarà stato da operare immediatamente!”, mi dissi. Ci vietarono di entrare nella sua stanza, abbandonandoci in corridoio a divorare le nostre ansie.
Dopo una decina di minuti vidi arrivare, dal fondo del corridoio, uno stuolo di persone. Era un gruppo compatto. Sembravano hooligans in trasferta. Vidi i loro camici bianchi che, man mano che si avvicinavano, le luci del corridoio rendevano addirittura abbaglianti. Nel centro, davanti a tutti, camminava il Primario. Il suo passo era veloce, stizzito, a scatti. Guardava diritto dinanzi a sé e non aveva l'aria di voler dare confidenza ad alcuno. I suoi collaboratori, Dottori, Dottoresse e Capo Sala, lo accerchiavano facendogli da corollario come i petali di un fiore. Faticavano a tenere il suo passo, arrancavano, restavano un po' indietro, poi lo raggiungevano di nuovo, discutendo con lui parlandogli ossequiosamente, quasi chiedendone il permesso, seguendone, lusingatori di mestiere, ogni insignificante smorfia. Il Primario gli rispondeva con sufficienza, senza guardarli. Sembravano il Re e la sua Corte dei Miracoli.
Quando mi fu a pochi metri riuscii a scorgere bene il suo volto rasato di fresco, i suoi capelli brizzolati e perfettamente squadrati, le basette che cascavano rade rade e piene di sussiego, i suoi occhi vispi che facevano da contraltare a un naso sottile e svogliato, mentre le labbra serrate, perfette, parevano menefreghisticamente annoiate.
Mi passò davanti senza vedermi. La sua luminosità di Luminare, con ignavia e senza alcun impegno, calzava appieno tutti i luoghi comuni che la riguardano.
Quando fummo vicini parve quasi puntar dritto verso di me con l'intenzione di speronarmi e, come un pirata, di abbordarmi. Io feci per andargli incontro, ma giunti a non più di trenta centimetri uno dall'altro, virò bruscamente ad angolo retto, come se dovesse seguire un muro immaginario, e infilò la porta della stanza dove Maurizio, cosciente, stava agonizzando.
Una volta davanti al letto guardò il mio amico, che dava ampia visione di sé e della sua misera condizione di moribondo, prendendo a scrutare la sua cartella clinica come un archeologo cerca la verità decifrando geroglifici egizi. Dopodiché tirò su la testa e lo guardò con una smorfia. Il suo volto, prima sicuro e saccente, seguì la drammaticità degli eventi e si fece più greve. Improvvisamente inventò una giravolta su sé stesso e si mosse verso l'uscita della camera. Fu così lesto che la Corte biancovestita per un istante restò sorpresa e spaesata. Il suo camice svolazzò come la gonna di una ballerina di tango nell'erotiche piroette, e i suoi collaboratori dovettero cercarlo per qualche secondo, giacché era scomparso alla loro vista come un fantasma nella notte. La situazione era critica e il suo volto ci si dovette adattare. Giunto a poche decine di centimetri da me si schiarì la voce come un tenore sta attento, poco prima del “Nessun dorma”, a prendere la tonalità giusta. Iniziò a parlare ma dovette metterla a punto un paio di volte, prima abbassandola, ma eccessivamente, quindi rialzandola di un'ottava.
- Lei è un parente? - disse guardando sopra la mia spalla con occhi abbattuti e ignorando volutamente gli altri del gruppo.
- No. - risposi faticando a trovare il suo sguardo - Sono un amico.
- La situazione, come avrà capito, non è affatto allegra. Il suo amico sarebbe da operare subito. Ha il fegato completamente in cirrosi............………
- In cirrosi? - chiesi stupito.
- Sì, epatite C. Glielo ha divorato. Servirebbe un trapianto ma……..
- E allora? - lo interruppi - Che problema c'è?
- Non è così semplice. Lui dice di non voler subire trasfusioni di sangue. Ora, il tempo stringe. Non possiamo più portarlo in un altro ospedale dove hanno le apparecchiature per trapiantarlo senza far uso di sangue, perché non c'è tempo e rischierebbe di andarsene senza vedere neppure la sala operatoria. L'unica speranza è che il vostro amico - e per la prima volta girò la testa verso gli altri – cambi idea, altrimenti.......………
- Ma non è possibile! - dissi infastidito da tanta rassegnazione - Fatemi entrare un momento, lo convinco io.
- Prego. Se ce la fa........................
Entrammo. Coi miei amici ci sparpagliammo circondando il suo letto, come Generali attorniano un tavolo per decidere, scrutando una cartina, le tattiche di guerra. Il biancore asettico della stanza rendeva tutto più muto e sospeso. Sembrava che il mondo avesse spento le luci e abbassato la saracinesca.
L'arredamento era moderno, ricoperto di fòrmica grigio chiara. Ogni cosa era pallida, bianca, che poi è il vero colore del lutto, perché quando si muore ci si rifà vergine la coscienza. Le gambe nude delle sedie di metallo davano al tutto un'impressione cerimoniosa, formale, poco adatta a ciò che erano i momenti. Le finestre, punteggiate di pioggia, lasciavano passare una luce flebile e vuota. Era giorno, ma senza la lucentezza gioiosa propria del giorno. Il panorama era l'autorità della Morte sull'intera umanità, che, traboccando da un corpo ormai ridotto a nulla, va ad infettare ogni cosa intorno, gli oggetti, le persone, la vita stessa. Si aggrappa, la Morte, tira e scalcia, fetente, prepotente, olezza. Se ne approfitta, perché un malato terminale non è nelle condizioni di rifiutare niente. Ma non è sempre così. Altre volte invece è più silenziosa, ha il volto della vita, delle Istituzioni, sorride, si tira i capelli indietro come un vanitoso, ti si mette accanto, ti prende per mano, vuole parlarti, comunicare, convincerti che è l'ora e bisogna andare.
Maurizio era debole, e con gli occhi semichiusi non mi riconobbe subito. Teneva le braccia lungo i fianchi, smorte, coi palmi delle mani rivolte verso l'alto. Il suo viso era pallido e sudato, ma non trasmetteva agli sguardi intorno la Morte, tutt'altro. Sembrava pieno di vigore, nonostante la voce comunicasse uno stato d'abbandono, d'incuria, d'arrendevolezza. Sembrava un bambino con poche linee di febbre che si possono curare più coi baci di una madre che con gli antibiotici. Mi fissò. Quando riuscì a capire che ero io si allargò in un sorriso ingeneroso e impotente.
- Ehi, cosa mi combini? - dissi a voce bassa - Cos'è questa storia che non vuoi fare trasfusioni?
- Anche tu sei un appassionato lettore della Bibbia, - rispose lui con un fil di voce - e dovresti sapere che Dio non accetta che chi lo vuol seguire, chi vuol seguire le sue leggi, commetta consapevolmente peccato.
- Da quando sei diventato religioso?
- Lo sai, mi è sempre piaciuto leggere la Bibbia, e non sono di-sposto a vendermi per salvare il mio misero culo. Altrimenti cosa ne sarebbe di me?
- Ma perché, Dio vieta di assumere sangue?
- Sì. Il sangue rappresenta l'anima, e chiunque lo assuma si macchia di un reato molto grave, un reato che merita la morte. Se io muoio ora, senza assumere sangue, ho qualche possibilità che Lui si ricordi di me quando resusciterà l'umanità, nell'ultimo giorno….…….… altrimenti….………....E poi morirei ugualmente…….…….credimi Gianni………..non è spocchia…………..
- Ti credo......................ma allora................cos'è?
- Tu credi veramente - disse Maurizio faticando a parlare - che tutto ciò che siamo, che abbiamo, la gente che ci stima e ci vuol bene, ci appartenga? L'unica cosa che è davvero nostra sono i nostri princìpi. Senza princìpi non siamo nessuno. I nostri principìi siamo noi stessi. Ora dovrei andare contro i miei principìi, contro ciò che penso, per salvarmi la vita. Ma dopo questo compromesso cosa resterà di me? Dovrei vendermi? No, questa cosa, come la chiami tu, è mia, nessuno potrà mai portarmela via. Se oggi muoio così come sono, sono sicuro di essere io a morire. Ma salvandomi contravvenendo a ciò che Dio vuole da me, magari per morire fra dieci anni, sarò ancora certo di essere io a vivere il tempo che mi rimane?
Non ebbi il coraggio di aggiungere niente. Avrei voluto dirgli tante cose, ma non seppi osare e le parole restarono imprigionate dentro il mio stomaco in una smorfia di rassegnazione. Le smorfie non nascono dalle facce, ma dagli stomaci. Le facce sono solo un punto d'arrivo. Alzai la testa, e vidi che gli altri fissavano il pavimento quasi fosse l’enorme schermo di un cinematografo.
Poi guardai Maurizio. Avevo il corpo sobillato da una matassa ingarbugliata di sentimenti contrastanti. Nonostante il mio amore per lui, in quel momento un po’ lo odiai. Perché era stato così stupido? Perché anche lui aveva finito per farmi soffrire? La memoria, anticipatamente commemorativa, iniziò a frugare fra le pieghe degli anni per riportarmi indietro il mio amico, al quale Maurizio, in quel letto, così poco somigliava, tentando di consolarmi e prefigurando ciò che lui sarebbe stato nei ricordi degli anni a venire. Un gesto solo, una parola, forse rimasticata confusamente, un sorriso, sbiadito perché lui non esiste più. E poi le battute stupide, gli scherzi scemi, e, perché no?, perfino le incomprensioni, i battibecchi. Ma anche il suo ricordo in noi era destinato a spegnersi, magari lentamente, come il fumo di un braciere, resto di un falò enorme, che a notte inoltrata, quando tutti sono andati a casa a dormire, decide di arrendersi anche lui.
Forse i nostri ricordi non sono altro che il tentativo di tenere in vita istanti piacevoli e piacevoli facce, perché sappiamo bene che ogni volta che un uomo se ne va un poco è tutto il mondo a morirne, e, consci d'essere noi stessi il mondo, è come se un pezzettino delle nostre anime rimanga incastrato nel lontano passato, purtroppo non in qualcosa di lieto, bello da ricordare, ma piuttosto perso per sempre in quelle morti tremende, nello sfasciamento umano.
Restai in quella stanza perdendo la cognizione del tempo. Tutti i pensieri, passati e presenti, vennero a tormentarmi, il silenzio di quell'ospedale fece il resto. Entro un’ora Maurizio aveva abbassato gli occhi alla terra. Una volta fuori da lì andai a spasso per la città, titubante come un cieco che a tastoni cerca la sua via.
Avevo immaginato spesso che qualcuno dall'alto, come spettatore fedele di un teatrino in cui si mette in scena ogni giorno la medesima commedia, ci osservasse divertendosi pazzamente. Immaginavo che fosse lui stesso a cambiare di volta in volta la scenografia e le battute, conservando però i ruoli. Cambiava sovente anche il genere, passando dal drammatico al fantastico, e dall'avventuroso al grottesco. Avevo sempre creduto che il mondo sarebbe passato quando lo spettatore avrebbe finito di divertirsi, e non ci sarebbe stato più nessuno che avrebbe pagato il biglietto.
Gli altri non avevano capito molto di quel che Maurizio aveva voluto dire, io sì. Forse è vero. Tutto il coraggio di cui disponiamo può venir fuori solo in casi estremi, come di fronte alla morte, per amore della vita, per tener fede a un principio.......……….………...
Mentalmente misi a confronto Maurizio e Marta. E' incredibile come certa gente, con le azioni, riesca a farti capire quanto l'umanità viva in funzione propria, quanto poco ci curiamo di conoscere le persone in profondità, perfino coloro che reputiamo nostri amici. Allora rivediamo i loro atteggiamenti, le loro espressioni, i loro gesti soliti, addirittura i loro vizi, come qualcosa d'incomparabile, e ci rammarichiamo di non aver avuto quel secondo in più per urlargli in faccia tutto il nostro amore.
Due giorni dopo, davanti al sagrato della chiesa dove i suoi genitori, contravvenendo a ciò che Maurizio aveva lasciato detto, gli fecero il funerale, c'era tutta la città. Nostri fans, sicuramente, ma anche gente normale, che si fermava mentre faceva la spesa o andava al lavoro. L'eco della sua morte, ma soprattutto di com'era morto, in quali circostanze, si propagò come un incendio. Il diretto risultato fu che i nostri dischi (il terzo era appena uscito) in un paio di giorni entrarono nelle classifiche di tutto il pianeta.
Fu al cimitero, percorrendo il lungo sentiero consumato, che pensai seriamente di lasciare il gruppo. Come potevo mettermi in tasca i soldi di quei dischi? Maurizio era morto per i propri principìi. Se noi del gruppo avevamo ancora qualche principio e un po' d'amore per Maurizio era arrivato il momento di dimostrarlo.
Lasciai il gruppo perché gli altri non lo dimostrarono.
IV. Delirio di un artista (presunto)
In questa casa alle Cinque Terre, sulle alture di Monterosso, posso vedere la vita da vicino, strapparle quell'orribile maschera dietro la quale si nasconde il bellissimo volto di Dio. Le pochezze, i sotterfugi, le meschinità, le vanità, appartengono ad un altra mia vita. Una vita che forse non volevo fare, e che invece mi ha cresciuto. Quella stessa vita che ha dovuto prendermi a calci per farmi capire che ero diventato uomo, che i miei anni non me li avrebbe perdonati più nessuno.
Oggi ho capito che siamo stati solo degli effimeri personaggi, comparse alla stessa strenua di tanti individui che affollano il mondo, quasi non fossimo mai esistiti. Come quegli artisti inventati da Marcel Proust per “Alla ricerca del tempo perduto”; Elstir per la pittura, Bergotte per la letteratura e Vinteuil per la musica. Ma, a pensarci bene, sono rimasti più loro che noi.
Se quell'effimera vita è stata solo una commedia teatrale noi siamo stati soltanto i suoi distratti e vanitosi spettatori. Non abbiamo pagato il biglietto e ci siamo seduti nei posti migliori. Non l'abbiamo seguita e ci siamo vantati con chi non è potuto entrare di sapere cos'è stato messo in scena. Ci siamo alzati, verso la fine, e ce ne siamo andati spocchiosamente, senza applaudire. Ma, appena fuori dal teatro, abbiamo sentito dire che quella è stata la miglior rappresentazione dell'anno. Così ci è presa la voglia di rientrare. Ma non ci sarà dato altro da vedere che la morte, perché la vita è l'unica commedia che non si replica mai.
Guardando il mare da vicino mi è difficile non ammettere a me stesso che quello che siamo stati non è che una risata continua, l'illusione di restare, di perpetuare la nostra esistenza. L'immortalità è il desiderio che l'abitudine si protragga all'infinito, ma è in vita che si coltiva la propria eternità, così che spesso arriviamo di fronte alla Morte disarmati, perché abbiamo perso troppo tempo a bighellonare per le strade scure nella notte del mondo. Proprio ciò che ci rende deboli davanti alla Morte. Un giorno tutti saremmo costretti ad uscire da questo mondo senza avere la possibilità di abitarne un altro, e soltanto chi resta saprà cosa abbiamo lasciato.
Anche oggi che sono affannosamente ricercato da chi vuole i miei testi o le mie interviste, mi rendo conto della pochezza dell'artista, e capisco di essere un uomo qualunque. Scrivo, ogni tanto, ma non godo molto. Non so perché, ma sento che gli altri mi regalano quei complimenti di circostanza che fanno più male delle critiche feroci e disoneste. Il successo è una calamita di compassioni e benevolenze che solo l'invidia può inibire.
A volte, sperando in un improbabile normalizzazione della mia vita, m'immagino impiegato del catasto, col tavolo ingombrato da protocolli e sommerso dalla polvere, e col potere di tenere fuori dalla porta tutta l'umanità. Vorrei, oh come lo vorrei!, che qualcuno venisse da me e mi dicesse: “Questa cosa che hai scritto fa veramente cagare”, e magari restare lì con lui a farmi spiegare perché. E invece niente. Solo complimenti, risa, pacche sulle spalle, scherzi e cameratismo. Quante volte avrei voluto, entrando in un albergo per chiedere una camera, che non mi avessero riconosciuto. Quante volte mi sono sentito in questo il Nemico Pubblico Numero Uno.
A volte penso a quanto sarebbe più facile la vita per me senza l'ausilio del successo. Come mi piacerebbe fare il cameriere nelle navi da crociera! La notte, appena smontato dal lavoro, fermarmi sul ponte a fumarmi una sigaretta pensando che la terra non esiste mentre guardo il mare! E poi alzare la testa, fissare il cielo tentando di scorgere qualche stella cadente per allungare una mano ed afferrarla proprio mentre si spegne, e rammaricarmi d'aver pensato che fosse eterna come il mio amore. Camminare sul ponte di legno a piedi nudi, assaporando il dondolìo del mare come se fossi un bambino cullato dalle braccia di una tenera madre. Avere la cabina piena di posters d'auto e di donne, gli uni per ridere e gli altri per piangere. Quando il Sole tramonta riuscire a scoprire dall'oblò dove si trova il Levante in alto mare, e, fra una portata e l'altra, carpire i segreti del cuoco di bordo.
Nonostante tutto credo che i miei “Cent'anni di solitudine” siano stati un po’ troppo brevi.
Ogni tanto mi capita di sentirmi come il soldato di una Armata vinta. Quale misera vita fa “l'artista”! Sempre a ricercare l'umiltà perché sa che prima o poi, come quel sole disegnato da un bambino sulla lavagna nell'ora di ricreazione, toccherà anche a lui tramontare con un colpo di cancellino. E' soltanto lì, in quel momento tremendo, che si capisce, come tutti gli altri, d'aver perso. E allora?
Bisogna avere quell'umiltà di fondo per convincersi che nella sconfitta, come nella morte, siamo tutti uguali. Quale differenza può esserci fra un pittore senza il suo pennello e uno scrittore che fa il tassista? Nulla! E' l'omologazione! La nostra misera paghetta morale di artisti è andata a farsi fottere. Come per tutte le cose che col tempo invecchiano per poi morire, anche noi siamo passati o passeremo.
Forse aveva ragione Maurizio. Ciò che di noi resta è soltanto il nostro comportamento, che ha permesso a qualche persona di amarci davvero. Questo si può ottenere solo con la coerenza, coi principìi, fondamento delle amicizie e degli amori. Tutto il resto non è che un’apparizione fugace destinata all’oblìo.
Quando ripenso ai vecchi tempi non provo quella che sarebbe una più che giustificata nostalgia. Piano piano si cresce e i ricordi si offuscano, così che non arrivo mai a pensare di aver perso chissà cosa. Gli unici momenti magici sono quelli che si vivono, il passato se ne esce, e a volte sento che il mio non mi è mai appartenuto. Cosa può mai darti la vita? Niente altro che ciò che ti prendi! Senza meriti siamo venuti al mondo, e senza particolari colpe ce ne andremo.
Soltanto raramente mi mancano gli alberghi, i concerti, i voli in aereo, i lunghi viaggi in macchina, le urla dei fans, gli autografi fatti bene, quelli fatti male, le notti in treno, le serate a perder tem-po con amici sconosciuti e fidanzate che non ti amano. Solo di tanto in tanto sento la mancanza della chitarra, del palco, di Maurizio, di Marta, di mio figlio. Non c'è tristezza in un volto che non vuole ricordare, ma solo questo successo, tremendo, una barriera invalicabile fra me e il mondo. Per la prima volta in vita mia sono davvero solo, malgrado fuori dalla porta di casa qualcuno sosti continuamente per chiedermi un autografo.
Chissà, forse è questa separazione la mia Morte.
Il nostro attaccamento alla vita non si affievolisce perché invecchiamo e vediamo che i nostri amici invecchiano con noi e tanti muoiono, ma perché i ricordi si offuscano e nella nostra memoria non rimane nulla di cosciente che non sia lo squallido presente. Non si muore mai perché aumentano gli anni, ma perché diminuiscono i ricordi.
Talvolta, sorridendo, mi chiedo se esisto ancora o se sono solo la proiezione dell'immaginario collettivo del divismo. Forse ognuno di noi verrà ricordato solamente come punto di riferimento della storia personale di qualcun altro, o come un passaggio vuoto fra due date.
- In quegli anni mio padre era ancora vivo. – diranno i nostri figli.
Chissà, potremmo diventare oggetto di vanto, di vanità, di presunzione.
- Mio padre ha conosciuto il tal cantante.
Oppure:
- Mio nonno suonava in una band famosa.
Che meschinità! Che frivolezza! Sentirsi grandi per i meriti altrui! Mai capito. Queste cose, chissà per quale motivo, sono abituato a figurarmele con la faccia di Marta. E allora mi scatta l'input e ripenso al ruolo che la vanità ha avuto nella mia vita, o al dolore che mi sono inflitto correndo dietro all'illusione che Marta fosse il “vero amore”, quello con la A maiuscola.
La vanità è abituata a prendersi sempre di più dagli individui che la sfoggiano, suoi padroni, così che per loro diventa il centro gravitazionale di ciò che sentono e di quel che vivono, e il mezzo per poterla sfoggiare acquista una tale importanza ai loro occhi che non lo sanno tenere in disparte per un attimo.
Quante persone ho conosciuto, anche bravi artisti, eccellenti musicisti, che se gli toglievi il loro lavoro non sapevano più come entrare né come uscire. Erano il balìa delle onde, di ciò che spesso cambia. Dove li mettevi stavano; se c'era il sole si abbronzavano e se pioveva si bagnavano. Tutto questo aspettando...……………….
Ancora non sono riuscito a capire cosa stessero aspettando, se il tempo, che secondo loro tutto cambia, o che gli cascasse un sacco pieno di soldi sulla testa. Si guardavano smarriti, e credevano che quel po' di musica che avevano gli sarebbe bastata, che fosse l'unica cosa importante. Non avevano capito che lo svago, ciò che la musica rappresenta per chi l'ascolta, se si è messi alle strette è la prima cosa di cui la gente fa a meno. Come tutti i divertimenti, che in sé stessi non sono l'essenziale ma il superfluo, anche la musica è una di quelle cose che in tempi di carestia non servono a nulla. Ma bisognava capirli, quello era il solo modo che gli permetteva di sentirsi “qualcuno”.
Comunque non c'è limite all'illusione. Anch'io per qualche tempo ho creduto di essere un artista. La verità era che con questa convinzione che mi seguiva da vicino, seduta accanto a me sull'autobus, nel locale, o dove volete voi, mi sentivo come se fossi più di quel che ero. Poi arrivò la vanità, il sentirsi importanti in modo sproporzionato alla causa, e quel poco d'arte che c'era in me svanì lasciando il posto alla disillusione. Capii che le mie miserie non appartenevano solo a quella faccia sulla Carta di Identità, ma anche a quell'altra che anch'io conoscevo solo a sprazzi. Ero, come già detto, padrone di due me stessi. Uno disilluso, cosciente di non voler far parte del mondo, delle sue stranezze, delle sue cose consuete, e un secondo, più portato verso la fantasia, un inguaribile sognatore che era ancora convinto di poter cambiare qualcosa, in definitiva più simile a ciò che ero da fanciullo. Non so dire quale dei due sia stato più misero, vuoto e nudo.
Ciò che più mi preme oggi è stare fuori dalla scena. Da quella politica, dalla musica, dalla comunità. Tutto quel che ho mi basta. Non voglio correre il rischio di tornare ad illudermi come mi è successo in passato. Illudermi che una madre voglia sempre bene al suo bambino, illudermi che chi si occupa d'arte abbia in sé un animo candido, migliore di altri, e voglia occuparsi d'arte perché gli piace, perché è uno spirito libero. Non voglio illudermi che gli amici non debbano morire mai solo perché sono i “nostri amici”.
Mi spiace umanità, ma non susciti in me alcun moto, non ho più niente da dirti. Quello che oggi voglio è che tu ti distragga un momento, che volti la testa dall'altra parte per farmi uscire da te in silenzio, senza clamori né false sorprese.
Non ho mai amato i funerali di Stato o quelli di cadaveri eccellenti che con la loro dipartita riescono a riempire i sagrati delle chiese e i piazzali sottostanti.
Ricordo i funerali di Maurizio. Sì, c'era tantissima gente, ma molta era lì per caso o per noia, perché non sapeva cosa fare quella mattina. Quando li guardavo, quando li vedevo indaffarati a farsi riprendere dalle Tv, pensavo che Maurizio meritasse di più. Di più di quella specie di gazzarra messa in opera, di più delle parole che quel prete dietro quell'altare pronunciò senza neppure conoscerlo, di più dell'affetto fittizio che molti gli avevano riservato, di più della vita che aveva condotto contrattando i suoi anni con la Morte.
Seduto su questa sdraio, sul mio cortile a Monterosso, nella Liguria più discreta, penso che non tutti, come me, hanno il privilegio di vivere senza arrabattarsi. Ma tutto ciò che ho, che sono e che sarò, lo devo realmente alla musica?
Quando ripenso a ciò che la musica è per me mi metto a ridere da solo. Il nostro successo, il mio, è solo frutto di considerazioni esagerate, frutto dell'illusione dei nostri fans che dando un po’ di celebrità ad una persona normale, e considerandosi persone normali essi stessi, possano usufruire di un indefettibile sillogismo, frutto di speranze di chi ce lo ha dato, di potercelo un giorno togliere. E prendetevelo allora, questo cazzo di successo!
Sono sicuro che se un giorno qualcuno che mi conosce, anche solo di fama, non importa, venisse a rinfacciarmi la mia agiatezza, tutto quello che posso rispondergli non basterebbe a calmarlo seriamente. Ma è davvero molto che ho?
La mia casa, la mia donna, i miei figli e io stesso, riesco a tenerli insieme soltanto col timore. Quello stesso timore che mi prende la sera, quando sto per andare a dormire e penso al domani chiedendomi che ne sarà di me e di tutto quel che ho. Quel timore che, ne sono sicuro, il mondo non sarebbe in grado di capire fino in fondo.
V.
Subito dopo la morte di Maurizio entrai in una crisi profonda. Una crisi dalla quale, sentivo, non mi sarebbe stato facile uscire. In quei giorni molti mi consigliarono l'Analista, ma io non vi andai mai. Non ne vedevo, come non ne vedo, l'utilità. Anche perché non ho mai creduto nell'efficacia della Psicoanalisi. Sarebbe come andare da un ateo a farsi spiegare Dio.
Che comica. La Psicoanalisi è l'unica Scienza Medica che cura i pazienti usando come medicina i luoghi comuni.
Fatico a capire perché le persone che vanno dall'Analista non provino prima con un loro amico. Presumibilmente perché sanno già di cosa soffrono e, per superbia, non vogliono farselo dire da chi già li conosce e in modo gratuito.
Confondiamo l'originalità, l'essere unici, con la complessità del nostro carattere, e se qualche nostro amico ci dice “non ti capisco”, invece che pensare se per caso non ci siamo spiegati male, ci sentiamo stupidamente orgogliosi. Sovente penso che la vera terapia siano i soldi che si lasciano in quelle sedute.
Quando un tizio va dall'Analista, quasi sempre, è perché si rende conto d'aver sbagliato in qualcosa e che sia proprio quell'errore a farlo stare male. Dando quei soldi per le sedute il paziente si fa la convinzione di pagare principalmente per quello sbaglio. Per carità, non c'è nulla di male in questo, ma facendoci caso traspare in questi individui una convinzione di fondo che fa più paura della loro pseudo malattia: che i soldi riescano a comprare non solo il benessere fisico, ma anche un certo stato di coscienza che fa sentire più puliti.
Demostene, rispondendo ad una cortigiana che gli aveva chiesto una grossa somma di denaro per concedergli i suoi favori, disse: “Non pago così caro un rimorso”.
Per un breve periodo rimasi come separato dalla vita, dal mondo. Come se l’atto di quella donna nell’uccidere nostro figlio mi avesse contagiato, mi allontanai da tutto con la vaga speranza di mondarmi da quel contagio, da quell’epidemia conformista che tentava di annientarmi. Certo, ben presto capii che la ricerca di quella stravagante purezza era solo una scappatoia meschina, e che la salvezza personale sarebbe stata comunque ben poca cosa al cospetto del dolore che provavo, ma, con quel rancore dentro che per i primi tempi mi fu necessario, riuscii a so-pravvivere.
La presenza di Marta nel mio cuore e nella mia coscienza d'esser vivo continuava ad essere qualcosa di estremamente doloroso. Si materializzava sottoforma di odio, certo, di rabbia, di gelosia, perfino di rimorso, e per alcuni anni non mi lasciò in pace un momento. Ebbi successo nel trasformare ciò che aveva fatto in una specie di tradimento, e il rancore era per me come una droga, un'assuefazione, un'assuefazione della quale non riuscivo a fare a meno.
L'amore che vogliamo ad una donna è una sorta di specchio che riporta indietro la nostra immagine, e quand'ella in qualche modo ci tradisce è come se perdessimo la fiducia in noi stessi. Consideriamo quel tradimento come una nostra pecca; “l'incapacità di essere uomini”. Amiamo perché narcisisticamente “ci amiamo”, e quando veniamo traditi dalla nostra donna vediamo nella nostra condizione di traditi non solo la fine di un rapporto, ma anche quella della nostra capacità di accettarci per ciò che siamo. Così, vittime di tali situazioni, si reagisce in modi assai diversi; gli uomini si attaccano alla bottiglia per darsi il colpo di grazia, e le donne vanno da un Chirurgo Estetico a rifarsi il seno. Si potrebbe dire che l'uomo vede nel tradimento di cui è vittima, una delusione irreparabile che lo porta verso il suicidio, e la donna invece la sua morte vera e propria. Così il primo si uccide davvero, e la seconda, considerandosi già morta, tenta di rinascere più bella di prima.
Entrambi i comportamenti sono frutto di millenari retaggi.
L'uomo, più cacciatore che cacciato, non sopporta di essere snobbato dalla sua preda, mentre la donna, preda per definizione, mal digerisce che a lei si preferisca altra selvaggina. Da tali fatti si può desumere che la donna, benché meno capace di amare (altrimenti non si spiegherebbe la contraddittorietà del suo “perdersi” e la destrezza nel riuscire a “voltare pagina”), tenga più dell'uomo al suo ruolo di specchio, e che l'uomo, stupidamente convinto di essere invincibile, veda nella rottura di quello specchio non sette anni di sfortuna, ma il completo annullamento del suo spirito.
La consapevolezza che agguanta un tradito è simile a quella visita medica che siamo convinti di fare per una sciocchezza o per routine, e che invece ci rivelerà un nostro stato tumorale.
La vera forza degli uomini oggi, è tutta nel saper rompere gli specchi senza torturarsi poi con un ridicolo rimorso. Non so dire se qualcuno di voi si sia mai fermato a pensare seriamente a ciò che sono gli specchi, neppure io per molto tempo lo avevo fatto. Noi ci fissiamo, ci presentiamo davanti a loro, gli chiediamo di presentarci al mondo, convinti che soltanto loro siano in grado di raffigurarci per ciò che siamo. In realtà lo specchio non ci mostra per quel che siamo ma per ciò che vorremmo essere. E’ senz’altro questo il motivo principale per cui gli specchi non servono a niente.
Sono convinto che se sapessimo con chiarezza cos'è uno specchio, avremmo in mano la Pietra Filosofale del Terzo Millennio.
L’unico nostro specchio credibile sono gli altri, e principalmente la persona di cui siamo innamorati. Capisco che sia difficile ammetterlo, ma purtroppo è proprio così. Quando la nostra donna vede in un altro uomo la capacità di farla sentire più importante e più fedele a sé stessa, più simile a come si vorrebbe, capiamo che il nostro, di specchio, è andato in frantumi, e, vittime di quello che consideriamo un tradimento, siamo portati istintivamente a non fidarci più di alcuno specchio. Solo mutando le nostre ambizioni amorose riusciamo a rifarci una vita sentimentale con un’altra donna. In pratica, solo cambiando specchio.
Il tradimento è difficilmente perdonabile perché il suo atto ingiusto d'infedeltà sfrutta la fiducia di chi ama, e, per questo stesso motivo, è capace di violentare nelle carni le sue vittime. Si può capire, e forse anche giustificare, chi salta la barricata per opportunismo, molto meno chi lo fa per noia o per vanità. L'infedeltà non è solo “andare” con una persona diversa dal nostro partner solito, ma regalargli il proprio lato migliore (il farsi belli, andare dal parruc-chiere, profumarsi e mettersi in bella forma per un altro, o un'altra, in pratica gli “addobbi” che un vanitoso allestisce per la collettività) mentre riserviamo al compagno legittimo la squallida monotonia della normalità (la faccia gonfia dal sonno, il modo orrendo di cucinare, le spese pazze, la puzza delle defecazioni, la pochezza intellettuale e ogni altro difetto). E' questa la faccia visibile del tra-dimento. Difetti che si sopportano fino a quando ci si sente amati, ma che diventano una tortura dal momento che il nostro partner trova altrove l'amore che prima gli davamo noi. Chi è in grado di tradire la persona di cui sa d'essere amato, è capace di fare qualsiasi cosa.
Naturalmente nulla è generalizzabile, e tanto più le considerazioni amorose, altrimenti molti non perderebbero tempo a tentare di rifarsi una vita, e vedrebbero nella canna del gas una più semplice e meno frustrante via d'uscita.
Ricordo che allora, poco prima dell'aborto, quando meditavo di lasciare Marta, bastava solo quel pensiero per rovinarmi la giornata, mettendomi in uno stato di assoluta ansietà. Volevo essere un mago, che con un colpo di bacchetta cancella tutto. Volevo non esser mai nato. Volevo che lei fosse come prima. Volevo lasciarla, ma anche reinnamorarmene. Volevo farla soffrire, ma pure curarla.
Queste contraddizioni non sono un fatto strano, perché vedete, nonostante tutta la Letteratura, per quante ragioni valide ci possano essere, abbandonare l'essere amato è sempre un atto di estremo coraggio. Non tanto nel voltare le spalle e andarsene, quanto poi nel ritrovare la strada, digerire i ricordi, la solitudine, la mancanza di fisicità, sopportare le tristezze, le malinconie, ed essere in grado, col tempo, di sostituirle. E' il “punto del non-ritorno”, un limite oltre il quale sappiamo che di là in avanti non ci aspetta altro che sofferenza.
Quello che in vita più ci preme è di entrare nelle grazie di quel personaggio che, a detta di tutti, rappresenta la personificazione, seppur momentanea, dell'importanza. Nel piccolo quotidiano di ciascuno di noi esiste una persona del genere. Può essere il Capo Ufficio, la ragazza che ci piace, o colui che può farci fare un salto di qualità nella nostra vita. Ma se qualcosa improvvisamente cambia (c'innamoriamo, perdiamo il posto di lavoro, traslochiamo in un'altra casa o in un'altra città, siamo vittime d'incidenti o perdiamo una persona cara), allora il nostro cervello è disposto a dimenticare il clima, le fattezze e gli atteggiamenti di quell'importanza così, in modo anonimo e naturale. Magari in attesa d'incarnarne un'altra.
A volte, più che la vita delle persone, è la manipolazione del nostro ricordo ad esserci fatale. Gli individui cadono sempre nell'errore d'idealizzare. E' uno sbaglio che si ripete ciclicamente, un circolo vizioso fatto di richiami memorizzati. Si ragiona a caselle, ci si affida all'inferenza; una voce, un individuo, una mentalità, una faccia, un nome. Un rumore una cosa, un posto, una situazione. Il problema è che il nostro cervello tende a rimuovere quanto di brutto abbiamo passato, e allora non restano che i momenti felici, che spesso e volentieri siamo stati noi, nelle nostre evocazioni manipolandoli, a far divenire tali. Nel far questo, però, resta nell’aria un pericolo; che la nostra volontà vada a stuzzicare la memoria in maniera sbagliata, così che le immagini che Ella ci riporta indietro non sono le desiderate, e le brutte figure che quell’oggi ricordiamo, ci fanno arrossire più di quanto non ci abbiano fatto arrossire il giorno stesso che ne fummo vittime.
Non è così male cadere preda di questo formulacro di considerazioni che, sebbene scontate, ci fanno ricrescere dentro quei punti fermi che plasmano la stima per noi stessi, perché se così non fosse molti di noi si farebbero vincere dal rancore e dalla rivalsa, e finirebbero per strangolare il loro ex partner, propinatore di quelle umiliazioni.
Per qualche tempo mi sentii improvvisamente vecchio. Mi scoprii a guardare le donne per strada, cosa che non era mia abitudine fare. Non le guardavo come avrebbe potuto fare un qualsiasi “affamato”, fantasticando sessualmente su di loro, ma giusto come può fare un anziano disilluso, convinto che siano il male che c'è sulla terra. Mi appostavo dietro la vetrina di un bar, seduto ad un bisunto tavolino, e da lì le spiavo. E nel vedere le loro teste voltarsi rincorrendo i posteriori di uomini eleganti e “costosi”, o le loro auto, o le loro dita asettiche d’impiegati bancari o agenti di Borsa, battevo le mani sulle gambe ridendo come un matto, per il ridicolo. O forse per l’invidia. Non lo saprò mai. Così le odiavo, per un istante, e se guardandole pensavo al sesso, mi ritrovavo, sadico, a frustarle e torturarle.
Ogni tanto, però, sentendo la mancanza dell'innamoramento, riprendevo ad amarle, e, proprio come gli anziani, avrei voluto sapere qualcuna di loro innamorata di me perché io, allora, potessi innamorarmi di lei. Come gli anziani, che vivendo il solo amore per loro possibile, l'amor senile, si trasformano in “fratelli intellettuali” (perché non hanno più possibilità fisiche e l'unico ruolo che godono rivestire con le donne è quello del Mentore), non badavo più di tanto alle facce, e la mia smania di rinvigorire gli affari di cuore che, ancora come gli anziani, avevo creduto spenti per sempre, mi avrebbe permesso d'innamorarmi di chiunque.
Fu allora che mi ritrovai ad essere combattuto da un sentimento contrastante; volevo ucciderle tutte, queste donne, queste maledette, o me ne volevo innamorare globalmente, come se fossero una squadra di Calcio o una corporazione? E Marta? Il mio amore per lei? Dovevo considerarla, dopo ciò che aveva fatto, una persona normale? Avevo provato, simulando una condizione fatta di contorni sfuocati, a perdonarla, ma la mia coscienza, scarsamente allenata al peggio, mi rimetteva continuamente davanti la sua faccia ghignante mentre mi diceva di aver abortito.
Sapevo che quel ghigno era solo superficialità o frutto di un istinto isterico, ma, seppur nei ricordi soltanto, non riuscivo a sopportarlo.
Nei giorni che seguirono il nostro distacco, quell'immagine fu per me, al tempo stesso, un'àncora che mi teneva ormeggiato al passato, al nostro amore appena finito, agli istanti belli vissuti assieme, e una specie di distributore di determinazione. Libertà e schiavitù, felicità e tristezza. Era la voglia di amare Marta e quella di disprezzarla. Era, nelle sue possenti apparizioni, uno di quei Sergenti che in trincea spronano i soldati a non temere il nemico poco prima di un assalto alla baionetta, o un pazzo pacifista, un disertore che saltando fuori dal camminamento va incontro al nemico urlando: “Vi voglio bene tutti, nemici miei!”
Quando il desiderio di perdonarla iniziava il suo ruffiano lavoro di convincimento sulla mia coscienza, a me bastava chiudere gli occhi ed evocare, in modo che sorgesse dall'angolino del cuore dove avevo accatastato odii e rancori, l'immagine della sua faccia, che tanto avevo amato, mentre pronunciava quelle fatidiche parole. Chissà, forse se non mi fosse importato nulla di lei sarei anche riuscito a perdonarla.
Talvolta pensavo di tornare con lei e di schiavizzarla, d'imporle rapporti sessuali contro natura e di picchiarla se solo avesse aperto bocca senza il mio permesso, ma quelle meditazioni erano vacue nuvolette che lasciavano il tempo che trovavano. Alla donna di cui siamo innamorati non saremmo in grado di torcere un capello.
Riuscire a dar sfogo alle proprie perversioni è il risultato di una lunga operazione che ha come obiettivo quello di trasformare le vittime, o le complici, di quelle nostre depravazioni in oggetti di estranee confidenze. Con le donne che amiamo questo ci riesce scarsamente. E non tanto perché elle non ci eccitano, quanto perché il nostro amore funziona da inibitore. Il nostro sentimento è un tubicino di scappamento dal quale evaporano tutti i nostri perversi desideri sessuali, così che quel “far all'amore con loro” diventa più un atto dissacratorio che una “partita doppia”.
Forse ha ragione il Professor Kafka, che riconduce la scarsità di serotonina nel fisico alla ragione principale per cui i maniaci sessuali sentono la spinta a stuprare le donne. Si sa che quando siamo innamorati la serotonina raggiunge livelli altissimi, per cui, secondo il succitato Professore, il nostro eccitamento sessuale ne risente.
Con gli occhi della memoria ogni tanto la riguardavo, la mia Marta, e la ritrovavo come l'archetipo della donna moderna tutta gambe e collant, tailleur e ventiquattrore, capelli e shampoo alle erbe, tette e Consigli d'Amministrazione. Una “finta potente”. Sì, “finta” perché ora capivo di averla avuta in pugno, seppur per un breve istante, di aver avuto il potere di prenderla o di rifiutarla, ciò che infine feci. Io non ero come lei, sapevo soffrire io, contestualizzando, senza dare le colpe ai movimenti, studenteschi o dinoccolati che fossero. Scoprii che quella presunta “potenza” che le avevo attribuito era anch'essa veicolo di vendetta, perché più la ricordavo “potente” sapendo di averla avuta in pugno, più godevo perché capivo di essere io stesso potente. Si sa, le vittorie non sono tutte uguali. C'è quella sul misero, un disgustoso approfittarsi, quella sul coniglio, che lascia l'amaro in bocca, e quella sul potente vero, che ci trasmette, rubandola a lui, un po' della sua potenza. Fu così che mi resi conto di essere diventato un uomo. Forse anche per colpa di Marta, ora la mia nemica.
Siamo sempre pronti a raffigurarci il dolore e la cattiveria col volto di chi ci ha fatto qualche carognata. Siamo talmente certi che la cattiveria sia lui, che solo il tempo può cambiare le sembianze di quel viso e restituirci l'essere astratto che prima d'incarnarlo ci eravamo sempre immaginati. Ora, per me quel nemico era Marta, il mio amore, per Marta era nostro figlio, vittima predestinata del suo conformismo. A nessuno dei due venne in mente che quel viso poteva anche essere del mondo.
Un giorno, insipiente, pensando affogato nella mia crisi esistenziale, capii che mi era rimasta solo una cosa da fare; staccare la spina. Prendermi un po' di tempo, per me, per rinfrancare il mio spirito, per uscire dall'inappetenza, per recuperare qualche speranza nella vita senza, tuttavia, perdere la mia amata disillusione e finire per diventare come uno dei tanti ingenui che ci capita d'incontrare sempre più spesso (con la vista occlusa da rosei paraocchi e un qualunquismo ottimista nutrito di superficialismo), secondo i quali il mondo in fondo possa essere un bel posto, che a tutto ci sia rimedio, che bisogna battersi per la pace, e che per questo crede nelle guerre umanitarie, meschinetto, che vede le nazioni come un insieme di armonia e di sicurezza. Volevo solo uscire dalla mia crisi esistenziale senza perdere la mia disillusione, mica diventare un deficiente! Non volevo mettermi a bere o, come fanno molti, abbandonare la mia casa e mettermi a viaggiare. Credo fosse Cèline che scrisse: “Il viaggio non è che una piccola vertigine per coglioni”.
Chissà, forse ha ragione lui e noi siamo davvero dei coglioni che ancora non l'hanno capito.
C'è chi parte per fuggire, e fa il “giro del mondo in ottanta giorni” per ritrovarsi poi allo stesso punto di partenza, con gli stessi problemi da risolvere e le stesse insofferenze. Purtroppo quel bagaglio di pochezza che siamo non si perde mai agli aeroporti o nelle stazioni. Pare abbia un'intelligenza propria, e nelle rotelle la velocità per riacchiapparci anche se andiamo a finire in Polinesia.
Qualsiasi cosa ha il suo contrappasso, comprese vanità e superficialità. Scappare dai problemi è scappare da sé stessi, e per quanto lunghe le nostre gambe possano essere, alla fine è sempre il corpo a cui sono attaccate che si porteranno dietro.
Sono quasi sicuro che la nostra vita sia su un'eterna bilancia. Una bilancia che tutto pesa e che tutto calcola, anche i comportamenti minimi, oltre alle tragedie, alle fortune, al caso e alla pianificazione o ciò che noi crediamo tale. In realtà ci è stata data da consumare una porzione, che è la nostra intera vita, e tutto quello che facciamo o che ci capita, sia esso bellissimo o doloroso, altro non è che parte di quella porzione. Possiamo prenderla per farne quel che vogliamo, darla da mangiare ai cani o usufruirne al massimo, ma non ci sarà dato altro che non sia di quella porzione. La vanità può essere parte integrante di quella porzione, e, come se ci fosse caduto un capello nel piatto, dobbiamo costantemente ricercarla e tirarla via, gettarla nella spazzatura.
Ma probabilmente un giorno scoprirò che anche la bilancia è una mia, una nostra invenzione. Non è improbabile che il contrappasso sia soltanto una scusante, e che il solo espediente per mettere le cose al loro posto sia unicamente la Morte.
Quante storie ho visto finire male per troppa vanità o per la presunzione di essere riusciti a celarla perfettamente, dove nessuno potesse vederla. In realtà è proprio la vanità stessa ad ostentarsi, a non perdere occasione per mettersi in mostra, e a tutto questo non c’è rimedio alcuno.
Se bene ci pensiamo, il tizio che vediamo nello specchio quasi mai siamo noi stessi. Il riflesso di uno specchio è l'unico caso conosciuto di ubiquità, così che guardandoci indossiamo sia i panni del-l'attore che quelli dello spettatore (che potrebbero anche essere quelli del fraudolento e della sua vittima, del peccatore e di chi ha subito il “surrettizio”, dell’assassino e dell’assassinato), e per pia-cerci siamo portati, quasi istintivamente, a recitare una parte che non abbiamo recitato mai, a trasformarci in un personaggio che calzi appieno i nostri gusti.
In verità stiamo solo tentando d’ingannare noi stessi.
E' davanti agli specchi che gli individui diventano ridicoli, perché per piacersi recitano dando il meglio di sé stessi ma vestendo vanitosamente abiti di scena che non gli somigliano per niente, e finiscono per caricaturare il vicino di casa, un personaggio televisivo o un amico. Un vanitoso, per piacersi davanti allo specchio, deve necessariamente abbandonare la sua personalità e indossar-ne un’altra, ed è in quell’esatto istante che sta tentando di eludere il contrappasso.
Ricordo che quando mi accadeva di vedere della vanità in individui che avevo ritenuto di un certo spessore, subito mi rimproveravo il fatto di essere caduto di nuovo in quella voglia di speranza, in quella voglia di fiducia dentro la quale cascano gli ingenui.
Allora mi rimproveravo la mia avventatezza nel giudicare gli individui. Ma a pensarci bene non era tanto colpa mia, quanto la diversità delle situazioni in cui li avevo, la prima volta, conosciuti e considerati, e, la seconda, rigettati. Allora rimanevo spaesato, smarrito, e mi chiedevo come potevo esser stato così ingenuo. Certo, la loro vanità non avrebbe dovuto interessarmi, ma sono sempre stato un tipo troppo sofferente, un moribondo con la voglia di guardare la Morte negli occhi solo un secondo, appena un secondo prima di morire, e avere quel secondo per allietarmi il cuore dicendo:
“Certo, era proprio lei, e io l'ho vista”.
Non ci si rimprovera mai abbastanza nella vita, datemi retta. Così, ogni volta, ci troviamo di fronte agli stessi sbagli e davanti alla stessa delusione, agli stessi sintomi che la delusione porta nel cuore. Stanchezza per la vita, rabbia, lacrime per troppa autocommiserazione, falso vigore e fin troppo vero rancore. Nulla ci sembra così naturale come odiare il mondo, ma sentiamo anche che quell'odio è la strada più breve per morire. Allora? Ti allontani da tutto e da tutti. Ti prepari, ricamando, un mondo alla tua portata, fatto su misura per te, dove nessuno può entrare e portar via. E' il solo modo per sentirsi vivi, vincitori, e, se capita, perfino uomini.
Qualche volta può anche venirti la spinta per ricominciare, per provare a rientrare nel mondo, nella società, ma capisci presto che per te non c'è rimedio, che il tuo posto non è in mezzo agli altri, o non completamente. Cerchi di cacciare questo sentore, vuoi sentirti un caso disperato. Sovente non ci riesci.
Così successe anche a me.
Cambiai casa, andai ad abitare a Monterosso, in paese. La mia casa era veramente lontano da tutti, confusa nei monti. Solo raramente andavo in città, a Genova, giusto quando non potevo farne a meno. Il fatto che mi fossi spostato a vivere in un paesino tranquillo mi rendeva agli occhi degli altri, amici, parenti, giornalisti, televisioni e fans, una specie di oggetto misterioso. In realtà la ragione per cui me n'ero andato era semplice. Di tanto in tanto, sotto casa mia, trovavo alcuni curiosi che si avvicinavano, mi squadravano da testa a piedi e, con l'aria di dire: “Tutto qua?”, allungavano un foglietto sul quale io scarabocchiavo una firma deprimente che li acconten-tava. Giusto così.
A Monterosso ho preso dimestichezza con la vita da casalingo, e mi sto convincendo che sia proprio questa a rivelarci la compatibilità che eventualmente possiamo avere con una donna. Quando si va d’accordo in camera da letto, in cucina e in bagno (l’igiene non è da trascurare), allora siamo a metà dell’opera. Se poi troviamo affinità anche nello studiolo, davvero abbiamo trovato la nostra scarpetta.
Un'altra cosa che m'incuriosisce di questo paesino è l'aspetto diffidente che le forze dell'ordine nutrono nei miei confronti. Non capisco come affrontano l'obbligatorietà di avere a che fare con me. Io ero famoso, ero un artista, e loro lo sanno, però sono considerato da Carabinieri e Polizia come uno di quegli artisti moderni tutto sesso, droga e rock 'n roll. Così, ogni volta che li incontro, li vedo combattuti se fermarmi per chiedermi i documenti e, con fare indagatore, cercare di capire quale sorta di personaggio sono, o, come normali cittadini, tentati dal chiedermi un autografo o snobbarmi. In quel paese, però, non è che ci sia molto da fare, quindi io sono diventato l'attrazione principale. Così esco il meno possibile, e quando lo faccio me ne vado, per non star fermo a farmi ammirare come una scimmia dentro una gabbia allo zoo, nei paesi vicini; Vernazza, Corniglia, Manarola eccetera.
Alle Cinque terre c'è una stradina che costeggia il mare e che unisce tutti i paesini. Spesso, con mia moglie, partiamo la mattina e andiamo a passeggiare in questo sentiero, in questa strada.
Abbiamo fatto amicizia con qualche persona, così succede che ci fermiamo in ognuno di questi paesini e le andiamo a trovare. A Vernazza abbiamo conosciuto due ragazze che sono proprietarie di un negozio nel quale si degustano vini locali. Sono simpatiche e sovente, nei nostri giri di perlustrazione, ci fermiamo da loro a farci qualche bicchiere di Sciacchetrà o di vino delle Cinque Terre. A Corniglia, non molto distante, poco più avanti, ho fatto la conoscenza del Capo Stazione che abita vicino a dove lavora. E' vedovo e ama il vino. Di tanto in tanto m’invita per una cena o per vedere la partita insieme. Ha sempre mille cose da raccontarmi e la sua parlata, cadenzata come quella di un anchor man, mi diverte parecchio.
Per come ero abituato in passato questo genere di vita non è granché, ma io cercavo proprio questo. Ero stanco delle confusioni, delle amicizie opportuniste e dei “partiti presi”. La vita “dell'artista” è tanto pregiudizievole che ti ritrovi ad aver a che fare sempre con la stessa gente perché ti convinci che gli altri, che non siano i tuoi amici, non possono essere interessanti e simpatici.
Soltanto raramente ripenso a Marta. Lei è lontana nei miei ricordi, lontana a tal punto che oggi ho perfino scordato la sua faccia. Mi va bene così. Il rancore sordo che le portavo si è quasi sopito del tutto, e solo pensando a ciò che poteva essere mio figlio ogni tanto riesco a destarlo. Ma è solo parvenza d'odio. Non l'ho mai perdonata, ma non sento di volergliene più di tanto. Mi piace pensarla con qualche bel giovanotto, con casa, auto, telefono cellulare a carico, e senza la costrizione di volerle bene. Qualche tempo fa mi sono convinto che fosse lei a rappresentare lo stereotipo di quella che si è fatta fregare dalla Tv. Il bisogno di protagonismo è uno dei mali del nostro secolo, più pericoloso della droga e di altri “vizi personali”, e lei ne era assolutamente assuefatta.
Chissà, oggi, con tutti quei programmi “in diretta” dove chiudono dieci persone in un unico ambiente e le spiano per mesi ventiquattrore al giorno, Marta potrebbe avere un bel palco-scenico su cui esibirsi.
Fu in uno dei tanti giorni seduto ad aspettare che la mia vita cambiò drasticamente. Non pensavo che la mia porzione mi serbasse qualcosa di nuovo, ed ero sul punto di considerarmi un uomo di poco conto che non avrebbe lasciato alcuna traccia visibile di sé stesso.
Anche questa volta fui smentito.
VI.
Un bel giorno venni a sapere, tramite posta, che eravamo in debito con la nostra casa discografica. Gli dovevamo un disco. Avevamo firmato un contratto per cinque dischi e ne avevamo fatto solo quattro. Erano diversi anni ormai che avevo smesso di suonare per il pubblico. La chitarra la tiravo fuori solo con gli amici del paese ed ero sempre risoluto a non voler rientrare nel mercato discografico. Questa faccenda era comunque da mettere a posto, se non altro per non pagar penale.
Telefonai ad Alessandro e lui fu d'accordo con me.
Quando il gruppo si era sciolto lui e Giacomo si erano messi insieme e avevano continuato a suonare, facendo qualche disco che aveva avuto anche un discreto successo. In pochi giorni rin-tracciammo anche Enzo, e ci accingemmo a comporre qualcosa di nuovo. Sostituimmo Maurizio con Massimo, un ottimo tastierista, ed iniziammo a provare. I primi tempi mi sentivo abbastanza legato nelle dita. Un conto è suonare in spiaggia per la tua fidanzata o per qualche amico, un altro è suonare insieme ad altre persone. Dopo la prima settimana fu abbastanza chiaro che non riuscivamo a cavare un ragno dal buco, e dopo esserci riuniti e averne parlato, decidemmo di abbandonare definitivamente quel progetto.
Dopo aver convocato Gagliardi e il Produttore Lopresti, dicemmo che non ci usciva niente di buono. Il Produttore, non dopo aver tentato più volte di farci cambiare idea, cedette ed accettò la nostra proposta di far uscire sul mercato una raccolta di pezzi vecchi più un brano inedito. Così uscì l'album che doveva sancire il nostro definitivo tramonto come gruppo rock.
Trovammo per questo disco un titolo originale e assai divertente, una specie di scioglilingua:
“Seghiri Munilaciu,
Gheramastumapasu del mistico Sole”
Era anche il titolo dell'unico pezzo nuovo che eravamo riusciti a comporre. Come al solito ero stato io a scriverne i testi. Era la storia di un uomo che avevo conosciuto a Vernazza in un pomeriggio d'Inverno, quando il mare mosso e il cielo grigio fanno riemergere i ricordi e ci fanno sentire più tetri e malinconici di quel che siamo.
Passeggiavo nei pressi del moletto quando si scatenò un acquazzone. Cominciai a correre cercando un riparo che mi proteggesse dalla furia della pioggia, e lo trovai in un'osteria lì vicino. Il locale era quasi completamente vuoto. Le sue travi scricchiolavano solo a guardarle, il pavimento era spaccato in più punti, e il bancone sembrava un suppellettile improvvisato, di quelli che i venditori ambulanti allestiscono nelle Fiere e nei mercati rionali.
Gli unici due abitanti erano il barista e padrone del lurido postaccio, e un vecchio che, di-scretamente defilato, occupava sgraziatamente un antico e sporco tavolo di legno. Aveva gli abiti sunti e consunti, con macchie evidenti sul davanti, e un paio di scarpe da marcia forzata dell’ARMIR. Il suo viso era da giovane vecchio, con la barba spettinata e i capelli che parevano essergli cascati in testa dal quinto piano di un palazzo. Aveva un portamento malandato, con spalle curve da becchino, ed emanava anche un discreto “odorino”.
Ordinai un bicchiere di vino caldo e mi adagiai su una sedia per aspettare la fine del Diluvio. Il vecchio, sebbene pareva non tener conto del nuovo arrivato, io, cercava di ammaliarmi con finto interesse. Sfogliava dei giornali laceri passandoli da una parte all'altra del tavolo. Anche lui, malgrado la sua condizione, aveva un fare vanitoso. Probabilmente era convinto che i suoi anni potevano per-mettergli d'essere saccente e di considerare, certo di conoscere il mondo, l'intera umanità molto più ignorante di lui. Si sa, ad una certa età si raggiungono consapevolezze che non s'avevano mai avute in precedenza. Almeno, nominalmente.
“Questi sono gli individui che mi fanno salire la voglia di rompere definitivamente col mondo”, pensai io. Mi sbagliavo.
- Permette una parola? - mi disse.
- Prego. - risposi io trattenendo uno sbuffo di noia.
- Mi chiedevo se poteva interessarle il mio lavoro. – continuò il vecchio.
Prese a raccontarmi una strana storia. Si occupava di pesca, ma nel tempo libero faceva anche dell'altro. Era appassionato di spiritismo e mi disse che molti di quei posti, alle Cinque Terre, erano infestati da fantasmi e da spiriti. Mi disse anche che quando la pesca non riusciva a mantenerlo in vita faceva un lavoro nuovo e originale; vendeva quotidiani di seconda mano. Quei giornali erano vecchi e portavano notizie datate che, in certi casi, potevano anche avere venti-trentanni.
- Lei non si rende conto di quanto interessanti possano essere le notizie rilette a distanza di qualche anno. – disse - Certe sono rimaste avvolte nel mistero, altre, anche se palesate da indagini e completate da finali, agghiaccianti o lieti che siano, conservano quella grazia e quell'interesse propri dei romanzi d'appendice. Non gli è mai capitato di rileggere una notizia alla luce della conclusione che ha avuto la vicenda? Le assicuro che può essere divertente e molto istruttivo. Come può essere istruttivo rivedere l'andamento della Borsa e dell'Economia di qualche anno fa, quando gli Imprenditori erano seri e non avevano ancora partorito i figli che oggi vogliono dominarci spocchiosamente, e che sono portati a confondere i loro interessi con quelli generali. E poi le polemiche sportive. Che spasso! Si parlava già di doping, e oggi ancora non sono riusciti a metterlo sotto controllo. Qualche dubbio ti viene. Io mi diverto coi Necrologi e le pubblicità. Ogni tanto mi accorgo che le pagine parlano. Ci dicono che il fatto di essere consunte può essere messo in relazione con chi li ha letti. Spesso ci trovo appunti scritti a penna, e gli annunci sottolineati possono suggerirci quale tipo di persona aveva comprato il giornale e perché, se per cercare lavoro, casa o qualche oggetto di seconda mano. A volte riesco ad estrapolare anche i gusti sessuali di chi ha consultato i “matrimoniali”.
Restammo a parlare per ore e ore facendo discorsi di ogni tipo; spiritismo, religione, politica, vita, era una specie di “tuttologo”.
Quando si alzò per uscire mi accorsi che zoppicava ed era giù di peso. Lo accompagnai alla porta e vidi che il tempo si era rimesso, anzi, c'era un sole fortissimo e un caldo da Agosto fiorentino.
Quella fu la prima e l'ultima volta che lo vidi. A quanto pare non aveva mai abitato in quel paese né in altri vicino. Spesso pensai che forse mi ero imbattuto in un fantasma, dal momento che soltanto pochi giorni dopo il padrone dell'osteria non si ricordava né di me né di lui. Più vero-similmente era soltanto un mistificatore, il classico cacciaballe.
L'unica cosa che è rimasta di quell'incontro è questo testo che ho scritto per la mia probabile ultima canzone. Quando tornai a casa, nel mio paesino, riconobbi che quella vita non faceva più per me. La musica mi aveva dato tanto, è vero, ma mi aveva anche privato della mia vita, del mio modo di concepire la vita. Ero rimasto in letargo per parecchi anni senza rendermene conto. Non ch'io ora disprezzi la musica in quanto tale, ma piuttosto m'infastidisce la concezione che di lei ha il mondo, quello dei giovani ma anche quello di certi adulti.
Fu allora che iniziai a scrivere non più per la musica ma per me stesso. Scrivevo dei romanzi che mi permettevano di occuparmi la giornata. Non avevo velleità artistiche letterarie, non me ne fregava niente di entrare a far parte di un altro tipo di mercato artistico, fatto solo per vendere le facce, non certo per arricchire i cuori. Scrivevo così, per dar corpo ai miei pensieri.
Fu per questo mio nuovo interesse d'idolatra letterario che conobbi Francesca. Lei, come me, amava leggere, e fu proprio in una libreria che feci la sua conoscenza. Ormai non mi aspettavo più nulla dalla vita, e tantomeno che lei avesse in serbo per me qualcosa di molto simile all'amore. Ero riuscito a diventare ciò che avevo sempre aspirato essere; un disilluso.
Francesca dunque. Anche lei aveva l'aria della studentessa fuori corso. Biondina, occhialini, sguardo ingenuamente azzurro, nasino all'insù stupendo, belle gambe da donna adulta malgrado non lo fosse, gonna stretta appena sopra al ginocchio, camicetta bianca con piccoli bottoncini color perla, nessun interesse per ciò che le girava attorno, e movenze da piccola liceale in vacanza. Ma quest'ultime sembravano non appartenerle. La sua parlata, da quanto era “accennata”, abbozza-ta, pareva presa a nolo, e che lei avrebbe dovuto restituirla fra breve.
Subito caddi nella mania di giudicar le persone e pensai: “Questa non è padrona neanche di diri-gere il suo passo”.
Mi sbagliavo ancora. Era soltanto la solita ragazza semplice che aveva la solita vanità di farsi guardare, che probabilmente aveva fatto, e forse ancora faceva, la spesa a sua madre, che andava in centro, per vetrine di negozi, che credeva di avere visioni assolute delle cose e la convinzione necessaria per confondere la Psicoanalisi col “Vangelo secondo Freud”.
Francesca somigliava al mondo.
Io ero in quel periodo in cui, convinto e persuaso dall'idea di bastarmi, non ricercavo alcun tipo di compagnia. Le mie voglie erano altre. Le donne mi piacevano ancora, ma non credevo nella loro duttilità, e nemmeno nel bisogno che di loro il mio corpo, ogni tanto, reclamava. Si sa, ci si abitua a tutto, perfino all'astinenza sessuale. Sono certo che se non fossero esistite in quel periodo non me ne sarei neanche accorto.
La conobbi in quella libreria e la rividi la sera stessa. Francesca era una donna curiosa. Quella sera, dopo aver mangiato e bevuto, ci dilungammo in chiacchiere, fino a che, verso le undici, lei saltò su e disse che doveva scappar via.
- E perché? - chiesi io - Non è mica così tardi!
La gelosia è un violino tzigano che suona note dissonanti richiamate direttamente dall'Inferno, e che su noi, sebbene ne sappiamo la provenienza, hanno un effetto incantatore che ci travolge, e non è tanto raro, guardando la donna che non amiamo più mentre bacia il suo nuovo uomo, esser scossi da quella gelosia melodiosa che ha la potenza di farci innamorare di lei. Magari per la prima volta. Lo troveremmo strano, allora, e forse ci rammaricheremmo di non essere riusciti ad amarla come meritava.
- Lo so, ma non vado a casa. - rispose lei.
- E dove vai, allora?
- In un posto speciale. Puoi venire anche tu se vuoi. Vado al “Picco”, a vedere i treni che passano.
Quella sera ripresi a guardare la vita con l'animo del mondo. Certo, con frivolezza, con poco realismo e con la convinzione che, volutamente distratti, in fondo si possa anche vivere bene. La semplicità di Francesca m'insegnò a non dar troppo peso a quel genere di situazioni e di comportamenti che si vedono in giro. Imparai a non fissarmi sulle altrui vanità, su egoismi e presunzioni, e trovai quel distacco necessario per sopravvivere senza martoriarmi il cuore.
IN SILENZIO
Quel che ci sembra l'apoteosi della felicità, il preludio al paradiso, può in un'attimo cambiare per diventare severo, tirannico, persecutore. La vita non si farà mai apprezzare come dono divino fino a quando non saremo noi, rifiutandola lasciandoci socialmente morire, a metterle addosso la frenesia di riconquistarci. E ciò che fino ad allora ce l'aveva con noi, era tignosa, sorda alle suppliche, aveva spocchia da vendere, la vita, ecco che diventa una tenera bimba, ci tira per la giacca, c'invita a giocare con lei, ci promette mille fedeltà come un'innamorata pazza. Ma pare che poi nessuno l'abbia vista mai, quest'innamorata pazza. E' vero, poco ce ne importa. Anche se le sue promesse non vengono mai mantenute, sembra che il solo fatto che ce le abbia fatte ci basti. Così ci facciamo convincere da lei. Così ci facciamo comprare come per quattro soldi si fanno cor-rompere i traditori. Così ci facciamo battere e riconquistare dal suo sinistro fascino. Sconfitti ci facciamo strappare, senza reagire in alcun modo, al nostro piccolo rifugio fatto di sogni e di ricordi.
E' in questo modo che si diventa “alienati mentali”.
Iniziamo a rifiutare tutto, il dolore è troppo grande, ad isolarci, perché sebbene vinti, sia dentro che fuori, siamo orgogliosi, e non vogliamo che il nostro cervello e la pubblica opinione ci conside-rino complici di quella che ora riteniamo essere “la nostra perduta vita”.
Sì, perché la nostra vita, e tanto più la nostra vita amorosa, è un cumulo di grano che si presta ad essere trebbiato, e il nostro successo consiste in gran parte nella capacità di convivere con l’eterogenesi dei fini, la nostra, quella interiore, e l’eterogenesi altrui. La compatibilità di una coppia, il loro successo amoroso, dipende esclusivamente da tale capacità di adattamento. Sap-piamo vivere con una donna quando lei non c’impone il suo pacchetto di diversità, e quando noi riusciamo a sopravvivere al nostro.
Non è un lavoro facile, questo, perché molto spesso ci succede di partire per raggiungere un luogo e invece ci ritroviamo in un altro. La delusione allora ci può conquistare, e l’amarezza segnarci in modo determinante la vita. La sola cosa che ci salva è la forza di sorriderne. Solo così riusciamo a sopravvivere alla delusione di un obiettivo mancato.
Non avevo più pensato alla possibilità di farmi una vita normale, con moglie, figli, casa e beghe famigliari. Non ho problemi econo-mici e quindi neppure la necessità di lavorare. Sposai Francesca e continuammo a vivere alle Cinque Terre. Il passato non influisce più di tanto sul tempo che mi resta da vivere. Ogni tanto suono la chitarra, quasi sempre per gli amici del paese, ma più che altro scrivo. Scrivere mi diverte parecchio.
Gli sfoggi di vanità non m'infastidiscono più tanto. Ho imparato a non farmi toccare da certi atteggiamenti, anche se non ne posso essere sicuro fino in fondo (perché Monterosso è un piccolo paesino), credo di essere “guarito” dalla mia sofferenza. Oggi, quando ricordo le serate al locale, sorrido e tiro avanti.
Qualche volta mi capita di pensare a Marta e al bambino, e quei ricordi non sembrano bruciarmi troppo. Arrivano così, in silenzio, e sempre in silenzio se ne vanno. L'unica cosa che sono in grado di causarmi è una leggera e vaga pena, che non trovando posto nel mio cuore, va subito ad angosciare qualcun altro in qualche altra parte del pianeta.
Con Francesca usciamo spesso, anche senza scopo. Ci divertiamo a girare per i monti a strapiombo sul mare. Ci piace entrare a far parte di un paesaggio, come quello ligure, unico nel sul genere. In Francesca adoro la discrezione, il suo presentarsi a me senza chiedere nulla in cambio. Sovente penso che la mia sola presenza le basti. Lei è in grado di appagare tutti i miei pruriti cardiaci e io non le chiedo altro che non sia questo lasciarsi amare così, sempli-cemente, senza particolari bramosie. Lei sembra averlo capito.
Dopo non molto tempo che stavo con lei sentivo che qualcosa ancora mi mancava, anche se non ci facevo troppo caso. Finché un giorno Francesca entrò in casa e disse:
- Aspetto un bambino.
Il silenzio che riempì l'appartamento dopo quell'affermazione era la vera colonna sonora della mia vita. Rimembrante cercai di buttar fuori tutta la felicità di cui ero capace per far sentire a Francesca che non era sola, che quel figlio lo avremmo condiviso.
Chissà, forse Maurizio, mio figlio, è proprio quel bambino che ritorna.
Ho paura di credere che questa sia la felicità, non ci sono mai stato granché abituato. Quel che faccio è cercare di vivere appieno tutto ciò che arriva, e sforzarmi di sentirne il gusto. Forse solo così riuscirò a convincermi che finalmente un po’ di gioia è toccata pure a me, anche se non dimenticherò mai la prima volta che vidi Marta.
fine




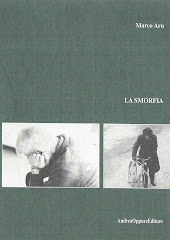


1 commento:
Riduzione per prestiti veloci e finanziamenti tra
in particolare, come promotore del Vangelo di Dio nel tuo vicinato
il prestito viene effettuato tra 3.000 e 800.000 con un tasso di interesse del 2%
Per maggiori informazioni:
mickaelducobet@gmail.com
Posta un commento